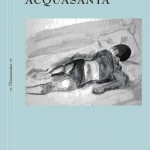 ROMA – ChronicaLibri ha incontrato Barbara Ottaviani, autrice di “Acquasanta”. Ci siamo viste in un book bar dalle tonalità femminili, una location perfetta per conoscere meglio una donna forte, decisa e consapevole del proprio bisogno di scrittura.
ROMA – ChronicaLibri ha incontrato Barbara Ottaviani, autrice di “Acquasanta”. Ci siamo viste in un book bar dalle tonalità femminili, una location perfetta per conoscere meglio una donna forte, decisa e consapevole del proprio bisogno di scrittura.
Barbara Ottaviani, un medico che decide di scrivere un romanzo?
Non è proprio così. L’anima di medico vive con quella intimista della scrittrice forte in me da sempre, anche da prima de “I cortoracconti di Sonja”, la mia prima esperienza letteraria edita da Navarra editore nel 2006. Sono innamorata delle persone e dell’idea di prendermene cura in senso generale; lo esprimo attraverso la medicina per una parte della giornata e attraverso la scrittura per l’altra.
In “Acquasanta” ho percepito una scrittura che voleva affermare la propria sensibilità nonostante il pragmatismo di tutti i giorni, un amore che venisse fuori dalle pagine come risposta al distacco professionale. E’ così? Barbara Ottaviani attraverso “Acquasanta” esprime la sensibilità che nella vita di tutti i giorni deve mettere da parte?
Sì, se mi ci soffermo a pensare, sento di dare, nei miei racconti, molto respiro alla parte sensibile a discapito di quella pragmatica. Mentre quando sono in ospedale, sebbene di partenza dosi in modo equo razionalità e sensibilità, riconosco, alcune volte, di dover sacrificare un po’ la sensibilità per lasciare più spazio al pragmatismo, alla determinazione, che nel mio lavoro di medico devo avere. Sicuramente la scrittura mi bilancia in senso umano, ma trovo la mia definizione nell’essere un medico-scrittore o uno scrittore-medico.
“Acquasanta” è un romanzo che ha la caratteristica di poter estrarre qualsiasi capitolo e trattarlo separatamente come entità autosufficiente. E’ solo una mia impressione?
No, affatto e sono felice che arrivi al lettore. All’inizio non volevo scrivere un romanzo, quindi scrivevo dei pensieri, dei micro mondi, definendo però dei punti di contatto tra di loro. . Sentivo il bisogno di mettere su carta le emozioni, poi, lentamente, come il fluire di un suono o di un odore, la storia ha preso la sua strada esercitando il suo potere catartico su ogni cosa toccasse. Questa è la scrittura, una forza catartica, che nel momento stesso in cui si manifesta e ti cambia, lenisce il tuo dolore per il cambiamento e si prende cura del tuo bisogno di sicurezza. Posso affermare che “Acquasanta” è andato scrivendosi.
No, affatto e sono felice che arrivi al lettore. All’inizio non volevo scrivere un romanzo, quindi scrivevo dei pensieri, dei micro mondi, definendo però dei punti di contatto tra di loro. . Sentivo il bisogno di mettere su carta le emozioni, poi, lentamente, come il fluire di un suono o di un odore, la storia ha preso la sua strada esercitando il suo potere catartico su ogni cosa toccasse. Questa è la scrittura, una forza catartica, che nel momento stesso in cui si manifesta e ti cambia, lenisce il tuo dolore per il cambiamento e si prende cura del tuo bisogno di sicurezza. Posso affermare che “Acquasanta” è andato scrivendosi.
 Un processo del genere, però, immagino impieghi molto tempo. Quanto è durata la gestazione di “Acquasanta”?
Un processo del genere, però, immagino impieghi molto tempo. Quanto è durata la gestazione di “Acquasanta”?Poco e tanto. Poco perché i pezzi che compongono il romanzo sono stati scritti di getto, quasi insieme, e in meno di un paio di mesi in tutto. Il tempo lungo è stato quello di trasformazione per rendere tanti pezzi un unico corpo. Senza considerare la mia anima di perfezionista: “Acquasanta” è stato un desiderio da limare e modificare continuamente; tagliavo, tagliavo, cercavo la parola giusta, e poi ancora tagliavo. Volevo che restasse solo l’essenziale. Rileggendolo ora taglierei ancora altro, però mi dicono che è meglio che non lo rilegga più, altrimenti resta solo un aforisma.
La protagonista del tuo romanzo è un’infermiera che si lascia coinvolgere nella storia di una bambina in coma. Come mai questa scelta?
Uno dei primi pezzi che ho sentito il bisogno di scrivere riguardava il diario di una bambina. In quel periodo mi capitava spesso di leggere romanzi o storie in cui i bambini che parlavano si esprimevano attraverso una linguistica e una forma mentis da adulto e lo trovavo molto incoerente. Quindi ho pensato di riscattare un po’ questo mio bisogno di leggere delle parole bambine, scrivendo un diario. Poi, come si diceva prima, la scrittura ha preso il sopravvento, e sono comparsi dei pezzi in cui c’era questa donna, che bambina non era stata mai; nel lavoro di unificazione dei pezzi non ho fatto altro che farle conoscere, il resto è venuto da sé. La scelta di non far parlare la bambina se non attraverso l’indagine della donna rappresentava la sublimazione della ricerca e, secondo me, l’anima dell’indagine emotiva: non ci si conosce se c’è qualcuno che ci da già tutte le risposte. Rintracciando le briciole di pane che la bimba ha seminato lungo il suo cammino, la protagonista ritrova sé stessa.
Perché i personaggi di questo romanzo sono descritti minuziosamente ma non hanno nomi?
I nomi non ti permettono di fare completamente tua un’immagine. La madre è madre per chiunque, la bimba potrebbe essere la figlia della tua vicina di casa o tua figlia, il vecchio, affascinante e oscuro, potrebbe essere l’Uomo che esiste nella vita di ognuno di noi.
Ecco, appunto, il vecchio! Guida e amico della bambina, per il quale la protagonista prova subito una forte e strana attrazione, non ha un nome ma viene reso riconoscibile da una descrizione molto attenta del suo odore. Facci capire meglio, per te il vecchio che odore ha?
Un odore rassicurante, carismatico, molto riconoscibile, familiare. Ha un odore di casa.
Scrivi: “Ho pure spiegato le scapole, rudimentale abbozzo d’ali con le quali prima o poi spiccherò il volo”. Come è nata questa immagine?
Un giorno la mia massaggiatrice Mari mi ha letteralmente afferrato le scapole e ha provato a tenderle al limite come a volerle spiegare. A quel punto, mi è come parso che stesse estraendo le mie ali, ecco è stato allora che ho deciso di scrivere delle ali in fieri, della frustrazione che ci consuma già dal ventre materno quando le ali si trasformano in scapole “come a ricordarci che ce la dobbiamo guadagnare la possibilità di volare”! Mi piace cercare nuove dimensioni dell’anima nel corpo, così come nella mente.
Le tre parole che preferisci?
Non ho parole che preferisco, ma preferisco di massima le parole che mi colpiscono, e cambiano di volta in volta, di contesto in contesto. E’ come nella vita, se non c’è qualcosa che mi colpisce in modo particolare non so decidermi sulle scelte da fare.
(foto di Studio Kiribiri)





