 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Quanto tempo si può trascorrere all’inferno? Jean Genet ce ne trascorse quattro, il 19 settembre 1982; e l’inferno fu il carnaio di Chatila; soltanto un paio di giorni prima, tra il 17 e il 18, i miliziani cristiani, fedeli al presidente libanese Gemayel, per vendicare la morte del loro capo, fecero irruzione a Sabra e Chatila, i due campi profughi palestinesi a Beirut Ovest. Jenet fu il primo occidentale a entrare e le sue “Quattro ore a Chatila” (Stampa Alternativa, 2002) diventarono un inno alla contestazione della violenza inspiegabile, del cieco furore che colpisce senza ragione. “Qui, tra le rovine di Chatila, non c’è più niente” racconta Genet: non c’è più niente di vivo, tra le rovine di Chatila. C’è tanta morte, però; tante istantanee pazzesche e inspiegabili: “Da un muro all’altro di una via, curvi o inarcati, i piedi contro un muro e la testa appoggiata all’altro, i cadaveri neri e gonfi, che dovevo scavalcare, erano tutti di palestinesi o libanesi”. Gli israeliani erano fuori: avevano chiuso i campi, avevano collocati posti di osservazione sui tetti, ufficialmente per proteggere i profughi palestinesi dalle violenze dei libanesi, ma non mossero un dito di fronte all’invasione delle milizie cristiano-falangiste: “Il massacro di Chatila si è compiuto nel brusio o nel silenzio totale, se gli israeliani, soldati e ufficiali, sostengono di non aver sentito nulla, di non aver dubitato di niente mentre occupavano questo edificio?”. Anzi; alcuni li accusarono di aver fatto luce sul campo, per facilitare la violenza degli invasori, girando la faccia dall’altra parte per fare finta di non vedere: “Al bagliore dei razzi rischiaranti israeliani, ogni orecchio israeliano, da giovedì sera, ascoltava Chatila”.
I cadaveri, a Chatila, erano muti, le bocce piene di terra, gli occhi vuoti di cielo: “La donna palestinese era probabilmente vecchia, perché aveva i capelli grigi. Stesa sul dorso, posata o abbandonata sui sampietrini, mattoni, sbarre di ferro ritorte, senza cura. Il volto nero e gonfio, rivolto verso il cielo, una bocca aperta, nera di mosche, con denti che mi sembravano bianchissimi, volto che, senza che un muscolo si muovesse, sembrava sia accigliarsi, sia sorridere o gridare di un grido silenzioso e ininterrotto”. Le immagini che testimoniano la carneficina sono agghiaccianti, incomprensibili nella loro ferocia, ma non riescono a dare il giusto peso della realtà: “La fotografia non coglie le mosche, né l’odore bianco e greve della morte. Non racconta il salto che si deve fare quando si passa da un cadavere all’altro”. Non c’è neppure nulla che, in luoghi del genere, dovrebbe essere naturale: “Ciò che mancava, in quel luogo, me ne sono accorto allora, era la scansione delle preghiere”. Chi pregare, in quella situazione? A chi rivolgere parole di supplica e di pietà? Nella violenza si perde la misura, si smarrisce il storia, si snatura l’essenza: “La solitudine dei morti, nel campo di Chatila, era ancora più tangibile perché avevano gesti e pose di cui non erano responsabili. Morti non importa come. Morti abbandonati”. Perché a Sabra e a Chatila non sono morti soltanto i profughi palestinesi, ma siamo morti tutti, responsabili morali delle violenze: “L’odore della morte non veniva né da una casa né da un suppliziato: sembrava uscire dal mio corpo, dal mio essere”.
Ma i morti, grazie alla testimonianza, sanno anche parlare: la loro presenza pesa e significa: “Un bimbo morto, a volte, può bloccare le strade, che sono così strette, quasi sottili e i morti sono così tanti”. Genet si schiera dalla parte dei palestinesi, per lui privati di una terra e costretti a difendersi dall’assalto degli invasori: “La lotta per una terra può riempire una vita molto intensa, ma breve”. Ma la questione è ben più complicata: e l’inferno di Sabra e Chatila dolorosamente lo conferma: “Sono dovuto andare a Chatila per percepire l’oscenità dell’amore e l’oscenità della morte”.
Autore: Giulio Gasperini
La natura enigmatica e l’insondabile uomo.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
ROMA – Più enigmatico di Bashō e, in un certo senso, più metafisico fu Buson. Nelle sue “Poesie” (Acquaviva, 2004) gli eventi naturali, gli scorci e gli spaccati di spontaneità colta, non sono così chiari, non son soggetti a una facile lettura. Ogni volta paiono caricarsi di valori altri, più oscuri e profondi di quanto non potrebbero accidentalmente parere: “La tenebra è così fonda / che si può persino sentire la neve / sfaldarsi”. In questa cornice, l’uomo diventa anch’esso più enigmatico e problematico, mai chiaro né semplice da risolvere e la natura finisce per diventare un mero espediente, privandosi della sua carica propulsiva: “Mi diverto a dipingere / un ventaglio da niente / con la linfa dell’erba”. Ma la natura sa essere anche protagonista, in un doppio ruolo che in Buson si fa addirittura stridente, per l’ampio potere di cui è dotata; la natura, infatti, sa anche nobilitare e soggiogare coi suoi incantesimi irresistibili: “Che luna meravigliosa, / il ladro si ferma / e canta”. È una natura che sa tracimare, che sa invadere tutti gli ambiti dell’uomo, regalando la sua magia dovunque, comunque, a chiunque: “Le rondini, / sotto le grondaie dei castelli, / sotto i tetti dei tuguri”. Sa persino la natura, in qualche caso, costituirsi panteismo inscindibile: “Pioggia d’autunno, / anche l’anima dell’uomo / se ne diventa una goccia d’acqua”.
Buson fu pittore eccellente e la continua e multipla sollecitazione sensoriale si fa evidente nei suoi haiku, che si materializzano come leste pennellate di colore, di corposa tinta: “Cadono i fiori di ciliegio / sulle acque delle risaie, / stelle in una notte senza luna”. Gli attimi si cristallizzano con una potenza sensoriale che forse mai prima di lui in queste schegge di componimenti era stata raggiunta: “Vento di primavera, / gli alberi di pesco / fremono di gemme”. Qualche astrattismo (“Il pesco d’inverno, / sembra uno spettro / arrabbiato”) e surrealismo (“Vorrei avere in mano / una farfalla, / come in un sogno”) poetico e pittorico anima la sua visione della natura e del mondo, in un connubio artistico che in lui manifesta pienamente i possibili punti di tangenza. Il viaggio anche per Buson è una condizione d’esistenza imprescindibile, irrinunciabile, che si può caricare di valenze complesse, fin anche opposte: “Guardo il fiume d’estate, / con i sandali in mano / son felice”.
Più dolente la poesie di Buson, più consapevolezza del tempo che passa e che passando priva l’uomo di opportunità, confinandolo nelle effimere consolazioni della memoria e del ricordo: “Ieri è già andato / oggi se ne va, / s’incammina via pure la primavera”. Più dolente la nota della solitudine, che si connota di riflessi quasi amari, come di un abbandono che non sia ricercato ma imposto, soprattutto quando si ricordano i vecchi affetti trascorsi: “Nella mia camera / calpesto il pettine che fu una volta / di mia moglie, un morso affonda nella mia carne”. E mentre l’attesa si fa vana, il rimpianto può avvelenare l’animo: “Sento lontano i rumori dei passi / sulle foglie morte / di chi sto aspettando”.
Quando l’arte è espressione dei bisogni della società
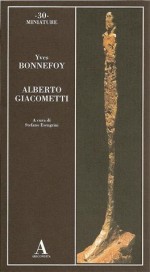 Michael Dialley
Michael Dialley
AOSTA – Ci sono tantissimi stili e movimenti artistici nella storia dell’arte. Si è sempre incasellato tutto in rigidi schemi, non chiedendosi, però, se sia davvero giusto definire un’opera d’arte, un artista, a seconda delle somiglianze e dei contributi di un movimento culturale. Può valere, questo, per alcuni artisti, soprattutto se molto legati a circoli culturali; ma per alcuni non si può fare, basti pensare a Rubens, a Caravaggio, a Mirò. E anche ad Alberto Giacometti. Originario della Svizzera italiana, nato nel 1901, Giacometti ha una concezione dell’arte che deriva solamente dalla sua visione del mondo, da come concepisce la realtà nella quale vive.
Ives Bonnefoy ci fa conoscere l’uomo-artista Giacometti grazie al saggio “Alberto Giacometti”, edito da Abscondita nel 2004, nel quale si può toccare con mano quanto la produzione artistica dell’artista sia profondamente legata ed influenzata dalla sua visione del mondo.
Si ripercorre tutta la vita dell’artista svizzero, toccando gli episodi della sua quotidianità, dai primi studi all’Accademia di Ginevra, all’adesione al gruppo surrealista della Parigi degli anni ’20, arrivando poi alla sua produzione matura, quando raggiunge una maggiore consapevolezza di sé stesso e della propria arte.
Quello che emerge è il ritratto di un artista profondamente angosciato, che si preoccupa di voler concretare la presenza, la vita in quanto essenza, che abita il corpo umano; argomento, questo, che attirerà nel suo piccolo atelier parigino molti intellettuali e letterati, tra i quali Sartre, non a caso il più grande esponente dell’esistenzialismo.
A Giacometti non interessa la figura da un punto di vista estetico, della forma, bensì vuole dare alle sue sculture la vita che alberga in ogni uomo. Per raggiungere questo obiettivo inizia rappresentando dal vero le figure che incontra; a un certo punto, però, le immagini gli appaiono distorte e utilizza la memoria, ricorda ciò che ha visto nella sua infanzia, nella sua adolescenza, avvicinandosi, così, alla componente più irrazionale e istintiva propria del circolo surrealista. Questo non è che una tappa, che porta l’artista a realizzare l’inafferrabilità della sua arte.
Ecco che inizia il suo grande lavoro, interiore ed artistico, di comprensione della vita, della condizione umana, della componente esistenziale: osserva il viso, lo sguardo delle persone, l’unico elemento che meglio di tutti coglie l’interiorità, l’intimità più profonda di ogni uomo. E, una volta trovato il punto focale, l’uomo cammina, procede, avanza, ma verso che cosa? Questo Giacometti non lo esprime, lui semplicemente vede l’uomo che va sempre oltre, che cerca sempre qualcosa, che nonostante le due grandi Guerre mondiali è riuscito ad andare avanti, a rialzarsi.
Questo ciò che ci racconta Bonnefoy e che raccontano, in maniera straordinaria, anche i due racconti scritti da Giacometti stesso, che sono riportati in appendice al saggio, “Il sogno, lo Sphinx e la morte di T.” e “Lettera a Pierre Matisse”.
Un artista da conoscere, che ci comunica qualcosa, che ci pone delle domande grazie alle sue opere, ma che non ci dà risposte, ma che anzi, invita ognuno di noi a giungere alle proprie conclusioni, in quanto crede che ognuno, dentro di sé, abbia le risposte o le potenzialità per trovarle.
Ascoltate quel che le vagine dicono!
AOSTA – Anche se si frequentan poco, o per nulla, bisognerebbe sempre conoscere quel che dicono le vagine. In definitiva, perché tutti veniamo da costì, da quell’antro da sibilla. E perché, inoltre, le vagine son una cosa seria, che ha a che vedere con la femminilità, l’integrità della donna: un mondo, in definitiva, potente e saturo di significato; sia per le donna ma anche per gli uomini. E perché, ancora, la violazione della vagina è uno dei crimini più atroci e terrificanti, in una sopraffazione dove non c’è amore, ma solo violenza: e una violenza non è mai giustificabile. Né, a mio parere, perdonabile. Eve Ensler cominciò a raccontare questi “Monologhi della vagina” sul palcoscenico di un minuscolo teatro di New York: era il 1996 e a quei tempi parlare di vagine e di donne alle prese con il loro sesso non era certamente usuale, né facile. La Ensler aveva scritto questa pièce teatrale basandosi su alcune interviste rilasciate da donne di ogni età, di ogni etnia, di vissuti estremamente diversi e distanti. Sono donne che si scoprono, per la prima volta, magari in tarda età; sono donne che parlano della loro esperienza di violazione, delle loro pretese mai soddisfatte, del loro desiderio di essere felici senza rinunciare alla loro femminilità più pura, più istintiva. Sono donne che osano pronunciare la parola, “vagina”: perché è la parola che dà carne, che crea materialità, “è la parola che ci spinge avanti e ci rende libere”.
 Eve Ensler ha dimostrato l’importanza e la potenza dell’arte: dai primi “Monologhi della vagina” si è sviluppato un movimento mondiale, il V-Day, che ogni anno viene celebrato in ogni angolo di mondo, anche in quei lembi di terra che son considerati più arretrati: proprio lì dove, in effetti, ci sarebbe più bisogno di ascoltarle, le vagine, e di seguire il loro volere. “L’arte ha reso l’attivismo più creativo e audace, l’attivismo ha reso l’arte più mirata, più concreta, più pericolosa” ha scritto Eve Ensler. L’arte si è dimostrata in grado di poter svolgere un ruolo da protagonista in campo sociale; ha il potere di cambiare la cultura, perché è la cultura che deve cambiare, “le credenze, la storia e il comportamento che stanno alla base della cultura” devono cambiare, perché “non abbiamo ancora svelato o decostruito i fondamenti cultuali e le cause della violenza”; l’arte ha il potere di far conoscere e, facendo conoscere, ha il potere di far maturare le coscienze. Ecco, allora, gli strazianti monologhi delle donne di Bosnia, rinchiuse nei “campi di stupro” durante la guerra in Jugoslavia, e quelle di Ciudad Juarez, in Messico, dove ogni anno decine di donne spariscono e vengono ritrovate nel deserto, stuprate, coi seni tagliati, violate in ogni aspetto della loro femminilità: perché “ovunque succedono cose terribili alle vagine”.
Eve Ensler ha dimostrato l’importanza e la potenza dell’arte: dai primi “Monologhi della vagina” si è sviluppato un movimento mondiale, il V-Day, che ogni anno viene celebrato in ogni angolo di mondo, anche in quei lembi di terra che son considerati più arretrati: proprio lì dove, in effetti, ci sarebbe più bisogno di ascoltarle, le vagine, e di seguire il loro volere. “L’arte ha reso l’attivismo più creativo e audace, l’attivismo ha reso l’arte più mirata, più concreta, più pericolosa” ha scritto Eve Ensler. L’arte si è dimostrata in grado di poter svolgere un ruolo da protagonista in campo sociale; ha il potere di cambiare la cultura, perché è la cultura che deve cambiare, “le credenze, la storia e il comportamento che stanno alla base della cultura” devono cambiare, perché “non abbiamo ancora svelato o decostruito i fondamenti cultuali e le cause della violenza”; l’arte ha il potere di far conoscere e, facendo conoscere, ha il potere di far maturare le coscienze. Ecco, allora, gli strazianti monologhi delle donne di Bosnia, rinchiuse nei “campi di stupro” durante la guerra in Jugoslavia, e quelle di Ciudad Juarez, in Messico, dove ogni anno decine di donne spariscono e vengono ritrovate nel deserto, stuprate, coi seni tagliati, violate in ogni aspetto della loro femminilità: perché “ovunque succedono cose terribili alle vagine”.
Sicché ben vengano codeste vagine parlanti, che ci fanno riflettere su quali sono le vere proporzioni e le vere prospettive alle quali dovremmo attenerci per non correre il rischio di mancare una definizione di umanità indispensabile per la nostra stessa sopravvivenza, per la nostra stessa dignità. Brave le vagine che parlano! E che tante altre cose fanno…
E se l’uomo non fosse nient’altro che natura?
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
ROMA – La magia dell’haiku non è quantificabile nella sua semplice definizione. Un componimento breve, che parte da uno spunto naturale, e si configura in diciassette sillabe suddivise in tre versi: prima cinque poi sette poi cinque. La magia dell’haiku è data dal suo genuino potere di cogliere la scintilla, di cristallizzare il momento dell’energia e concretarlo lì, sulla carta, imprigionandolo nelle sillabe e modellando un ricordo che sia valido a discapito del luogo e dello scorrere del tempo. Bashō fu forse il più grande scrittore di haiku: la storia lo racconta e lo certifica la critica. Fu quello più legato alla natura e ai suoi impulsi poetici. Nelle sue “Poesie”, pubblicate nel 2003 dalla coraggiosa casa editrice pugliese Acquaviva, gli animali e le piante sono l’elemento imprescindibile della provocazione sensoriale, e diventano vettore trainante dell’intima scoperta umana: “È in fiore / il ciliegio centenario. / Il vecchio ricorda”.
La natura diventa anche il setting privilegiato per la scoperta, che avviene nella quotidianità più estrema ma che narra una storia più universale: “Mangiando ai piedi dell’albero / sulla minestra e sul piatto di pesce / cadono i petali di ciliegio”. La comunione tra uomo e natura è totale e non ammette deroghe né torti: “Io sono un uomo / che mangia il suo riso / in mezzo alle campanule”. Ma la natura trasmette soltanto calma e quiete, dolcezza e tranquillità. La natura è anche il luogo del dolore, che trova però sempre il modo di esser sublimato e, in un certo senso, arricchito di possibilità, di alternative: “In morte di un mio amico poeta // Scuotiti, tomba. / Il vento d’autunno / è la voce del mio lamento”. Perché la poesia Basho la ricerca nella vita quotidiana, appunto. La ritrova voltando lo sguardo, cogliendo gli aspetti della vita più semplice e pura: “Ah, come sto bene! / Ieri mi è passato ogni malore / dopo una zuppa di pesce palla”. E la ritrova, soprattutto, là dove la creatività umana e la potenza della natura si incontrano e, incontrandosi, riescono a unirsi e far gemmare qualcosa di speciale, di genuino: “L’inizio dell’arte: / la profondità della campagna / e una canzone piantando il riso”. Nella natura Bashō ritrova tutti i componenti dell’uomo, trova la possibilità d’una continua sorpresa, la promessa dell’inaspettato: “Sono stanco / e entro in una bettola. / Ci trovo fiori di glicine”. Trova persino una traccia perduta dell’amore, un desiderio rimasto incompiuto e chissà se mai avverabile: “Verrà quest’anno / la neve / che contemplai con te?”.
Sa bene, Bashō, che la poesia nacque con l’uomo, e che l’uomo con la poesia crebbe fino a superare sé stesso nelle sue previsioni, nei suoi intenti. Sa bene, Bashō, che la vita è una ricerca, un continuo esplorare per cambiare, nel tentativo ultimo di migliorare: “L’anno se ne va / mentre anch’io mi metto il cappello / e mi calzo le ciabatte di paglia”. Sa però ugualmente bene, Bashō, che la ricerca è solitudine, e che in solitudine si compie il viaggio: “Grande luna! / Ho vagato intorno allo stagno / per tutta la notte”. Ecco allora che gli ultimi suoi versi mai composti sono il suo testamento, la teorizzazione suprema di tutta la sua eterna ricerca, poetica e umana: “Ammalato nel mio viaggio / il mio sogno se ne va da solo / per le pianure desolate”.
Hans Adam von dzu Liechtenstein e i suoi privati tesori.
 Michael Dialley
Michael Dialley
AOSTA – “I Tesori del Principe” si propone come un viaggio nella più grande collezione privata di opere d’arte presente al mondo, l’ultima appartenente ad una casata asburgica.
Le 80 opere sono una minima parte rispetto alle 1500 che compongono questo patrimonio artistico della casata dei Principi del Liechtenstein: la famiglia ha sempre avuto la passione per l’arte classica, tant’è che la collezione nasce nei primi anni del 1600 e prosegue ancora oggi, sempre seguendo lo stesso filone artistico, in quanto l’arte moderna è immagine di un secolo buio, come afferma Hans Adam von dzu Liechtenstein.
Edito da Forte di Bard e curato da Johann Kraftner e Gabriele Accornero, il catalogo, dell’omonima mostra, si propone come un importante strumento per chi ama e studia l’arte, corredato di immagini grandi, nonché di testi introduttivi, didascalie che raccontano i soggetti e danno le informazioni necessarie per un’infarinatura generale sull’autore. 7 sezioni che fanno scoprire i più grandi maestri olandesi, fiamminghi ed italiani che hanno profondamente segnato la storia dell’arte dal XV al XVIII secolo: da Lukas Cranach Il Vecchio ad artisti del calibro di Hayez.
Un viaggio tra opere a carattere religioso, come il “Compianto di Cristo” di Rubens, scene mitologiche, come il “Ratto di Europa” di Van Balen piuttosto che “Apollo e Diana uccidono Pitone” di Francheschini, ma anche ritratti, di artisti come Van Dyck e Hals, fino ad arrivare a pezzi molto particolari come il “Cabinet” di Baumgartner, un mobile con piccoli cassetti interamente decorato con pietre preziose e marmo toscano.
Un insieme di opere ricche di cromatismo, movimento, emotività tipiche dell’arte e dei dipinti di un secolo controverso, ma fortunatamente molto rivalutato negli ultimi anni: il Barocco.
Un viaggio suggestivo nelle sale che erano le cannoniere dell’opera Carlo Alberto del Forte di Bard, in Valle d’Aosta, e che adesso può essere intrapreso anche attraverso il catalogo di questa mostra.
Chi sono gli “Assassini” dei nuovi anni Dieci?
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
ROMA – C’è una fabbrica che inquina, nel romanzo di Philippe Djian; c’è un paese, Hénochville, che vive grazie a codest’industria; c’è un ispettore che sta per decidere di chiudere la fabbrica; ci sono alcuni operai che non vogliono che sia chiusa; ci sono delle mazzette che vengono versate e c’è una donna pagata per convincere l’ispettore. C’è anche un fiume – ovviamente inquinato – che sta per tracimare; c’è una donna, una ragazza, che ignara di tutto si trasferisce in città e prende in affitto un appartamento; c’è il protagonista, Patrick Sheahan che ha una relazione con una donna sposata; e c’è il marito che fa finta di ignorare. Il copione di “Assassini”, romanzo edito nel 2012 dalla romana Voland, è quello che anche alcuni recenti fatti, di questi primi anni Dieci, hanno portato alla ribalta delle cronache. Da una parte la produzione, la creazione di ricchezza; dall’altra il disastro ambientale e umano: quale dei due poli pesi di più e sia più importante è difficile a dirsi, perché l’assunzione di responsabilità della risposta tira in ballo situazioni imbarazzanti e un’accusa di omertà pesante da giustificare.
Il protagonista è perentorio, fin dall’inizio: “Lavoravo per un assassino. Lavoravo per un assassino come molti in città, ma nessuno diceva niente”. Tutti i personaggi corrono su un doppio binario: quello delle proprie vite personali e quello delle proprie vite “pubbliche”, legate indissolubilmente all’andamento della fabbrica e alla sua capacità produttiva. Gli amici si ritrovano tutti assieme, in un piccolo chalet di montagna, assediati dalla pioggia e da una frana che si fa sempre più incombente, fino a quando tutto è travolto e si offre la possibilità di voltare pagina, di affrancarsi dai dolori del passato e di cominciare una nuova vita da qualche altra parte: “La ricerca della felicità è faccenda piuttosto complessa e quasi sempre votata al fallimento, eppure tutti ci provano. Ci vuole tempo, poi, per imboccare un’altra strada”. Il ricatto sentimentale del protagonista, il suo volontario e sadico ostaggio della sua storia e della sua vicenda personale, lo allontanano dalla possibilità di redenzione, che appare preclusa in una città soffocata e oppressa, dall’industria e dalla natura; i suoi tentativi di evadere sono stanchi rimedi inutili, iniziative fallite ancora prima di approdare all’epilogo: su tutto grava un cielo scuro e un annuncio di giudizio universale. Su tutti incombe l’ombra di un fato arcigno e di una casualità ostile. Tutta l’umanità è pareggiata, sullo stesso palcoscenico d’eventi, e tutta l’umanità, al di là di ogni proprio impulso e patimento, si scopre sofferente e sanguinante.
Nello scorrere degli eventi, nell’avanzare impetuoso e inarrestabile della trama, di fronte alle esigenze intime e individuali, quelle della collettività passano in secondo piano, si opacizzano e assumono, sempre più, una dimensione inquietante e carnivora. Non c’è vita che possa essere sprecata, ma ci sono disastri che posson tramutarsi in risorse. Il finale è prevedibile e scontato, persino sdolcinato, ma lascia un’ombra inquieta e inquietante: in tutta questa trita umanità non si capisce bene chi siano i peggiori assassini.
Roberto Roversi, il poeta della musica.
 AOSTA – Un altro poeta ci ha abbandonato. Roberto Roversi è morto. Aveva 89 anni. Era stato partigiano, libraio antiquario, fondatore di Officina, scrittore per il teatro, paroliere di Lucio Dalla e gli Stadio, scrittore e soprattutto poeta, mai piegato alle necessità di fatturato delle case editrici ma orgogliosamente e fiduciosamente convinto nell’indipendenza dell’arte, e nella sua utilità al di là dell’introito.
AOSTA – Un altro poeta ci ha abbandonato. Roberto Roversi è morto. Aveva 89 anni. Era stato partigiano, libraio antiquario, fondatore di Officina, scrittore per il teatro, paroliere di Lucio Dalla e gli Stadio, scrittore e soprattutto poeta, mai piegato alle necessità di fatturato delle case editrici ma orgogliosamente e fiduciosamente convinto nell’indipendenza dell’arte, e nella sua utilità al di là dell’introito.
Lo ricordiamo con questo testo, 20 parole, una canzone incantevole, scritta per Mina e dalla Tigre di Cremona magistralmente interpretata nel 2005, per il suo Bula Bula:
20 parole
Io ti ascolto da solo, mio cuore
Tu che guardi dai vetri
Le rare foglie del cielo la terra toccare
L’ora del giorno è rubata dal sole
Montagne rosse, tre colpi di tosse lontani
E poi scende la sera
Sull’asfalto le voci dei cani
Sotto i lampi di una nuvola nera
 Posso strapparti d’amore il vestito
Posso strapparti d’amore il vestito
Sono i diavoli padroni delle giornate
Io ti amo da altezze incredibili
Ragazzo vestito di bianco e di arancio
Per guanciale il tuo corpo mi dai
Solo i sogni non muoiono mai
Io ti amo da spazi infiniti
Ragazzo vestito di sale e di vento
E ti ascolto da solo, mio cuore
Questa sera di nuvole nere
Sul guanciale rimane l’amore
Con un sogno di 20 parole
I sopravvissuti “Canti d’amore dell’antico Egitto”.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
ROMA – Alla parola “Egiziani” non sono le poesie d’amore le prime immagini che si presentano alla mente. Subito compaiono piramidi, sfingi, monumentali tombe e raffigurazioni di un oltretomba tanto certo quanto misterico. Ma dell’epoca di Ramesse II, il periodo di maggior fioritura dell’Egitto antico, ci rimangono alcune testimonianze scritte di notevole valore e importanza, che la Salerno Editrice ha pubblicato nel 2005, con la cura di Emanuele M. Ciampini: i “Canti d’amore dell’antico Egitto” costituiscono una miniera sorprendente di parole e immagini che riguardano l’amore. È sorprendente stupirsi di fronte ai toni coi quali in Egitto si poetava di questo sentimento, perché è facile ritrovare topoi e immagini concordi con quelle di altre popolazioni del tempo, soprattutto nell’ambito sapienziale (“egli allora magnificherà il mio nome”), a conferma di come il serbatoio poetico e la memoria collettiva sia comune al di là delle etnie e degli orizzonti che si occupavano. Risultano ancora più sorprendenti queste testimonianze vista l’estrema frammentarietà a cui è stata condannata la scrittura egiziana, codificata su supporti troppo fragili per potersi conservare massicciamente e a lungo: “Oh, possa tu venire in fretta da (tua) sorella / come una gazzella che corre per il deserto”.
Questi componimenti paiono sorprendere soprattutto per un aspetto: dopo la parentesi amarniana, con la riforma religiosa e sociale di Akhenaton, il predecessore di Tutankhaton/Tutankhamon, la coscienza egiziana si rende più “umanistica”, più focalizzata sull’interiorità e su un rapporto esclusivo tra uomo e mondo: in questo modo si potenzia il sentire, anche poetico, dell’individuo e la poesia può effettivamente librarsi al di là degli orpelli e dei limiti retorici e celebrativi: “Il tuo amore si è fuso col mio corpo / come [vino] con l’acqua / come una medicina alla quale si mischia della resina”. La nuova e maturanda coscienza di sé porta anche a un cambiamento epocale nella società egiziana: la sempre maggior presa di coscienza del ceto medio-alto egiziano, che comincia a conquistarsi spazi e prospettive all’interno della rigida società piramidale: “Fratello, mio amato, il mio cuore segue il tuo amore, / e tutto ciò che è stato creato per te io te lo racconterò”.
I temi delle poesie son quelli affrontati, classicamente, nei componimenti dall’origine della poeticità: l’amore visto come dolore, come sofferenza, ma anche, all’opposto, un amore concepito come sentimento universale, come potenza sovra-umana che sa conquistare l’uomo e persino cambiarlo (“La mia salute dipende dal suo arrivo / perché al solo vederla io sto bene”). È un amore che anche la Natura appoggia, che soddisfa e sostiene, e nella quale l’amante si ritrova, trasformato e sublimato: “Il melograno ha aperto la sua bocca / […] e rimango verde in ogni stagione / […] e comincio a dispiegare la mia fioritura”. È un amore inesauribile, che non smette mai di ricercare situazione di incontro, convergenze e tangenze: “È un giorno felice quando posso contemplarti. / Fratello, è un canto grandioso vederti!”. È un amore fortemente erotico, nella sollecitazione di tutti i sensi, accesi e stimolati al suo adempimento: “Tu potrai inebriare i loro sensi, / e li soddisferai nella sua notte. / E allora lei dirà: – prendimi tra le tue braccia / e al sorgere del sole noi staremo ancora così”. Spesso l’amore è osteggiato, spesso gli amanti sono costretti a separarsi, divisi dal destino e dagli antagonisti, ma spesso la loro riconquista reciproca sancisce la fine della sofferenza e il ristabilimento di una situazione che viene perseguito come il compimento più perfetto della vita di ognuno: “Oh notte, tu mi apparterrai in eterno, / da quando la signora è venuta da me!”.
“Se la vita è un piatto di ciliegie, perché a me solo i noccioli?”
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
ROMA – La domanda chiunque di noi se la sarà fatta, almeno una volta nella vita. E la risposta non è mai troppo scontata. Nel caso di Erma Bombeck, però, diventa lo spunto per una divertente disamina della propria condizione esistenziale. Giornalista di costume e sensazionale osservatrice degli attimi, Erma Bombeck ha per anni divertito l’America e il mondo raccontando la saggezza mietuta nelle sue lunghe giornate di casalinghitudine, quando il lavoro è titanico ma mai riconosciuto. Erma approdò tardi alla parola scritta, dopo una vita dedicata alla famiglia e alla casa: “Abbassare il coperchio della tazza del cesso dieci volte al giorno non basta a realizzarmi”; divenne così una delle penne più ricercate e pagate del giornalismo americano, scrivendo centinaia – forse più di 4000 – di articoli di costume, nei quali la housewife divenne la protagonista assoluta, imponendo la sua presenza e decretando la sua importanza nella società statunitense, senza rinnegare la sua importanza e il suo lavoro di profonda devozione.
 “Se la vita è un piatto di ciliegie, perché a me solo i noccioli?” (Longanesi & Co. 1980) è un’indagine sfiziosa e sagace della vita di una casalinga, la “Fata Turchina”, che diventa exemplum condiviso da milioni di altre casalinghe sparse per il mondo, nella quale tutte si ritrovano e possono, scherzando, crearsi comunità e condividere la sorte: “Ecco di cosa tratta questo libro. Della sopravvivenza”. Lo stile della Bombeck è accattivante, con improvvisi lampi e folgorazioni sagaci, intelligenti, mai volgari né banali; con coraggiosi cambi di prospettiva e di punti di vista, che accrescono l’ironia e mortificano il grottesco. Come nel caso dell’incontro/scontro tra uomini e donne, tra Venere e Marte: “Una donna può girare per il Louvre, a Parigi, e vedere cinquemila quadri da togliere il fiato appesi alle pareti. Un uomo può girare per il Louvre, a Parigi, e vedere cinquemila chiodi infissi in quelle stesse pareti. È questa la differenza fondamentale”.
“Se la vita è un piatto di ciliegie, perché a me solo i noccioli?” (Longanesi & Co. 1980) è un’indagine sfiziosa e sagace della vita di una casalinga, la “Fata Turchina”, che diventa exemplum condiviso da milioni di altre casalinghe sparse per il mondo, nella quale tutte si ritrovano e possono, scherzando, crearsi comunità e condividere la sorte: “Ecco di cosa tratta questo libro. Della sopravvivenza”. Lo stile della Bombeck è accattivante, con improvvisi lampi e folgorazioni sagaci, intelligenti, mai volgari né banali; con coraggiosi cambi di prospettiva e di punti di vista, che accrescono l’ironia e mortificano il grottesco. Come nel caso dell’incontro/scontro tra uomini e donne, tra Venere e Marte: “Una donna può girare per il Louvre, a Parigi, e vedere cinquemila quadri da togliere il fiato appesi alle pareti. Un uomo può girare per il Louvre, a Parigi, e vedere cinquemila chiodi infissi in quelle stesse pareti. È questa la differenza fondamentale”.
La realtà è la sua materia, che poi plasma per approdare là dove pareva troppo scontato approdare, ma dove effettivamente si nascondono le verità più vere e profonde. Non c’è mai un racconto fuori posto, un’esperienza eccessiva e inutile, un affondo inopportuno. Non c’è mai una valutazione stridente, o un concetto che non possa dirsi condivisibile. Gli aneddoti e le esperienze sono deliziose, golose, nutrienti, sane nel senso più pieno e completo della parola. Ed è la stessa famiglia della Bombeck il campionario di infiniti teoremi e postulati, una sorgente naturale di inesauribile vita: i figli e il marito diventano quasi dei casi da studiare, da analizzare con uno sguardo tagliente come bisturi, ma mai freddo, asettico: “Nessuno sa che cosa aspettarsi della vita! Ma io ho il terrore di lasciare questo mondo senza che nessun altro membro della mia famiglia sappia sistemare un rotolo nuovo di carta igienica sull’apposito sostegno”. Perché al di là di tutto, l’amore e la dedizione della donna-moglie-casalinga tracima e perdona. Non dimentica, ma perdona, sublimando l’evento e creandolo vita sempre migliore; vita per migliorare: “Ma soprattutto ti ho amato abbastanza da continuare a dire ‘No’ anche sapendo che mi avresti odiato. È stata questa la decisione più difficile”.
Avrà, insomma, pur sempre parlato della tazza del cesso, Erma Bombeck; ma ne ha parlato sempre col massimo rispetto!






