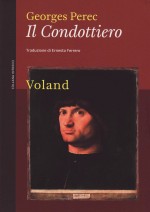Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – La globalizzazione l’abbiamo voluta. Il libero scambio, l’euforia di internet, la sensazione desiderata di sentirsi parte di un immenso “villaggio globale” dove le distanze si annullassero e le particolarità di annichilissero. La globalizzazione, però, porta con sé anche alcuni obblighi, che per tanti, adesso, sono diventati indesiderati. La libera circolazione umana, inarrestabile, improcrastinabile, rimette in gioco l’identità, attiva dei meccanismi di ri-definizione, di ri-valutazione. Non possiamo ancora farci resistenti all’idea, all’inevitabile futuro di incontri e tangenze. Di tutto questo, e anche di molto altro, ne abbiamo parlato con Andrea Staid, giovane storico e antropologo, che ha pubblicato per AgenziaX il saggio “Le nostre braccia”, dove si analizza il processo del meticciato e dove si teorizzano le nuove schiavitù, quelle che alimentano e sostengono le leggi sull’immigrazione, soprattutto extra-comunitaria.
Per questa nostra chiacchierata partirei dal concetto di “meticciato” perché la parola stessa (affascinante di per sé) ha subito, negli ultimi tempi, una sorta di riabilitazione semantica. Se fino a qualche tempo fa il lemma “meticcio” veniva utilizzato con un’ombra denigratoria e infamante, anche grazie al tuo saggio è evidente come le prospettive si siano ampliate e aggiornate. Persino sul piano della narrativa ha trovato spazio il grande esperimento di Wu Ming 2, con il ridefinito “romanzo meticcio”, ovvero un romanzo costruito tramite testimonianze, materiali d’archivio, memorie, interviste, fotografie, e anche creazione narrativa. Cosa si intende, oggi, per “meticciato” e come lo si può vivere e sperimentare concretamente?
Il meticcio è l’incontro, l’ibridazione tra culture diverse, ma non dobbiamo malintendere questo concetto, perché come ci ricorda Laplantine, non esistono individui originariamente puri, il meticciato si oppone alla polarità omogeneo/eterogeneo. Si presenta come una terza via tra la fusione totalizzante dell’omogeneo e la frammentazione differenzialista dell’eterogeneo. Il meticciato è una composizione le cui componenti mantengono la propria integrità. Non è una fusione, coesione o una specie di osmosi è un confronto tra le tante alterità culturali è quello che manca nelle nostre politiche sociali cioè il DIALOGO. In più non dobbiamo dimenticarci che la storia del Mediterraneo, dell’Europa è fatta da un vero e proprio crogiuolo culturale, di migrazioni continue, avvolte sotto forme di invasioni, conquiste, scontri, saccheggi e deportazioni, ma anche di scambi, confronti, trasformazioni reciproche dei popoli. Il meticcio è al di fuori di tutte le argomentazioni politicaly correct, è un mosaico polimorfo, decostruisce i muri identitari nazionali e sovranazionali. Cosa dobbiamo fare per viverlo e sperimentarlo? Smettere di avere paura, scavalcare i falsi confini del “noi” “loro” in modo da rielaborare i nostri modelli dei rapporti sociali e risistemare le coordinate del mondo vissuto perché le forme della società sono la sostanza della cultura.
E pare proprio la paura il sentimento costante dei nostri Anni Zero e Dieci. Talmente tanta la paura da aver elaborato delle leggi a regolare l’immigrazione che sono dei veri e propri bunker, anche se pieni di falle e di maglie deboli. C’è chi ha parlato di “Fortress Europe”, una vera e propria fortezza, fatta di frontiere rinforzate e di assurde leggi migratorie. Tu definisci il migrante una “non persona estremamente ricattabile”: perché i migranti fanno paura? Quali sono i nostri timori? Cosa immaginiamo a rischio ipotizzando l’arrivo di altre persone?
L’Europa infatti è una vera fortezza, fatta di confini sorvegliati da eserciti e polizie internazionali, fatta di persone con diritti e di persone uguali a queste ma di serie b, quelle che nel mio libro e prima di me Alessandro Dal Lago ha chiamato “non persone”. “Non persone” perché anche se camminano, mangiano e dormono come noi il fatto che non hanno il permesso di soggiorno che è solamente un pezzo di carta con un timbro sopra, li fa diventare immediatamente delle persone senza nessun diritto, ovvero non persone estremamente utili per il nostro sistema capitalista che necessita di lavoratori altamente ricattabili senza nessuna possibilità di rivendicare i propri diritti. I “nostri” timori sono dettati dalla paura del diverso, dal confronto con l’alterità perché troppo spesso tendiamo a rinchiuderci in una falsa e monolitica identità culturale. Come scrive Marco Aime nel suo “Macchia della razza, storie di ordinaria discriminazione” ormai siamo come quei tifosi che non inneggiano più alla loro squadra, ma passano novanta minuti a insultare gli avversari, tifosi che hanno fatto dei colori di una maglia una terra di appartenenza per cui vale la pena combattere, fare male, persino uccidere. Una terra non da amare, ma utile a odiare gli altri.
E per dominare le nostre paure, per illuderci di essere più sicuri nelle nostre vite, ci siamo inventati una legge sull’immigrazione che, come tu sostieni nel tuo saggio, incentiva la clandestinità e favorisce lo sfruttamento. Tu scrivi una cosa significativa nel tuo testo: “l’irregolarità non è un tratto ontologico del migrante, ma è determinata da un dato sistema giuridico”. Sicché è lo stato, paradossalmente (ma non troppo), che crea e favorisce la clandestinità, definita però al tempo stesso come reato. Quali sono i meccanismi per cui lo stato esercita questa sua ambivalente funzione? In nome di cosa si dispone di altre vite con una pratica burocratica alienante?
La legge italiana è particolarmente ridicola per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori. Praticamente è una legge che produce clandestinità. Un migrante una volta arrivato in Italia se non ha già un datore di lavoro non ha nessuna possibilità di essere regolarizzato. L’unica possibilità che trova davanti a sé è quella di lavorare in nero super sfruttato, senza nessun tipo di diritto. Il problema non riguarda poi solo il mondo del lavoro ma anche quello della casa: senza documenti trovare una casa è un odissea, e molti italiani se ne approfittano chiedendo affitti allucinanti per piccoli appartamenti o singole stanze da condividere. Ma non è finita qua senza documenti i migranti si vedono negare anche uno dei diritti più fondamentali cioè quello della libertà di movimento, si muovono il meno possibile e sempre con la paura di essere fermati e rinchiusi in un CIE o in un carcere senza aver commesso nessun reato. La seconda domanda invece contiene anche la risposta, la burocrazia è alienante e crea per dirla come David Graeber spazi morti nell’immaginazione degli esseri umani. Più semplicemente tramite cavilli burocratici, leggi sempre più restrittive si crea disuguaglianza, sofferenza e si condannano migliaia di esseri umani alla nuova schiavitù.
Ed è forse ancora più agghiacciante pensare che al giorno d’oggi si siano ripristinate, con la complicità e l’omertà dello stato, nuove forme di schiavitù. Una schiavitù che non soltanto condanna all’estrema precarietà i migranti ma che condiziona spesso i rapporti anche tra di loro, come tu scrivi in un paragrafo del tuo libro. In particolar modo tu analizzi un caso specifico, quello delle badanti. Noi siamo oramai abituati a queste figure che son diventate essenziali per la nostra esistenza, ma difficilmente immaginiamo – o abbiamo la pazienza di immaginarci – le dure condizioni nelle quali vivono e lavorano. Perché questo fenomeno è interessante all’interno della tua lettura etnografica? Quali considerazioni permette di elaborare?
Il capitolo sulle badanti analizza proprio un caso specifico, perché oltre allo sfruttamento la maggior parte di queste donne vivono una situazione di segregazione, di vero dominio e controllo da parte del datore di lavoro. In più analizzando bene le conversazioni che ho avuto con le badanti esce fuori un altro aspetto centrale che è quello di sentirsi trattate come delle macchine tappa buchi. Da non sottovalutare poi che sono le precarie per eccellenza nel mondo del lavoro nero perché la durata del loro impiego è strettamente legata alla vita del loro assistito. Per le considerazioni che permette di elaborare invece lascio la parola a una donna che lavora in Italia come badante che molto meglio di me sa esprimere ed elaborare quello che è la condizione di queste giovani donne: “Mio amato marito, emigrate diveniamo immortali. Mai nate, non siamo state cresciute, non invecchiamo, non ci stanchiamo, non moriamo. Un’unica funzione: lavorare. Immortali poiché continuamente interscambiabili. Esisterà la fine del lavoro, ma non c’è limite alle forme del servire”.
Sicché quali sono le possibili prospettive? Quali le avverabili soluzioni? Quali possono essere le decisioni coraggiose da prendere per trasformare la migrazione da ancestrale (e irrazionale) paura a effettivo momento di scambio e crescita, di compiuto meticciato?
Per smettere di avere paura bisogna accettare una interazione egualitaria con gli altri, dobbiamo saper costruire identità dai confini aperti e pronti al cambiamento. L’identità può avere una valenza positiva e riconoscersi negli altri e una negativa nella quale scoprirsi e definirsi in base a ciò che ci differenzia dagli altri. La valenza positiva porta verso il pensiero meticcio che contrasta il falso universalismo e il mito della purezza, questo avviene tramite un processo dinamico di scambi reciproci, di accettazioni e di rifiuti, di rinunce e di appropriazioni. Dobbiamo essere consapevoli dei tanti possibili errori, delle difficoltà, degli incontri e degli scontri, ma anche essere forti della necessità di accettare la complessità del reale, perché la complessità deve diventare il fondamento della nostra identità. Quindi senza paura verso il divenire meticcio!
 Giulia Siena
Giulia Siena