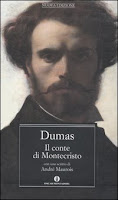Stefano Billi
ROMA – Sovente, parlando dei “classici”, cioè di quei libri che rappresentano la storia della letteratura, la mente associa questa categoria all’immagine del “mattone”: un testo che si compone di centinaia e centinaia di pagine in cui si avviluppa una trama sicuramente complicata (per non dire addirittura contorta), dai contorni noiosi e difficili da seguire.
Insomma, spesso si è portati a pensare che questi libri abbiano, come unico compito, quello di riempire le biblioteche, e oltretutto non quelle domestiche – riservate ai romanzi di ben più bassa levatura – ma quelle, ad esempio, comunali o universitarie.
Invece, è giunto il tempo di riappropriarsi di un patrimonio dell’umanità che, anziché essere lasciato alla mercé di topi e tarme della carta, merita di essere assaporato dalla prima all’ultima pagina.
Perché sono questi capolavori, elaborati dai grandi scrittori di tutte le epoche storiche, che possono permettere alla società di progredire.
Uno di questi libri, che nutre la mente come pochissimi altri racconti sanno fare, è proprio “Il conte di Montecristo”, scritto da Alexandre Dumas (padre) nel 1844.
La trama di questo meraviglioso pilastro della letteratura mondiale è tutta incentrata sulla figura di Edmond Dantès, giovane marinaio che dovrà combattere contro un destino spietato, frutto dell’invidia amorosa di un miserabile invaghitosi della dolce metà del protagonista: tuttavia il fato si rivela, infine, anche sorprendente e difatti l’inaspettata conoscenza dell’abate Faria sconvolge la vita di Edmond, un dono provvidenziale che il Dantès saprà abilmente cogliere.
Pur nelle sue millecinquecento pagine circa, la lettura de “Il conte di Montecristo” è scorrevolissima: lo stile di Alexandre Dumas è affascinante per la sua linearità e semplicità, aspetti che entrambi dimostrano al contempo l’eleganza della penna dello scrittore, che in quest’opera tocca il suo apice narrativo.
Inoltre, va assolutamente rilevata la maestria, impareggiabile, dello scrittore nel costruire un’impalcatura degli eventi che porta il lettore a non voler mai smettere di leggere, quasi che il romanzo fosse stregato; in realtà, non si tratta di un’opera magica, ma piuttosto di una creazione davvero perfetta, come se la sua origine, più che umana, fosse divina.
All’interno del libro l’autore sa mirabilmente descrivere ogni sentimento dell’uomo, dalla rabbia all’ammirazione, dal desiderio di vendetta al perdono.
Ogni parola illumina gli animi dei protagonisti e permette così di svelarne la vera identità.
Dumas sembra dunque assumere le vesti di un ottocentesco Virgilio che disvela a chi legge le reali fattezze emozionali di ogni persona.
“Il conte di Montecristo” è un romanzo che merita di essere letto per la sua infinita bellezza, perché racchiude una storia magnifica che penetra irreversibilmente nell’animo del lettore, ma soprattutto perché permette di innalzare il proprio pensiero e sfiorare le imponenti vette artistiche della letteratura senza tempo.
Una volta letto il libro, però, si rimane pervasi anzitutto da una sensazione di sconforto, non solo perché il testo è giunto al termine, ma anche perché si resta consapevoli di come soltanto pochissime altre opere letterarie siano così stupefacenti come questa creata dal Dumas.
Allora, l’unico antidoto possibile contro questo profondo senso di amarezza sta nel rileggere ancora e ancora “Il conte di Montecristo”, un romanzo che davvero cambia la nostra vita.
 Ho letto questo libro da bambina e l’ho amato. Ho amato la Maestrina dalla Penna Rossa e quella Piccola Vedetta Lombarda che ha dato la vita per la Patria. Li ho ammirati, nella mia ingenuità, per la loro purezza e per il loro coraggio. Ho sognato di diventare come loro. Di lasciare una traccia nel cuore di chi resta.
Ho letto questo libro da bambina e l’ho amato. Ho amato la Maestrina dalla Penna Rossa e quella Piccola Vedetta Lombarda che ha dato la vita per la Patria. Li ho ammirati, nella mia ingenuità, per la loro purezza e per il loro coraggio. Ho sognato di diventare come loro. Di lasciare una traccia nel cuore di chi resta.