Alessia Sità
ROMA – “Se ne stava lì. Lo sguardo fra le lunghe ciglia scure di trucco. Lo sguardo divorato dalla nostalgia di un domani che non sarebbe mai arrivato. Quello sguardo spalancato scagliava gli ultimi brandelli di vita verso il cielo di ghiaccio, come per catturarlo nella ragnatela disordinata di immagini che avrebbe trascinato con sé nella notte.”
Si apre negli anni ’70 “Viola”, il nuovo romanzo di Pervinca Paccini pubblicato da Autodafé Edizioni. Fra lotte studentesche, amore, sesso e disubbidienza femminista si dipana la storia di Giulia e Viola, due sorelle unite da un profondo ed intenso sentimento fraterno. Purtroppo però, l’inaspettato irrompe nelle loro giovani vite, spezzando per sempre qualcosa che mai più ritornerà. Quel legame che le aveva sempre accompagnate fin dall’infanzia viene inspiegabilmente stroncato da un evento oscuro.
A distanza di trent’anni, però, Giulia continua ad interrogarsi e a tormentarsi sulla morte dell’amata sorella. L’impossibilità di riuscire ad affrontare un passato doloroso, lentamente lascerà spazio ad un nuovo sentimento. Sarà proprio l’incontro e l’amore di Gabriele, un restauratore di libri antichi, la vera chiave di svolta nell’esistenza della donna. Fra foto sbiadite, indizi vari e vecchi amici, Giulia troverà la forza e il coraggio per intraprendere un viaggio doloroso, ma indispensabile per poter finalmente ridare la serenità al ricordo dell’adorata Viola.
Fra presente e passato, Pervinca Paccini racconta una toccante storia umana. A fare da sfondo alla vicenda esistenziale di ogni personaggio è sempre Milano. La Milano di oggi: “grigia, fredda inospitale, necessaria come il denaro” e la città di ieri, scenario di rivoluzioni culturali, di eccessi e partecipazione politica.
Vincitore nel 2010 del premio per il miglior incipit tra i romanzi pubblicati su IlMioLibro, “Viola” è un romanzo generazionale, che ha il merito di aver saputo mettere a confronto due generazioni completamente diverse.







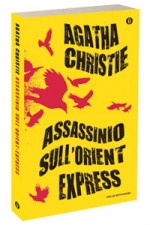
 Marianna Abbate
Marianna Abbate





