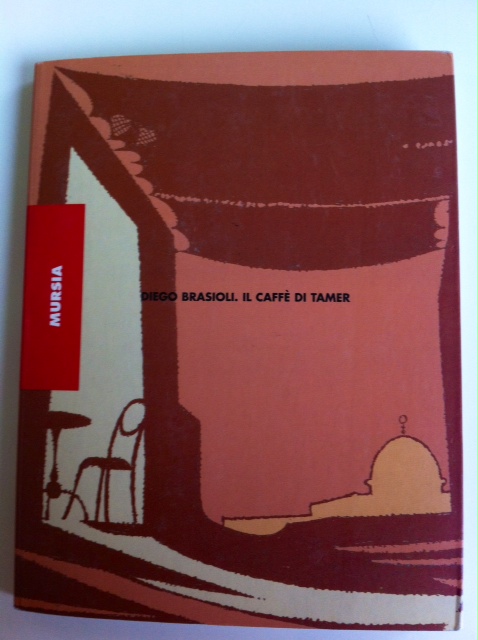 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Diego Brasioli conosce il Medioriente. Ci ha trascorso molti anni, come ambasciatore per l’Italia a Beirut. E ha conosciuto gli spettacoli della guerra, la devastazione, la complessità umana e sociale dei conflitti che per decenni lunghissimi hanno martoriato questa piega di mondo. Ed ha conosciuto persone vere, con un volto, un timbro vocale, una storia di migrazioni. In “Il caffè di Tamer”, edito da Mursia nel 2002, Brasioli squaderna una storia di amicizia dal valore altamente simbolico, come soltanto nel contesto della guerra sanno concretarsi.
Dori Goldman è statunitense, ebreo. Come tanti, prima di lui, si trasferì in Israele; tanti si sentirono in dovere di condividere la sorte dei loro “fratelli” di religione, altri pensarono che fosse la cosa giusta da fare; altri ancora, come Dori, andarono quasi per caso e scoprirono che lì, per ragioni sconosciute e non chiare, si sentivano a casa. Quando lui arrivò era il 1963: anni cruciali per il neonato stato. Si trasferì in un “quartiere di arabi ed ebrei dove in fondo non vi erano mai state fratture”, a conferma di come la storia sia spesso falsata e resa inesatta da giornalisti e storici dello scoop. La pace, in Palestrina (o Israele), è sempre esistita, perché gli uomini, al di là del Potere, sanno convivere e superare le differenze. Dori adora passeggiare per i quartieri della Gerusalemme vecchia, una città che possiede un’energia sovrumana, quasi mistica. Qui, in questo luogo di millenarie sofferenze ed epifanie, Dori conosce Tamer, un arabo proprietario di un modestissimo caffè, ma che diventa l’ombelico del loro mondo, il luogo più sicuro sulla terra, quello dove si costruiscono i veri sentimenti e si rafforzano i rapporti di amicizia e amore. Da dove, soprattutto, si contempla con sguardo critico l’evolversi degli eventi.
Anche durante gli episodi della Seconda Intifada, inaugurata all’alba del nuovo millennio, il loro rapporto non si incrinò, fino all’inevitabile epilogo, che un po’ è atteso ma non per questo perde il suo valore ultimo di teorema umano, che non ha bisogno di nessuna spiegazione né dimostrazione. Anche grazie a uno stimolante espediente narrativo. Il finale è, infatti, presentato all’inizio, in un “cielo accanto alla terra”; come se la fine fosse proprio il principio: la preghiera del rabbino ebreo e i versetti del Corano, cantati dall’amico, si allacciano insieme e si fondono in una preghiera unica, universale, che canta lo stesso uomo e i suoi stessi bisogni, le sue stesse urgenze: “Gerusalemme ricorda i giorni della sua miseria e del suo vagare, / tutti i suoi beni preziosi del tempo antico; ricorda quando il suo popolo cadeva / per mano del nemico e nessuno le porgeva aiuto”.
Tag: Israele
La bella favola di “Un asino a strisce”.
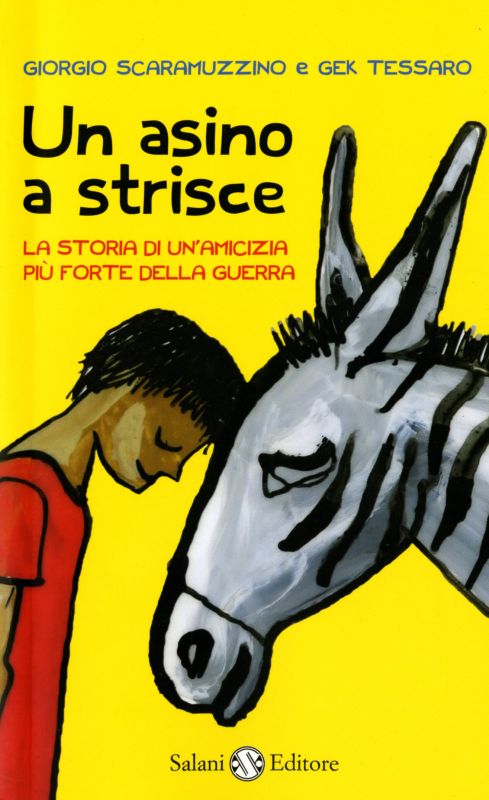 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – La storia è gonfia di un’umanità così sconcertante e potente come solo in situazione di estrema difficoltà capita di incontrare. A Gaza esisteva uno zoo, lo Zaitun. Il custode era il signor Nidal, un anziano palestinese che si prendeva cura dei suoi animali, nonostante tutte le difficoltà patite dalla sua terra. Sa che per i bambini il suo zoo è un’oasi di pace, un luogo divertente dove poter scordare fischi di pallottole, detonazioni, qualsiasi altro rumore o fantasma di violenza. Ma la guerra divampa, l’offensiva israeliana “Piombo fuso” si rovescia con violenza sui territori martoriati della Striscia. E non risparmiano lo zoo. Quasi tutti gli animali muoiono: rimangono oramai solo cani e gatti. Muoiono anche le due zebre che sono la più gradevole attrazione. Allora il guardiano ha un’idea: una specie di contraffazione della realtà, ma per un fine altamente importante. Prende due asini, denutriti ma pur sempre vivi, le rasa e li dipinge a strisce. Li maschera da zebre. Così i bambini potranno ugualmente divertirsi con gli animali, e sognare che tutto sommato possa esistere un po’ di pace.
Giorgio Scaramuzzino ha raccontato questa storia in “Un asino a strisce. La storia di un’amicizia più forte della guerra”, edito da Salani Editore nel 2013, con i disegni dalle linee emozionanti di Gek Tessaro. L’amicizia è quella tra la zebra Aidha e un bambino di nome Talal, di otto anni, uno dei più assidui frequentatori dello zoo. E dell’amicizia dei due con Nidal, il guardiano. Tutto si consuma in poche pagine ma la magia del sentimento, la commozione dell’incontro, il bisogno senza nome e senza età di un modo che sia in pace, senza più guerre, senza più rumori molesti, senza più cieli e futuri preclusi, durano e perdurano attraverso le pagine e anche a libro chiuso.
Non importa la differenza, non importa se la realtà è stata un po’ contraffatta, un po’ camuffata. Quello che importa è il senso profondo, il valore intimo. Perché tutti i bambini hanno dei poteri magici. E con questi si inventano un mondo che è migliore di quello feroce degli adulti.
Solo “Quattro ore a Chatila” per sopravvivere all’inferno.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Quanto tempo si può trascorrere all’inferno? Jean Genet ce ne trascorse quattro, il 19 settembre 1982; e l’inferno fu il carnaio di Chatila; soltanto un paio di giorni prima, tra il 17 e il 18, i miliziani cristiani, fedeli al presidente libanese Gemayel, per vendicare la morte del loro capo, fecero irruzione a Sabra e Chatila, i due campi profughi palestinesi a Beirut Ovest. Jenet fu il primo occidentale a entrare e le sue “Quattro ore a Chatila” (Stampa Alternativa, 2002) diventarono un inno alla contestazione della violenza inspiegabile, del cieco furore che colpisce senza ragione. “Qui, tra le rovine di Chatila, non c’è più niente” racconta Genet: non c’è più niente di vivo, tra le rovine di Chatila. C’è tanta morte, però; tante istantanee pazzesche e inspiegabili: “Da un muro all’altro di una via, curvi o inarcati, i piedi contro un muro e la testa appoggiata all’altro, i cadaveri neri e gonfi, che dovevo scavalcare, erano tutti di palestinesi o libanesi”. Gli israeliani erano fuori: avevano chiuso i campi, avevano collocati posti di osservazione sui tetti, ufficialmente per proteggere i profughi palestinesi dalle violenze dei libanesi, ma non mossero un dito di fronte all’invasione delle milizie cristiano-falangiste: “Il massacro di Chatila si è compiuto nel brusio o nel silenzio totale, se gli israeliani, soldati e ufficiali, sostengono di non aver sentito nulla, di non aver dubitato di niente mentre occupavano questo edificio?”. Anzi; alcuni li accusarono di aver fatto luce sul campo, per facilitare la violenza degli invasori, girando la faccia dall’altra parte per fare finta di non vedere: “Al bagliore dei razzi rischiaranti israeliani, ogni orecchio israeliano, da giovedì sera, ascoltava Chatila”.
I cadaveri, a Chatila, erano muti, le bocce piene di terra, gli occhi vuoti di cielo: “La donna palestinese era probabilmente vecchia, perché aveva i capelli grigi. Stesa sul dorso, posata o abbandonata sui sampietrini, mattoni, sbarre di ferro ritorte, senza cura. Il volto nero e gonfio, rivolto verso il cielo, una bocca aperta, nera di mosche, con denti che mi sembravano bianchissimi, volto che, senza che un muscolo si muovesse, sembrava sia accigliarsi, sia sorridere o gridare di un grido silenzioso e ininterrotto”. Le immagini che testimoniano la carneficina sono agghiaccianti, incomprensibili nella loro ferocia, ma non riescono a dare il giusto peso della realtà: “La fotografia non coglie le mosche, né l’odore bianco e greve della morte. Non racconta il salto che si deve fare quando si passa da un cadavere all’altro”. Non c’è neppure nulla che, in luoghi del genere, dovrebbe essere naturale: “Ciò che mancava, in quel luogo, me ne sono accorto allora, era la scansione delle preghiere”. Chi pregare, in quella situazione? A chi rivolgere parole di supplica e di pietà? Nella violenza si perde la misura, si smarrisce il storia, si snatura l’essenza: “La solitudine dei morti, nel campo di Chatila, era ancora più tangibile perché avevano gesti e pose di cui non erano responsabili. Morti non importa come. Morti abbandonati”. Perché a Sabra e a Chatila non sono morti soltanto i profughi palestinesi, ma siamo morti tutti, responsabili morali delle violenze: “L’odore della morte non veniva né da una casa né da un suppliziato: sembrava uscire dal mio corpo, dal mio essere”.
Ma i morti, grazie alla testimonianza, sanno anche parlare: la loro presenza pesa e significa: “Un bimbo morto, a volte, può bloccare le strade, che sono così strette, quasi sottili e i morti sono così tanti”. Genet si schiera dalla parte dei palestinesi, per lui privati di una terra e costretti a difendersi dall’assalto degli invasori: “La lotta per una terra può riempire una vita molto intensa, ma breve”. Ma la questione è ben più complicata: e l’inferno di Sabra e Chatila dolorosamente lo conferma: “Sono dovuto andare a Chatila per percepire l’oscenità dell’amore e l’oscenità della morte”.





