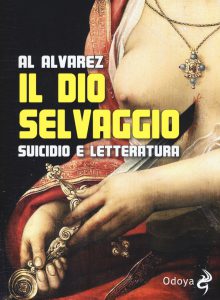 Giorgia Sbuelz
Giorgia Sbuelz
ROMA – Partendo dalla constatazione che forse metà della letteratura di tutto il mondo parla di morte, il poeta e saggista Al Alvarez affronta il tema nell’ opera Il Dio Selvaggio – Suicidio e letteratura – un classico uscito nel 1972, riproposto qui dalla casa editrice Odoya.
Come tiene a precisare l’autore, il suo “non è un lavoro sul suicidio nella letteratura, ma è sul suicidio e la letteratura”. Non analizza in che modo gli autori si siano sbarazzati di un determinato personaggio, bensì vuole venire a capo delle dinamiche di fascinazione che questo gesto ha suscitato nell’immaginazione creativa di chi l’ha compiuto, o solo tentato. Si parte quindi da una lettura storica, finendo per analizzare il carattere sociale e morale assunto dal suicidio nel corso dei secoli.
L’espediente per l’incipit di questa ricerca è una vicenda personale, il suicidio della scrittrice e amica Sylvia Plath. Chiarendo da subito che nessuna teoria potrà mai tributare le cause a monte di un gesto così ambiguo e complesso, Alvarez tenta una ricostruzione dei fatti così come egli stesso li ha percepiti. Una donna dall’innegabile talento – spesso azzittito per far luce al celebre marito Ted Hughes – astro nascente della poesia inglese. Impeccabile studentessa, impeccabile moglie, impeccabile madre e qualcosa che la logora dentro: un orrore che esorcizza nella potenza dei suoi versi, che richiama un lutto con cui si scontra quotidianamente, la presenza/assenza di un padre perso nell’infanzia e un ricongiungimento anelato, neppure tanto velatamente. Impeccabile, ancora una volta, prepara latte e biscotti ai figli che dormono al piano di sopra, dopodiché infila la testa nel forno prima che arrivi la baby sitter. Il gesto sconvolge Alvarez, si domanda perfino se quello di Sylvia fosse stato solo un gesto per richiamare l’attenzione sul male interiore che la stava guastando, finito poi tragicamente per la sfortunata tempistica che ha riguardato i fatti.
Da qui parte l’excursus che analizza il fenomeno nel corso dei secoli. Visto come una nobile alternativa in epoca romana, difeso da Seneca e valorizzato dallo stoicismo, fu portato allo stremo nella visione del martirio cristiano. Ascritto a peccato mortale nel Medioevo, un peccato contro Dio, nel Rinascimento le condanne verso il suicidio si ammorbidiscono, se non altro per una nuova insistenza sull’individualismo.
L’esempio migliore è fornito da John Donne, che scrisse la prima difesa del suicidio con l’opera “Biathanatos”. Idealizzato in epoca romantica, dove l’eroe suicida per eccellenza è il Werther di Goethe, così famoso da dettar moda e da esser ritratto perfino su porcellane cinesi. Rimbaud, invece, trova per sé la definizione di littératuricide, con quella smania di consumare presto la sua vita e il suo genio, mentre Dostoevskij introduce il concetto di suicidio logico: “Non posso esser felice a condizione del nulla che mi minaccia domani”.
Ma è nell’arte del XX secolo dove si sono prodotti dei passaggi estremi, rintracciabili sia nella guerra moderna sia nella crescente tecnologizzazione dei mezzi e relativa dispersione dell’individuo, che Yeats innalza l’altare per “ Il Dio Selvaggio”, espressione presa in prestito dallo stesso autore dell’opera qui presentata. Questo Dio Selvaggio è attaccato alle cose terrene e pretende sacrifici di sangue. A farne le spese gli intelletti più ricettivi: tutti quegli artisti tanto più dotati quanto più vulnerabili.
Se in precedenza si poteva discutere di suicidio caso per caso, da questo momento in poi l’impresa si complica: l’aumento vertiginoso di suicidi fra gli artisti sarà una delle caratteristiche più notevoli nel secolo prima del nuovo millennio. Virginia Woolf, Hart Crane, Dylan Thomas e Brandan Behan, Cesare Pavese, Majakovskij, Esenin, Marina Cvetaeva, Borowski e Hemingway. Per citarne alcuni. Ognuno con le sue argomentazioni.
A conclusione del lungo ragionamento sulla morte, un’altra vicenda personale. Il tentato suicidio dello stesso autore che, ingoiando una dose massiccia di barbiturici, si risveglia in un letto d’ospedale. E qui si chiude il cerchio aperto dalla scomparsa di Sylvia Plath. Nella sua personale osservazione di aspirante suicida, Alvarez è chirurgico, impietoso, raccoglie le prove per riorganizzare e comprendere la sintesi del gesto e della sua non riuscita.
Infine, una considerazione, per certi versi liberatoria dopo tanti dati e dubbi sollevati sulla fine dell’esistenza, in cui Alvarez proclama la sua rinascita, attraverso l’autodefinizione “ero morto”.
Sottinteso, ora non lo sono, non lo sono più.
Il Dio Selvaggio – Suicidio e letteratura è un libro intenso, più di una inchiesta letteraria e filosofica, perché coinvolge l’autore stesso come parte attiva, mai giudicante. Una scrittura densa, dove gli spunti riportano a un esercizio intellettuale costante: comprendere le dinamiche della morte volontaria significa infatti scomodare il proprio credo e quello di altri, ricomporre i costrutti socioculturali caratterizzanti di ogni epoca, ricollegare passaggi ed esonerarli da qualsiasi clamore. Quello di Alvarez è un lavoro composto, a tratti compassionevole, ma lucido al punto da trasmettere quel giusto rispetto per le vicende umane. La ricerca non è dettata dalla curiosità morbosa e non soddisferà le aspettative di chi è attirato dal morboso. Non ha la prerogativa di fornire delle risposte e non è una cronaca di morti illustri. E’ piuttosto una delicata indagine sulla condizione permanente delle arti, che basa i suoi fondamenti sul precario equilibrio di chi le esplicita: “… l’atomo intenso brilla per/un attimo poi cade spento in freddissima quiete”. (P. Shelley)





