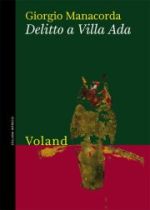Veruska Armonioso
 ROMA – “La mia capanna è nascosta
ROMA – “La mia capanna è nascosta
in una foresta profonda, di anno in
anno sempre più impenetrabile.
Non uno dei rumori del mondo
mi giunge se non, talvolta, il canto
lontano di un boscaiolo.
Quando splende il sole, mi rattoppo
il vestito.
Al chiaro di luna, leggo poesie.
Se mi è consentito un consiglio:
non perdete la vita a correre
dietro a tante inutili cose”
Ryokan
Avevo considerato per anni la mia vita come palco della mia essenza e le mie parole come manifestazione della mia vita, della mia intimità e della mia anima. Il mio percorso, le mie scelte, le mie paure, le mie forze, non provenivano che dal mio esperienziale e da un’eredità trans-generazionale che mi portavo dietro come una sorta di appendice invisibile, un joy stick che comandava i miei movimenti e le mie azioni. La mia vita era il mio paradigma e la mia mente era la mia maestra. Io potevo comandare con la razionalità ogni passo ed elaborarlo, intimamente guidata dalla saggezza della ragione ed esprimerlo con parole, all’occorrenza ferme e ponderate o vivaci e appassionate. Niente poteva interferire tra me e questo processo di esternazione, io avevo il controllo pieno e completo delle mie emozioni e della mia mente e niente sarebbe andato diversamente da come io avrei progettato per me. Avevo vent’anni.
Poi terminarono relazioni, rapporti di lavoro, famiglie. Cambiai case, uffici, letti, e scoprii le paure e che quello che mi portavo dentro non proveniva solo da me, che non era influenzato solo da me. “Devo aver vissuto altre vite, altrimenti perché tanto spavento? Le esistenze anteriori sono l’unica giustificazione del terrore. Solo gli orientali hanno capito qualcosa dell’anima[…] Espiamo in una sola vita il divenire dell’infinito.” (Cioran, “Lacrime e Santi”). Questo era quello che Cioran mi aveva suggerito e di cui mi ero lasciata convincere. Così avevo cominciato a pensare che doveva esserci qualcosa al di fuori di me o al di là di me, fosse anche una me antecedente o parallela, che influenzava tutte quelle paure che possedevo e che non avrebbero avuto ragione di essere se fosse dipeso solo dalla me “presente”.
Negli ultimi anni, però, una nuova paura era entrata a farsi largo. Questa paura, che non rappresentava più terrore verso qualcosa o verso qualcuno, inquietudine di vivere o di morire e nemmeno ansia di perdere qualcosa o qualcuno, era una paura inedita e, quindi, più spaventosa. Io avevo paura di essere derubata e temevo di incontrare sul mio cammino o, peggio ancora, di accogliere nella mia vita, dei ladri.
Era strano per me possedere questa paura, perché il furto era qualcosa di cui non mi ero mai curata molto. Capitava sovente che mi lasciassi derubare di qualcosa e, pur accorgendomene, decidevo di non oppormi. Mi ero accorta che ciò di cui venivo derubata cresceva progressivamente di valore; dapprima erano cose di poco conto tipo il tempo o favori, poi erano diventate cose sempre più preziose come il sorriso, le notti, fino ad arrivare al sonno, ai sogni e, infine, la speranza. I fantomatici “ladri” avevano sempre più approfittato di questa disponibilità-noncuranza e io li avevo lasciati fare, pensando di essere ricca abbastanza per provvedere, all’occorrenza, alle indigenze altrui e restare, comunque, a pancia piena. Fu, però, quando mi accorsi di non riuscire più a sperare in qualcosa che cominciai ad avere paura: l’indigente, adesso, ero io, a me non era rimasto niente, si erano portati via tutto. Così, costruii una fortezza dentro la quale mi barricai, senza un piano ben preciso, ma con il fermo intento di diventare irraggiungibile e, quindi, non farmi portare via più niente di ciò che mi era rimasto.
Ero ripartita con poco: qualche ambizione, un mezzo bicchiere di entusiasmo e un sacchetto da mezzo chilo di silenzio. Il silenzio era diventata la mia partenza. Con questi presupposti era molto facile restare da soli, ma non ne soffrivo perché ero disposta a restare senza persone pur di non restare più senza le ultime ricchezze che possedevo. Le parole erano un valore ed erano quanto di più prezioso mi fosse rimasto, così decisi di trattenerle dentro di me e di non usarle se non quando fosse davvero indispensabile. Come diceva Sandor Marai, chi avesse voluto comunicare con me, lo avrebbe potuto fare in un altro modo, in un modo nuovo. “Si può entrare in contatto con le persone anche senza parlare.[…] c’è un modo di entrare in contatto tra esseri umani più percettivo e affidabile della parola, fatto di sguardi, silenzi, gesti e messaggi ancora più sottili; è il modo in cui un essere umano nel suo intimo risponde al richiamo di un altro, quella silenziosa complicità che nel momento del pericolo dà alla muta domanda una risposta più inequivocabile di qualsiasi confessione o argomentazione, e il cui senso è semplicemente questo: io sono dalla tua parte, anch’io la penso così, condivido la tua preoccupazione, noi due siamo d’accordo…” (Sandor Marai, “Liberazione”)
Poi, accadde l’imprevedibile, perché “Le anime hanno un loro particolar modo d’intendersi, di entrare in intimità, fino a darsi del tu, mentre le nostre persone sono tuttavia impacciate nel commercio delle parole comuni, nella schiavitù delle esigenze sociali” . (Luigi Pirandelo, “Il fu Mattia Pascal”)
Qualcuno, zitto come me, cominciava ad affacciarsi e insieme a me restava zitto, cercando nuovi codici e nuovi modi per “entrare in intimità”. Così scoprivo che le mie paure erano anche le paure degli altri, che la paura di essere derubati è la più comune, ma è anche la meno facile da individuare. Che una volta che la scopri, cominci a vedere ladri ovunque. Ma scoprivo anche che se si ha paura di essere derubati, difficilmente si sarà in grado di rubare e, quindi, se si incontra qualcuno che ha paura di essere derubato, facilmente potrà essere un donatore e lo potrai lasciare entrare. Scoprivo che la mia mente poteva essere la mia maestra, ma che senza le mie paure non avrei imparato niente e che la paura era l’alleata più importante che avessi e che l’avrei sempre dovuta tenere vicino a me.
E così ricominciai a parlare. Perché le parole sono importanti. E ricominciai a parlare a voce alta, perché i suoni devono essere echi. E non ebbi più paura di parlare a tutta la gente, perché le parole, le mie parole, erano mie, anche se qualcun altro se ne fosse appropriato.
Perché se capisci che l’unica cosa che ti serve davvero per vivere non può essere rubata, i ladri non esistono più.
Fu così che mi aprii di nuovo alla vita.
“Avendo vissuto in solitudine e nella più totale indigenza, avendo rifuggito gli onori e gli intrighi della vita mondana, Ryokan divenne il monaco zen più celebre del suo tempo. Le sue calligrafie sono conservate nei musei, le sue poesie fanno parte di tutte le antologie. Ed ecco come gli fu ispirata la sua poesia più famosa.
In una fresca notte d’autunno, Ryokan dormiva sul suo eremo di Goggò-an. Svegliato da una ventata gelida, si accorse che la sua coperta era scomparsa. Alla luce madreperlacea della lune che rischiarava l’interno della capanna, scoprì che un ladro gli aveva portato via ogni cosa. […] Ryokan aveva capito che il ladro doveva trovarsi in un’indigenza ancora più grande della sua, visto che gli aveva trafugato anche la coperta rappezzata. Ma il Grande Idiota Misericordioso apprezzava sopra ogni cosa il poter contemplare l’astro notturno […] Allora, con un sorriso bonario, improvvisò questo haiku:
“Una cosa il ladro
Non ha potuto rubarmi:
la luna che splende alla mia finestra”
(Pascal Fauliot, “Racconti dei saggi del Giappone”)
 Luigi Scarcelli
Luigi Scarcelli