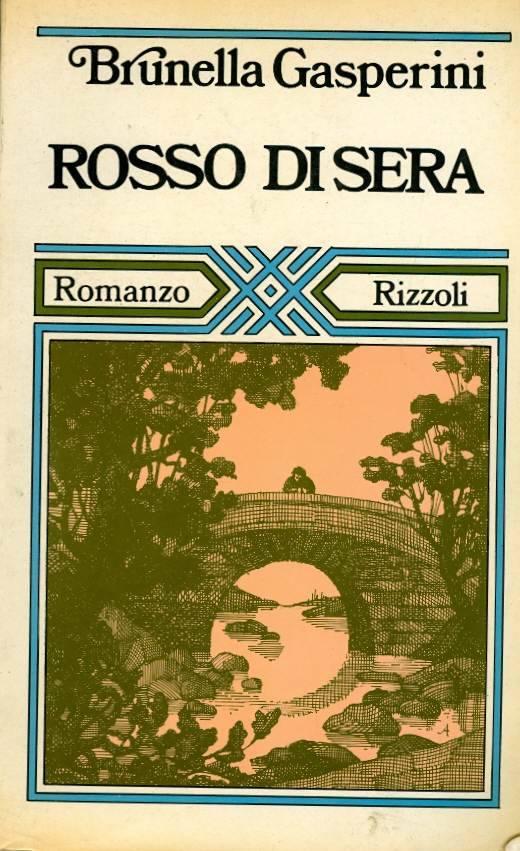 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Brunella Gasperini fu grande giornalista, di costume, di vita, di maniere gentili. Esplose nel 1963 alla scrittura narrativa proprio con “Rosso di sera” (Rizzoli), romanzo adolescenziale (ma definizione limitante) e di formazione, che suscitò non poco clamore nell’Italia agli esordi del boom economico. La storia che Brunella Gasperini ebbe il coraggio di presentare rompeva omertà e ipocrisie di una società oramai verso il collasso. I personaggi migliori sono il nonno anarchico e anticonformista, allontanato ed esiliato dal resto della famiglia borghese e bigotta (“Gli altri, mio padre, mia madre e i grandi in genere, ti parlano come se l’esser giovani fosse una colpa, o una buffa malattia, o almeno un transitorio accidente. Il nonno, solo guardandoti, ti rende cara la tua giovinezza, perfino nel momento in cui ti fa star male”); la donna abbandonata e sola, che cerca di combattere per la salvezza di sua figlia, una ragazza turbata e depressa, con una vita e una personalità decisamente borderline. Nel romanzo non si ha certo paura né tremori a evidenziare questi caratteri, queste alternative scelte. C’è già, in germe, la voglia della ribellione che poi esploderà di lì a pochi anni, con una contestazione che si farà ben più violenta ma spinta dalle medesime esigenze che compaiono in questa emozionante storia, narrata come una fiaba, come un sogno lungo una vita.
In Rosso, il ragazzo protagonista, c’è l’ansia di diventar grande ma non la fretta di crescere. C’è una maturità in doloroso e tumultuoso allestimento. C’è il primo incontro con l’amore: con una passione che, seppure vissuta da due adolescenti, non è sbadata né sbandata; ma è un amore covato con l’attenzione di cercatori d’oro, con sacerdoti che cercando di preservare una parte fragilissima di bellezza. E la passione d’amore, in Rosso, si unisce e si allaccia indissolubilmente all’amore per le poesie. Soprattutto quelle di un grande Pablo Neruda, tanto amato anche dal nonno anarchico. Ma ci sono anche altri poeti e poetesse, da Saffo a Sergio Solmi. Questo romanzo, nonostante gli anni siano trascorsi, non ha niente a che vedere con gli stanchi, sfibrati, banali, ipertrofici, volgari volgarissimi amori odierni di quattordicenni e quindicenni che confondono amore con altro e ignorano ogni possibile ricchezza di vera letteratura.
È una passione scriteriata, quella che Rosso nutre per letteratura e amore; un’ansia, un bisogno intimo e costante, quello della poesia. Che a sua volta si unisce a un amore (ritenuto persino inutile, dall’altra società) della musica: Rosso suona la tromba come fosse un arma, una bacchetta magica che lo può separare da tutte le volgarità, dallo sconforto, dal dolore. E, inevitabilmente congiunto con l’amore, c’è l’incontro con le prime delusioni, le prime frustrazioni, la sconfortante ansia delle ore che incalzano e che non sembrano mai dare requie. C’è il rimorso, un sentimento fin troppo adulto: così, infatti, Rosso si incolpa di non aver saputo fare altro che regalare alla sua amata “soltanto della letteratura”. E anche quando sembra che tutto non possa far a meno di ripiombare nei canoni consueti della società, immobilizzarsi di nuovo in quel mutismo, in quel borghese perbenismo soffocante, quando non sembrano praticabili altre strade che quelle della carriera benestante (maturità, università, fidanzata, matrimonio, figli…) la ribellione giunge, viene gridata senza voce; Rosso chiude il racconto della sua storia con una frase che diventa manifesto e programma: “No, non voglio dimenticare”.
Tag: Pablo Neruda
“Alture di Macchu Picchu”: là dove potremmo evitare la nostra “breve morte giornaliera”
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
ROMA – Tutti noi attendiamo la nostra “breve morte giornaliera”. Ogni ora, ogni battito che trascorriamo (in)consapevoli di noi, noi moriamo. Il concetto è antico, le disquisizioni sono state infinite. E tanti furon coloro che, a codesta ineluttabile condizione umana, cercarono di non sottomettersi troppo debolmente e offrirono vie di fuga, occasioni di rivalsa e di possibile vittoria. Pablo Neruda lo fece utilizzando il suo codice preferito e prediletto: la poesia. E lo fece scovando un esclusivo (e incredibile) angolo di mondo: le “Alture di Macchu Picchu” (Passigli, 2004) divennero, per lui, teatro unico e irrinunciabile della conservazione umana; un tentativo, insomma, per non tornar polvere e disperdersi nel vento, senza che rimanga alcuna traccia del sé stesso.
Lassù, su quelle alture gelose di sé stesse e straniere a qualsiasi sguardo, al riparo da ogni incombente assedio, lontane dalle notizie, dal pubblico, dalla frenesia del keep-in-touch, tutti vi potremmo ri-nascere, trasformati in fratelli. Lassù, dove le stagioni declinano il tempo, dove il sole e la luna comandano l’uomo, dove l’orologio si dimentica di ruotare, l’uomo curioso può persino esagerarsi essere perfetto, senza incertezze né dubbi, senza peccati da farsi perdonare né costanti crimini da dover scontare: “Io t’interrogo, sale delle strade, / mostrami il cucchiaio, lasciami, architettura, / rosicchiare con un bastoncino gli stami di pietra, / salire tutti i gradini dell’aria fino al vuoto, / grattare le viscere fino a toccare l’uomo”.
L’architettura di Macchu Picchu non è reale architettura, ma un’“architettura di aquile perdute”: è un “libro di pietra”, perché la pietra diventa natura, diventa il tutto che edifica l’uomo, che lo rende perfetto, che lo assiste in ogni sua azione e in ogni suo compito: “Attraverso la terra riunite tutte / le silenziose labbra disperse” e ritrovano la voce, riescono a raccontare di nuovo tutta la loro sapienza, tutte le loro esperienze così necessarie all’uomo per poterlo far giungere completo, uomo nel più profondo di ogni cellula: “Lasciatemi piangere ore, giorni, anni, / età cieche, secoli stellari”.
Macchu Picchu è “l’alto luogo dell’aurora umana: / il vaso più alto che contenne il silenzio: / una vita di pietre dopo tante vite”. E la pietra è la sola traccia che, dopo il suo trapasso, dell’uomo perdura. È la pietra il supporto su cui meglio si scrive e si deposita la memoria; è la pietra il pane; è la sorgente, la luce, è la “patria pura”, è “direzione del tempo”, in una litania che non conosce fine né distinzione tra sacralità e laicità, tra reale e immaginario, tra carne e fiato, in uno scontornamento evocativo di vocaboli, quasi formule alchemiche, che travasano la realtà nota e sovrappongono la pietra all’immagine e all’essenza stessa di Macchu Picchu.
“Datemi il silenzio, l’acqua, la speranza. // Datemi la lotta, il ferro, i vulcani. // Unite a me i vostri corpi come calamite. // Venite alle mie vene e alla mia bocca. // Parlate attraverso le mie parole e il mio sangue”: Macchu Picchu è la mèta ultima; oltre, non c’è che il non-sense del nulla.





