 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
ROMA – Più enigmatico di Bashō e, in un certo senso, più metafisico fu Buson. Nelle sue “Poesie” (Acquaviva, 2004) gli eventi naturali, gli scorci e gli spaccati di spontaneità colta, non sono così chiari, non son soggetti a una facile lettura. Ogni volta paiono caricarsi di valori altri, più oscuri e profondi di quanto non potrebbero accidentalmente parere: “La tenebra è così fonda / che si può persino sentire la neve / sfaldarsi”. In questa cornice, l’uomo diventa anch’esso più enigmatico e problematico, mai chiaro né semplice da risolvere e la natura finisce per diventare un mero espediente, privandosi della sua carica propulsiva: “Mi diverto a dipingere / un ventaglio da niente / con la linfa dell’erba”. Ma la natura sa essere anche protagonista, in un doppio ruolo che in Buson si fa addirittura stridente, per l’ampio potere di cui è dotata; la natura, infatti, sa anche nobilitare e soggiogare coi suoi incantesimi irresistibili: “Che luna meravigliosa, / il ladro si ferma / e canta”. È una natura che sa tracimare, che sa invadere tutti gli ambiti dell’uomo, regalando la sua magia dovunque, comunque, a chiunque: “Le rondini, / sotto le grondaie dei castelli, / sotto i tetti dei tuguri”. Sa persino la natura, in qualche caso, costituirsi panteismo inscindibile: “Pioggia d’autunno, / anche l’anima dell’uomo / se ne diventa una goccia d’acqua”.
Buson fu pittore eccellente e la continua e multipla sollecitazione sensoriale si fa evidente nei suoi haiku, che si materializzano come leste pennellate di colore, di corposa tinta: “Cadono i fiori di ciliegio / sulle acque delle risaie, / stelle in una notte senza luna”. Gli attimi si cristallizzano con una potenza sensoriale che forse mai prima di lui in queste schegge di componimenti era stata raggiunta: “Vento di primavera, / gli alberi di pesco / fremono di gemme”. Qualche astrattismo (“Il pesco d’inverno, / sembra uno spettro / arrabbiato”) e surrealismo (“Vorrei avere in mano / una farfalla, / come in un sogno”) poetico e pittorico anima la sua visione della natura e del mondo, in un connubio artistico che in lui manifesta pienamente i possibili punti di tangenza. Il viaggio anche per Buson è una condizione d’esistenza imprescindibile, irrinunciabile, che si può caricare di valenze complesse, fin anche opposte: “Guardo il fiume d’estate, / con i sandali in mano / son felice”.
Più dolente la poesie di Buson, più consapevolezza del tempo che passa e che passando priva l’uomo di opportunità, confinandolo nelle effimere consolazioni della memoria e del ricordo: “Ieri è già andato / oggi se ne va, / s’incammina via pure la primavera”. Più dolente la nota della solitudine, che si connota di riflessi quasi amari, come di un abbandono che non sia ricercato ma imposto, soprattutto quando si ricordano i vecchi affetti trascorsi: “Nella mia camera / calpesto il pettine che fu una volta / di mia moglie, un morso affonda nella mia carne”. E mentre l’attesa si fa vana, il rimpianto può avvelenare l’animo: “Sento lontano i rumori dei passi / sulle foglie morte / di chi sto aspettando”.
Tag: 2004
Quando l’arte è espressione dei bisogni della società
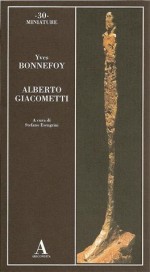 Michael Dialley
Michael Dialley
AOSTA – Ci sono tantissimi stili e movimenti artistici nella storia dell’arte. Si è sempre incasellato tutto in rigidi schemi, non chiedendosi, però, se sia davvero giusto definire un’opera d’arte, un artista, a seconda delle somiglianze e dei contributi di un movimento culturale. Può valere, questo, per alcuni artisti, soprattutto se molto legati a circoli culturali; ma per alcuni non si può fare, basti pensare a Rubens, a Caravaggio, a Mirò. E anche ad Alberto Giacometti. Originario della Svizzera italiana, nato nel 1901, Giacometti ha una concezione dell’arte che deriva solamente dalla sua visione del mondo, da come concepisce la realtà nella quale vive.
Ives Bonnefoy ci fa conoscere l’uomo-artista Giacometti grazie al saggio “Alberto Giacometti”, edito da Abscondita nel 2004, nel quale si può toccare con mano quanto la produzione artistica dell’artista sia profondamente legata ed influenzata dalla sua visione del mondo.
Si ripercorre tutta la vita dell’artista svizzero, toccando gli episodi della sua quotidianità, dai primi studi all’Accademia di Ginevra, all’adesione al gruppo surrealista della Parigi degli anni ’20, arrivando poi alla sua produzione matura, quando raggiunge una maggiore consapevolezza di sé stesso e della propria arte.
Quello che emerge è il ritratto di un artista profondamente angosciato, che si preoccupa di voler concretare la presenza, la vita in quanto essenza, che abita il corpo umano; argomento, questo, che attirerà nel suo piccolo atelier parigino molti intellettuali e letterati, tra i quali Sartre, non a caso il più grande esponente dell’esistenzialismo.
A Giacometti non interessa la figura da un punto di vista estetico, della forma, bensì vuole dare alle sue sculture la vita che alberga in ogni uomo. Per raggiungere questo obiettivo inizia rappresentando dal vero le figure che incontra; a un certo punto, però, le immagini gli appaiono distorte e utilizza la memoria, ricorda ciò che ha visto nella sua infanzia, nella sua adolescenza, avvicinandosi, così, alla componente più irrazionale e istintiva propria del circolo surrealista. Questo non è che una tappa, che porta l’artista a realizzare l’inafferrabilità della sua arte.
Ecco che inizia il suo grande lavoro, interiore ed artistico, di comprensione della vita, della condizione umana, della componente esistenziale: osserva il viso, lo sguardo delle persone, l’unico elemento che meglio di tutti coglie l’interiorità, l’intimità più profonda di ogni uomo. E, una volta trovato il punto focale, l’uomo cammina, procede, avanza, ma verso che cosa? Questo Giacometti non lo esprime, lui semplicemente vede l’uomo che va sempre oltre, che cerca sempre qualcosa, che nonostante le due grandi Guerre mondiali è riuscito ad andare avanti, a rialzarsi.
Questo ciò che ci racconta Bonnefoy e che raccontano, in maniera straordinaria, anche i due racconti scritti da Giacometti stesso, che sono riportati in appendice al saggio, “Il sogno, lo Sphinx e la morte di T.” e “Lettera a Pierre Matisse”.
Un artista da conoscere, che ci comunica qualcosa, che ci pone delle domande grazie alle sue opere, ma che non ci dà risposte, ma che anzi, invita ognuno di noi a giungere alle proprie conclusioni, in quanto crede che ognuno, dentro di sé, abbia le risposte o le potenzialità per trovarle.
E se l’uomo non fosse nient’altro che natura?
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
ROMA – La magia dell’haiku non è quantificabile nella sua semplice definizione. Un componimento breve, che parte da uno spunto naturale, e si configura in diciassette sillabe suddivise in tre versi: prima cinque poi sette poi cinque. La magia dell’haiku è data dal suo genuino potere di cogliere la scintilla, di cristallizzare il momento dell’energia e concretarlo lì, sulla carta, imprigionandolo nelle sillabe e modellando un ricordo che sia valido a discapito del luogo e dello scorrere del tempo. Bashō fu forse il più grande scrittore di haiku: la storia lo racconta e lo certifica la critica. Fu quello più legato alla natura e ai suoi impulsi poetici. Nelle sue “Poesie”, pubblicate nel 2003 dalla coraggiosa casa editrice pugliese Acquaviva, gli animali e le piante sono l’elemento imprescindibile della provocazione sensoriale, e diventano vettore trainante dell’intima scoperta umana: “È in fiore / il ciliegio centenario. / Il vecchio ricorda”.
La natura diventa anche il setting privilegiato per la scoperta, che avviene nella quotidianità più estrema ma che narra una storia più universale: “Mangiando ai piedi dell’albero / sulla minestra e sul piatto di pesce / cadono i petali di ciliegio”. La comunione tra uomo e natura è totale e non ammette deroghe né torti: “Io sono un uomo / che mangia il suo riso / in mezzo alle campanule”. Ma la natura trasmette soltanto calma e quiete, dolcezza e tranquillità. La natura è anche il luogo del dolore, che trova però sempre il modo di esser sublimato e, in un certo senso, arricchito di possibilità, di alternative: “In morte di un mio amico poeta // Scuotiti, tomba. / Il vento d’autunno / è la voce del mio lamento”. Perché la poesia Basho la ricerca nella vita quotidiana, appunto. La ritrova voltando lo sguardo, cogliendo gli aspetti della vita più semplice e pura: “Ah, come sto bene! / Ieri mi è passato ogni malore / dopo una zuppa di pesce palla”. E la ritrova, soprattutto, là dove la creatività umana e la potenza della natura si incontrano e, incontrandosi, riescono a unirsi e far gemmare qualcosa di speciale, di genuino: “L’inizio dell’arte: / la profondità della campagna / e una canzone piantando il riso”. Nella natura Bashō ritrova tutti i componenti dell’uomo, trova la possibilità d’una continua sorpresa, la promessa dell’inaspettato: “Sono stanco / e entro in una bettola. / Ci trovo fiori di glicine”. Trova persino una traccia perduta dell’amore, un desiderio rimasto incompiuto e chissà se mai avverabile: “Verrà quest’anno / la neve / che contemplai con te?”.
Sa bene, Bashō, che la poesia nacque con l’uomo, e che l’uomo con la poesia crebbe fino a superare sé stesso nelle sue previsioni, nei suoi intenti. Sa bene, Bashō, che la vita è una ricerca, un continuo esplorare per cambiare, nel tentativo ultimo di migliorare: “L’anno se ne va / mentre anch’io mi metto il cappello / e mi calzo le ciabatte di paglia”. Sa però ugualmente bene, Bashō, che la ricerca è solitudine, e che in solitudine si compie il viaggio: “Grande luna! / Ho vagato intorno allo stagno / per tutta la notte”. Ecco allora che gli ultimi suoi versi mai composti sono il suo testamento, la teorizzazione suprema di tutta la sua eterna ricerca, poetica e umana: “Ammalato nel mio viaggio / il mio sogno se ne va da solo / per le pianure desolate”.
“Alture di Macchu Picchu”: là dove potremmo evitare la nostra “breve morte giornaliera”
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
ROMA – Tutti noi attendiamo la nostra “breve morte giornaliera”. Ogni ora, ogni battito che trascorriamo (in)consapevoli di noi, noi moriamo. Il concetto è antico, le disquisizioni sono state infinite. E tanti furon coloro che, a codesta ineluttabile condizione umana, cercarono di non sottomettersi troppo debolmente e offrirono vie di fuga, occasioni di rivalsa e di possibile vittoria. Pablo Neruda lo fece utilizzando il suo codice preferito e prediletto: la poesia. E lo fece scovando un esclusivo (e incredibile) angolo di mondo: le “Alture di Macchu Picchu” (Passigli, 2004) divennero, per lui, teatro unico e irrinunciabile della conservazione umana; un tentativo, insomma, per non tornar polvere e disperdersi nel vento, senza che rimanga alcuna traccia del sé stesso.
Lassù, su quelle alture gelose di sé stesse e straniere a qualsiasi sguardo, al riparo da ogni incombente assedio, lontane dalle notizie, dal pubblico, dalla frenesia del keep-in-touch, tutti vi potremmo ri-nascere, trasformati in fratelli. Lassù, dove le stagioni declinano il tempo, dove il sole e la luna comandano l’uomo, dove l’orologio si dimentica di ruotare, l’uomo curioso può persino esagerarsi essere perfetto, senza incertezze né dubbi, senza peccati da farsi perdonare né costanti crimini da dover scontare: “Io t’interrogo, sale delle strade, / mostrami il cucchiaio, lasciami, architettura, / rosicchiare con un bastoncino gli stami di pietra, / salire tutti i gradini dell’aria fino al vuoto, / grattare le viscere fino a toccare l’uomo”.
L’architettura di Macchu Picchu non è reale architettura, ma un’“architettura di aquile perdute”: è un “libro di pietra”, perché la pietra diventa natura, diventa il tutto che edifica l’uomo, che lo rende perfetto, che lo assiste in ogni sua azione e in ogni suo compito: “Attraverso la terra riunite tutte / le silenziose labbra disperse” e ritrovano la voce, riescono a raccontare di nuovo tutta la loro sapienza, tutte le loro esperienze così necessarie all’uomo per poterlo far giungere completo, uomo nel più profondo di ogni cellula: “Lasciatemi piangere ore, giorni, anni, / età cieche, secoli stellari”.
Macchu Picchu è “l’alto luogo dell’aurora umana: / il vaso più alto che contenne il silenzio: / una vita di pietre dopo tante vite”. E la pietra è la sola traccia che, dopo il suo trapasso, dell’uomo perdura. È la pietra il supporto su cui meglio si scrive e si deposita la memoria; è la pietra il pane; è la sorgente, la luce, è la “patria pura”, è “direzione del tempo”, in una litania che non conosce fine né distinzione tra sacralità e laicità, tra reale e immaginario, tra carne e fiato, in uno scontornamento evocativo di vocaboli, quasi formule alchemiche, che travasano la realtà nota e sovrappongono la pietra all’immagine e all’essenza stessa di Macchu Picchu.
“Datemi il silenzio, l’acqua, la speranza. // Datemi la lotta, il ferro, i vulcani. // Unite a me i vostri corpi come calamite. // Venite alle mie vene e alla mia bocca. // Parlate attraverso le mie parole e il mio sangue”: Macchu Picchu è la mèta ultima; oltre, non c’è che il non-sense del nulla.





