 Michael Dialley
Michael Dialley
AOSTA – Le vite degli uomini creano reti invisibili che collegano le esistenze e intrecciano i sentimenti e le emozioni. Questo avviene anche a distanza di anni, decenni: vite apparentemente lontane, anche geograficamente, che si incontrano grazie ad altre esistenze. “Etica di un amore impuro”, di Alessandro Savona, edito da Edizioni Leima nel 2013, racconta proprio l’intreccio delle vite di uomini e donne, separate da molti anni, ma che si ricongiungono grazie a questa “corrispondenza di amorosi sensi” che è stata edificata.
Un amore fittizio che ha dato alla luce un bambino abbandonato alla madre e, ben presto, lasciato orfano; un amore forte, che resiste agli anni, alle difficoltà, alla “vita di strada”, ma che veniva (e purtroppo ancora oggi) considerato un “amore impuro”; legami di amicizia, progetti, idee che diventano ponte a collegare tutti questi diversi amori.
Un libro breve, che si legge con leggera scorrevolezza, ma che è davvero intenso e vissuto: molti rimandi geografici, paesaggi e scorci reali, dipinti con le parole cosicché per il lettore è spontaneo vedere nella propria mente le scene che avvengono a Parigi; sentimenti veri, sinceri, potenti che si possono toccare con mano, sentirne la consistenza e il peso.
Perno delle vicende è la figura di Roland Barthes: saggista e semiologo francese che ha vissuto la Parigi di metà Novecento; un uomo che ha avuto moltissimi incarichi e, grazie a questi, ha potuto viaggiare molto; e viaggiando sperimentando e conoscendo.
Savona permette in questo modo al lettore di apprendere e approfondire la consapevolezza di un importante letterato francese, analizzato nel romanzo sotto una luce diversa, nella dimensione più privata e personale della sua vita.
Alla conclusione della lettura, capiamo come le parole siano fondamentali: ma quali sono più giuste per raccontare un amore? Si può esporre con parole perfette l’armonia dell’imperfezione? Sono un po’ le riflessioni suggerite al lettore attento e che legge il romanzo non solo con gli occhi, ma anche con la mente e il cuore.
Tag: Michael Dialley
“Qual è il mio posto in quest’ordine?”
 Michael Dialley
Michael Dialley
AOSTA – Un baule, una stanza: questi i due luoghi dove Momo, africano inventato da Tahar Ben Jelloun in “Le pareti della solitudine” (edito da Einaudi nel 1997 ma scritto dall’autore nel 1976), nel quale l’autore s’identifica, vive completamente abbandonato a se stesso in una Francia razzista della metà del XX secolo. È una narrazione molto poetica, parti in versi e parti che sembrano un quadro tante sono le immagini visive che si creano nel lettore.
Questa poesia, comunque, non è casuale: come afferma Ben Jelloun, “soltanto la poesia, solo la finzione letteraria può essere in grado di dire e di far vedere e capire un uomo che soffre nel cuore, nel corpo, nella vita”.
Leggendo ci si rende davvero conto di quanto difficile e triste sia la storia di questi uomini; Momo dà voce a tutti loro, creando quadri, con le parole, dalle pennellate vigorose, potenti, cercando di richiamare il calore del sole, i colori e le tinte più vive; cercando, soprattutto attraverso i suoi sogni, di ricordare e far rivivere i sorrisi e la felicità tipici di questi popoli, dotati di una grande ricchezza interiore, smarrita dagli occidentali, ma che purtroppo viene totalmente ignorata e cancellata dalle violenze e dalle ostilità.
Costretti alla schiavitù, ad accettare condizioni di vita pessime, contratti che fanno rabbrividire tante sono le regole senza senso che travalicano e calpestano ogni singolo diritto umano (non si può nemmeno morire nelle stanze che vengono concesse a queste persone!).
Paradossalmente, però, più vengono sottomessi, più questi uomini sognano e sentono accrescere la voglia d’integrazione: Momo cerca di mescolarsi tra la folla, perché vuole “far parte di quella folla”, desidera “di esistere diversamente da un calzino bucato”.
Tanta sofferenza, fatica, tante rinunce, ma per cosa? Momo lo dice molto chiaramente: “Sono venuto nel tuo paese con il cuore in mano, espulso dal mio, un po’ volontariamente e molto per bisogno. Sono venuto, siamo venuti per guadagnarci da vivere, per salvaguardare la nostra morte, guadagnare il futuro dei nostri figli”.
Una grande solitudine vive nelle pareti di questi “bauli”, ma soprattutto nei corpi, nei cuori e nelle anime spente di questi uomini che rinunciano a tutto e tutti per il loro futuro e quello dei loro discendenti.
“I compagni del fuoco”: generazioni ai ferri corti
 Michael Dialley
Michael Dialley
AOSTA – Come reagiscono gli adulti, oggi, ai comportamenti e alle azioni delle nuove generazioni? Le risposte possono essere tante e svariate, alcune persino difficilmente indagabili. Nel romanzo “I compagni del fuoco”, edito da Laurana editore (2013), Ernesto Aloia vuole consegnarci la sua risposta, ponendosi l’obiettivo di raccontare la reazione di Valerio allo strano, e preoccupante, comportamento del figlio Seba.
L’indagine porta, però, a un inesorabile sgretolamento delle convinzioni e dei pilastri su cui il protagonista ha vissuto fino a quel momento, in ambito lavorativo, familiare e anche intimo.
È proprio questo il centro assoluto del romanzo: viene data importanza e visibilità al comportamento di Seba e al contesto nel quale vive Valerio, ma è la reazione di quest’ultimo a essere scandagliata e analizzata realmente, con grande attenzione e interesse.
“Compagni di fuoco” è un romanzo che da un lato contribuisce a dare risposte a interrogativi reali, ma può anche sconvolgere il lettore, mettendolo di fronte a una realtà che si tende a ignorare se non addirittura a fuggire. Proprio questo è in sostanza l’errore compiuto da Valerio nel suo percorso di vita: aveva e si era creato delle convinzioni, dei pensieri che poi nella realtà e soprattutto nel contesto dei primi anni del Terzo Millennio si sono rivelati sbagliati, antichi, vani.
Senza dubbio la generazione degli anni Sessanta e Settanta (per citare quella degli attuali genitori di adolescenti) ha una mentalità ben diversa, ma questo non significa certamente che tutti si sconvolgono di fronte a quella dei ragazzi del nostro nuovo millennio: credere nei propri valori e nelle proprie convinzioni è fondamentale, ma è necessario anche aprire la propria mente, abbattere le barriere, “uscire dagli schemi” per poter comprendere, e magari conciliare, il nuovo pensiero, la nuova società, le nuove idee.
L’assenza del mito e la rassegnazione
 Michael Dialley
Michael Dialley
AOSTA – Il mito è un idolo che le persone hanno come punto di riferimento e che utilizzano come modello da seguire nelle azioni quotidiane e come modello di vita. Avere un mito da seguire è stato fondamentale fin dalla nascita dell’uomo, ma lo è stato soprattutto per le generazioni degli ultimi anni.
Con “Post. 13 storie dopo l’89 che non sapevano di diventare mito”, edito da Lupo editore (2013), il curatore Paolo Paticchio pone l’accento sulla mancanza di veri miti negli anni ’90 da seguire per le generazioni attuali e, se alcuni sono stati miti, non sapevano che lo sarebbero mai diventati.
Ecco presentate quindi 13 storie, da altrettanti autori, che fanno conoscere al lettore 13 personalità, le quali hanno vissuto per creare qualcosa, combattere i mali della società, fornire ideali e perseguire scelte di vita.
Al centro si pone il problema del mettersi in gioco da parte delle persone: i veri miti degli anni ’60, ’70 e ’80 si mettevano in discussione, facevano scelte forti, controcorrente e soprattutto le urlavano al mondo esterno; i problemi erano chiari e le persone non avevano paura di mostrarsi e mostrare soprattutto il proprio disappunto.
Questo è ciò che i 13 autori-collaboratori del libro auspicano per le nuove generazioni: mettersi in gioco e non aver paura di esprimere le proprie idee; anzi, è dall’espressione dei propri pensieri che si può partire per migliorare la società, per risolvere situazioni e problemi che altrimenti continuano ad intaccare il nostro Paese.
È necessario porre domande e mettere in tavola le proprie carte, anche nel semplice quotidiano perché ciò che devono capire i giovani è che si parte dal piccolo per creare una vera “rivoluzione” che abbia i risultati cercati e concreti.
Ogni individuo può dare il suo contributo per migliorare la società e forse mai come ora abbiamo bisogno di esempi da seguire e di idee da sostenere.
Ciò che ci si deve chiedere, forse, è il motivo per cui dopo il 1989 le persone hanno iniziato a non avere più dei miti da seguire e come mai grandi e piccoli personaggi, come quelli presentati nel libro, non sono stati ascoltati e seguiti a sufficienza. Forse la sfiducia verso ogni cosa ha portato a questo risultato, o forse con il progresso e la tecnologia tutti sono incentrati su loro stessi, diventando più egoisti e non pensando al prossimo, all’altro, che ci sta accanto.
“Il ragazzo selvatico”: ChrL intervista Paolo Cognetti
 Michael Dialley
Michael Dialley
AOSTA – “Il ragazzo selvatico” abbandona la città per ritrovare se stesso, abbandona gli agi per “l’idea più assoluta di libertà”, la montagna. Di questo e di molto altro parliamo oggi con Paolo Cognetti, autore de “Il ragazzo selvatico” il libro edito da Terre di Mezzo e già recensito da ChronicaLibri la scorsa settimana.
Leggendo il suo romanzo mi sono chiesto più volte che cosa l’abbia spinta a raccontare e analizzare così concretamente la situazione della montagna oggi, nel 2013. C’è qualche avvenimento che l’ha spronata oppure è un suo semplice interesse?
“Il ragazzo selvatico” in realtà è un diario. Passo diversi mesi all’anno in una baita in Val d’Aosta: la prima volta fu un’esperienza di eremitaggio, ora per fortuna ho i miei amici e un po’ mi sono inserito nella comunità locale. L’amore per la montagna risale all’infanzia, quando ci trascorrevo l’estate. Da grande volevo provare a viverci in modo radicale, così non ho cercato una casa in paese ma su in alto, a duemila metri, tra gli ultimi boschi e i pascoli estivi. In primavera lassù non c’era davvero nessuno. In quella solitudine e in quel silenzio il bisogno di scrivere è arrivato spontaneo, e così è nato questo libro.
Il protagonista del romanzo parte da Milano per rifugiarsi in una baita in montagna: questo ritorno alle origini, alle cose semplici, al punto dove l’uomo ha iniziato a prendere consapevolezza delle proprie capacità, è un viaggio che dobbiamo fare fisicamente o, secondo lei, è un viaggio interiore, da fare con la nostra anima e la nostra interiorità?
Un momento. Per chi è nato in città, come me, la “vita semplice” non è uscire a spaccare la legna o zappare l’orto, ma prendere la metropolitana o bere un cappuccino al bar. Per le persone con cui sono cresciuto è più semplice girare di notte per Londra o Berlino che farsi mille metri di dislivello a piedi, e queste sono le nostre origini, così come quelle di un montanaro che si sente a suo agio in un bosco, o di uno che è nato al mare e fin da bambino nuota come un pesce. Per me la città non è caotica, angosciante, disumana; è sempre stata casa mia e per molto tempo ci ho vissuto bene. Poi ho sentito il bisogno di mettermi alla prova. Di stare da solo, vivere in un ambiente selvatico, usare il corpo, imparare ad arrangiarmi. Di certo c’era il fascino dell’avventura. Credo che uno possa fare un’esperienza del genere anche trasferendosi in una città straniera o imbarcandosi su una nave mercantile: ogni viaggio vero, e cioè rischioso, solitario, lontano dal mondo conosciuto, diventa un’esplorazione interiore.
 L’analisi della montagna è straordinaria, vengono messi in luce punti di forza e debolezze che, comunque, arricchiscono sempre l’uomo. Le Alpi oggi vengono vissute in due modi diversi e opposti tra loro: uno è l’atteggiamento nel voler conservare la montagna, facendola diventare un museo, un luogo di arretratezza, secondo una visione che l’ha condannata per moltissimi secoli; l’altro è quello della sempre più intensiva urbanizzazione per rendere appetibile la montagna a tutti i cittadini che, se si spostano, vogliono in ogni caso trovare le stesse comodità della vita in città. Secondo lei è possibile trovare una terza via?
L’analisi della montagna è straordinaria, vengono messi in luce punti di forza e debolezze che, comunque, arricchiscono sempre l’uomo. Le Alpi oggi vengono vissute in due modi diversi e opposti tra loro: uno è l’atteggiamento nel voler conservare la montagna, facendola diventare un museo, un luogo di arretratezza, secondo una visione che l’ha condannata per moltissimi secoli; l’altro è quello della sempre più intensiva urbanizzazione per rendere appetibile la montagna a tutti i cittadini che, se si spostano, vogliono in ogni caso trovare le stesse comodità della vita in città. Secondo lei è possibile trovare una terza via?
A me pare che la montagna di una volta sia finita per sempre, e questo non è un bene né un male. Nel senso che non era una vita più sana o felice della nostra, e infatti gli stessi montanari non sono più disposti a farla: non sono solo i cittadini a desiderare le comodità, su, proviamo a chiedere a un montanaro di oggi di rinunciare alla macchina o alla televisione o al cellulare, di salire in alpeggio a piedi, di lavorare senza mezzi a motore o di mangiare polenta e latte a pranzo e cena… D’altra parte, quando si parla di urbanizzazione, immagino ci si riferisca alle stazioni turistiche, perché il resto della montagna mi sembra tutt’altro che urbanizzata, anzi abbandonata, inselvatichita. I turisti vogliono piste da sci, alberghi, ristoranti, seconde case; i montanari vogliono lavoro perciò costruiscono quello che chiedono i turisti, e in più strade, dighe per fare un po’ di soldi vendendo l’acqua, impianti di risalita: questa è la montagna italiana degli ultimi cinquant’anni, un immenso cantiere edile, e non mi piace per niente.
Credo che adesso stia succedendo qualcosa di nuovo. Forse la terza via è quella di chi in montagna vuole andare ad abitarci, perché cerca uno stile di vita diverso. Gente giovane, che spesso ha una sensibilità ecologica più spiccata di chi ci è nato. Non tutti ci andiamo a fare i pastori o i contadini, a cercare una vita fuori dal tempo: tanti di noi ormai lavorano in rete, però sentono il bisogno di avvicinarsi alla natura e magari vogliono dare ai loro figli un ambiente diverso in cui crescere. Quali sono le esigenze di persone così? Io vorrei coltivare l’orto, però ho bisogno anche dell’adsl; adoro girare nei boschi ma devo anche raggiungere un aeroporto in tempi accettabili. Il prossimo autunno mi sposterò dalla mia baita in Val d’Aosta direttamente a New York. Ecco, vorrei vivere nella natura ma non fuori dal mondo. Le Alpi sono perfette in questo senso: un ambiente naturale magnifico, non lontano dalle grandi città e dal cuore d’Europa. Dovremmo salvaguardarle come un tesoro prezioso e allo stesso tempo renderle accessibili, attrezzate per lavorare e abitarci. Per me il futuro è questo.
Quanto c’è di suo all’interno del romanzo? Sono situazioni e luoghi di fantasia o reali?
Come dicevo non c’è nulla di inventato. Sono vere le persone, i luoghi e le cose che mi sono capitate. Ho omesso il nome del paese, ma credo che almeno la zona sia facilmente riconoscibile per chi frequenta questi posti. L’unico elemento di finzione è che la mia avventura nel libro dura sei mesi, da maggio a ottobre; nella realtà sono stati diversi anni.
Quali sono le 3 parole che, come scrittore, preferisce?
Le parole mi piacciono tutte, sono gli uomini che le sviliscono. Provo pena per quelle che, per essere troppo frequenti nell’uso, perdono di significato. E ancora di più per le parole delle frasi fatte e dei luoghi comuni, parole che abbiamo ridotto a gusci vuoti. Ogni volta che ne scriviamo una dovremmo ricordarci che cosa vuol dire davvero, e restituirle il suo valore.
“Il ragazzo selvatico” e la montagna come specchio dell’anima
 Michael Dialley
Michael Dialley
AOSTA – “Il ragazzo selvatico” è il nuovo romanzo di Paolo Cognetti, pubblicato da Terre di mezzo editore: racconta di un ragazzo che dalla città è partito per andare a ritrovare se stesso, ritrovare le sensazioni vissute da bambino, in montagna. È un viaggio reale quello che il ragazzo ha intrapreso, ma dalla lettura emerge il potere straordinario della montagna, delle sue difficoltà e delle sue bellezze, che rispecchiano appieno l’interiorità dell’uomo alla ricerca di qualcosa, nella speranza di raggiungerla.
La vita cittadina è frenetica, caotica, mentre nel romanzo si dice che la montagna rappresenta “l’idea più assoluta di libertà”. Si cerca, quindi, un ritorno a ciò che è semplice ed essenziale; tra le molte citazioni, potenti e belle, di cui è disseminato il romanzo, c’è anche il manifesto di Thoreau, filosofo e scrittore statunitense del XIX secolo, in cui si racconta: “Andai nei boschi perché volevo vivere secondo i miei princìpi, per affrontare solo i fatti essenziali della vita, per vedere se fossi capace di imparare quanto essa aveva da insegnarmi, e per non scoprire, in punto di morte, di non aver vissuto”.
Una montagna che è sia immagine da cartolina, fatta di scorci stupendi, paesaggi e panorami incontaminati che si possono solamente trovare nei sogni, ma anche una montagna sempre più urbanizzata: purtroppo è il destino delle Alpi in questi anni, andare incontro a una sempre maggiore urbanizzazione per creare un terreno di gioco per i cittadini che vanno in vacanza.
Sempre più spesso si dimentica il valore della montagna, valore che i montanari sentivano nel profondo del loro animo e che nel romanzo emerge grazie a questa fuga dalla città in cerca degli antichi valori e delle emozioni infantili vissute; ma anche una presa di consapevolezza dell’importantissimo lavoro che nei secoli è stato fatto: “Il paesaggio intorno a me, dall’aspetto così autentico e selvaggio, fatto di alberi, prati, torrenti e sassi, era in realtà il prodotto di molti secoli di lavoro umano, era un paesaggio artificiale tanto quanto quello della città”.
Nei secoli questo lavoro è stato graduale, ma ha cercato sempre di non stravolgere l’aspetto della montagna. Oggi, però, c’è l’amara consapevolezza della realtà e la modernità viene raccontata così: “Con la fine del ‘900 arrivò anche quella del vecchio albergo: venduto, demolito e ricostruito per farne un condominio”. Ciò che rattrista, però, è che “di quel luogo, come scriveva Stern, sono rimaste ora solamente queste mie parole”.
Questo romanzo breve, ma intenso e denso di significati, è un’analisi della realtà delle Alpi, di ciò cui vanno incontro e di come la visione della montagna sia diversa, tra un montanaro e un cittadino e turista.
“L’horror è un contenitore che può più di altri toccare corde essenziali dell’animo umano”: ChronicaLibri intervista Claudio Vergnani
 Michael Dialley
Michael Dialley
AOSTA – Un viaggio particolare in un’Italia popolata da zombie: questo il contesto del nuovo romanzo di Claudio Vergnani, “I vivi, i morti e gli altri”, uscito da poco per la Gargoyle Books.
Tinte fosche, luoghi misteriosi e rumori sinistri provocati da quelli che sembravano morti, sono invece gli ingredienti che tengono il lettore vigile e attento a tutti i dettagli.
ChronicaLibri ha intervistato l’autore per cercare di capire cosa c’è dietro questo romanzo e per dar voce a chi ha dato la luce a quest’avvincente storia.
Ha scritto una saga di vampiri, prima de “I vivi, i morti e gli altri”: che cosa l’ha avvicinata agli zombie? Come mai ha incentrato il nuovo romanzo su queste creature?
Né i vampiri né gli zombi hanno molta importanza per me: mi servivano solo per creare uno sfondo horror conosciuto dove poter raccontare soprattutto altro.
“Ritengo che l’horror sia un contenitore che, se usato adeguatamente, può più di altri toccare corde essenziali dell’animo umano”: queste le parole che ha usato in un’intervista per definire il genere horror.
Nel suo nuovo romanzo emerge la fragilità del protagonista, Oprandi, che viene quasi schiacciato dalla realtà, dalla società composta da cannibali: è questo, forse, un ritratto dell’uomo odierno e del mondo reale, trasposto ed enfatizzato poi nella realtà horror?
Di solito sfuggo le metafore. Spesso sono banali o ambigue. Ma certamente Oprandi si muove in un mondo che è solo un passo avanti al nostro, e infatti lo interpreta lucidamente in tutta la sua miseria, ignoranza, ingiustizia e pericolosità. Paradossalmente, pur essendo un uomo con tutte le carte in regola per crollare definitivamente, l’essere un figlio di questi nostri tempi gli sarà d’aiuto per non smarrire definitivamente sé stesso nel momento della catastrofe e dell’orrore.
Crede che il genere horror possa essere uno strumento utile alle persone per evadere, visto il periodo storico nel quale viviamo oggi?
È difficile da dire. Potrebbe sembrare di sì, ma i risultati delle vendite tendono a dire il contrario. Forse i tempi senza speranza in cui viviamo spingono maggiormente il lettore verso il fantasy, dove i buoni soffrono ma poi vincono, i cattivi vengono umiliati e sconfitti, e mille creature soprannaturali ma perbene ispirano al lettore la possibilità di un mondo magari ancora sconosciuto, ma decisamente migliore e più giusto di quello reale.
Una persona mi ha detto “leggi e rilassa la mente”, ed effettivamente la lettura ha, su di me, quest’effetto; a lei in che modo la lettura aiuta? Perché consiglierebbe alle persone di leggere un buon libro?
Me l’avesse domandato anche solo due anni fa mi sarei detto d’accordo, e avrei spiegato il perché. Oggi, le confesso, non lo so più. Qui in Italia la maggioranza dei lettori non legge, si limita a scorrere con gli occhi un insieme di parole che altri hanno scelto per loro. Non acquistano un libro, acquistano un autore, per pigrizia, per abitudine, per sentirsi rassicurati. Forse un giorno la gente tornerà a leggere, e allora, chi lo sa, potrò rispondere diversamente alla sua domanda, se le parrà ancora d’attualità.
I lettori, ormai, la conoscono nel genere horror: in quale altro genere le piacerebbe impegnarsi? Sta già lavorando a qualche altro progetto?
È uscito in questi giorni un thriller, Per ironia della morte, dove cerco ancora una volta di inserirmi in un genere, con amore e rispetto delle sue strutture classiche, e per poterlo poi rinnovare dall’interno con il mio stile considerato drammatico, profondo e ironico nello stesso tempo.
Come scrittore, quali sono le tre parole che preferisce?
Me ne basta una: quella giusta, schietta e sincera che arriva dritta al cuore e alla mente di un lettore attento e intelligente. Quella parola è tutto. Perché, come dico sempre, un romanzo è solo un’opera parziale, al quale solo un lettore attento e ricettivo può dare il soffio della vita, portandolo con sé nel suo mondo, arricchendolo con la sua partecipazione, le sue considerazioni e, perché no, con il suo amore. A mio parere è tutto qui, tutto quanto qui.
Un nuovo viaggio tra “I vivi, i morti e gli altri”
 Michael Dialley
Michael Dialley
AOSTA – È un’Italia, un mondo, dove gli uomini devono combattere contro il popolo dei non-morti, gli zombie, che stanno prendendo il sopravvento e si stanno moltiplicando all’ennesima potenza: uno scenario, insomma, che richiama quella tradizione del XIV secolo legata ai “Trionfi della morte” che si trovano nel panorama artistico e letterario del tardo medioevo.
Claudio Vergnani torna nelle librerie con “I vivi, i morti e gli altri”, per la casa editrice Gargoyle books, per raccontare questo mondo caduto nel caos totale; è una lettura scorrevole, che permette un momento di evasione e di “stacco della spina” dal caos reale che regna, oggi, nella società.
Oprandi, il protagonista, è un uomo di mezz’età, che ha fatto ormai la sua vita e che ha il vizio dell’alcool: ex combattente, la sua attività attuale è uccidere gli zombie, dar loro l’eterno riposo che la morte dovrebbe concedere ad ognuno.
Sono situazioni difficili, agghiaccianti, con immagini crude e suoni: sì, vengono descritti nei dettagli i moltissimi rumori che questi cadaveri fanno nei cimiteri, nei loro loculi, nelle casse; da un grattare continuo e costante a mugolii ed urla vere e proprie.
Ma non è solamente questa “non morte” la protagonista del romanzo, anzi: la chiave dell’intero racconto è Oprandi, la sua anima, la sua psicologia, i suoi sentimenti. È un uomo straziato dalla solitudine e dal dolore e cerca di reagire a queste difficoltà nel migliore dei modi, ma soprattutto con i mezzi che ha; in un momento di particolare crisi, però, ogni volta arriva qualche aiuto: dalla signora che prega per lui e gli dona una medaglietta di San Cristoforo, fino ad un incarico che, sì è molto difficile e complesso, ma che promette la tanto agognata luce in fondo al tunnel.
Durante questo incarico il protagonista vivrà situazioni estreme e di estrema difficoltà, ma conoscerà anche la passione, l’aiuto di persone estranee, l’amore per una ragazza che sarà costretto a abbandonare, il dolore della perdita. Oprandi ha una missione che lo porta a camminare sempre sul filo che separa il mondo dei vivi da quello dei morti, ma che gli fa riconoscere quanto, a volte, siano meglio i cannibali bramosi di carne (che non hanno più un’intelligenza, ma rispondono solo alla loro fame) rispetto a quegli uomini, ancora vivi, che hanno perso qualsiasi umanità (ma che sono assolutamente in grado di pensare ed agire secondo la ragione); emerge, infatti, la crudeltà fine a se stessa, la parte peggiore dell’uomo in momenti di estrema difficoltà e drammaticità.
Estremo silenzio ed estrema solitudine, alternati a caos, rumori, spari ed incendi: su questo dualismo si snodano le vicende del romanzo, che permettono al lettore, piano piano, di entrare sempre di più in quella realtà e, soprattutto, in Oprandi.
Il più grande inquisitore di ogni essere umano.
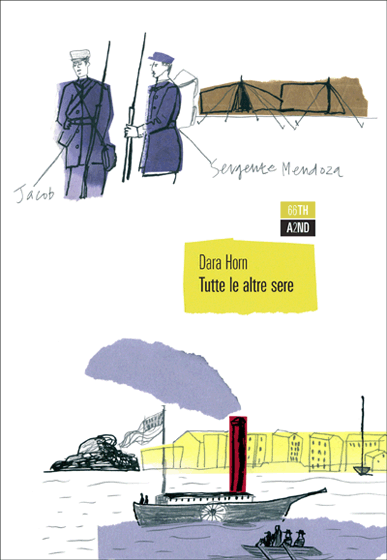 Michael Dialley
Michael Dialley
AOSTA – “Le guerre vanno e vengono, giovanotto. Vanno e vengono, e noi andiamo e veniamo con loro. Sono come il tempo, come una tempesta o una siccità. E noi non possiamo fare altro che cercare riparo e aspettare che passino”: è una frase che sicuramente identifica appieno il periodo nel quale è ambientato il romanzo: gli anni Sessanta del XIX secolo, a ridosso della Guerra civile americana che coinvolgerà moltissimi uomini, nordisti e sudisti; ma che si può applicare a ogni epoca, anche ai nostri anni.
Il romanzo “Tutte le sere” di Dara Horn, edito da 66thAnd2nd nel 2013, è una lettura molto piacevole che fa conoscere la realtà di quegli anni nella “lontana” America; si conoscono le situazioni familiari di Jacob Rappaport e delle persone a lui legate, ma al contempo grande importanza è data alla società del tempo, alla condizione degli schiavi neri acquistati all’asta come oggetti.
La guerra è al tempo stesso cornice storica che inquadra l’epoca, ma anche motivo scatenante degli eventi della vita del giovane Jacob, che intraprende la carriera militare per evitare un matrimonio ebreo, un vero e proprio contratto firmato prima della cerimonia, e per intraprendere poi missioni segrete contro le spie. Dapprima accetta di assassinare lo zio, poi deve sposare una bellissima ragazza sospettata di essere una tramite tra varie spie e complotti; tutto questo, però, pian piano lo porta a concretare i capricci di altri, più potenti, che rimangono nascosti, commettendo non solo crimini veri e propri, ma anche un crimine, molto peggiore, contro la sua coscienza e la sua libertà di scegliere cosa è giusto e cosa è sbagliato.
È difficile vivere in tempi così tragici e particolari come la più sanguinosa guerra combattuta dall’America: non ci si può fidare di nessuno, anzi, ci si scontra con realtà agghiaccianti, criminalità, menzogne e con la paura, soprattutto, di essere usati come oggetti ed essere, appena possibile, accoltellati alle spalle. Questo è sintetizzato da una frase che colpisce per la sua banalità, per la sua semplicità, ma soprattutto per la sincerità con la quale viene pronunciata: “Io voglio qualcuno che si fidi di me, non ho mai voluto altro”.
Eccolo lì, espresso, concretato, il desiderio più grande di Jeannie: essere amata, creduta, avere accanto a sé qualcuno di cui si possa fidare e a cui possa affidarsi completamente. Ma lei non è altro che portavoce dell’intera umanità: avere una spalla, un pilastro, cui poggiarsi e reggersi in qualsiasi momento, perché l’uomo è un essere estremamente forte, ma al tempo stesso fragile, con un’interiorità colma di paure e debolezze, che da solo non riesce, quasi mai, a vincere. Che sia grazie ad un compagno, ad un amico, ad un familiare, ad uno specialista, tutti hanno bisogno di guardare in faccia la realtà ed affrontare i problemi, ma anche la propria coscienza, il più grande inquisitore con cui si debba fare i conti.
“112 motti che portano alla fine del mondo”
 Michael Dialley
Michael Dialley
AOSTA – “Durante l’ultima persecuzione che subirà la Santa Chiesa Romana, regnerà Pietro il Romano. Egli pascerà le pecore fra molte tribolazioni. Passate queste, la città dei sette colli sarà distrutta, e il Giudice tremendo giudicherà il popolo”: questo dovrebbe essere ciò che spetterà all’uomo e, in particolare, alla Chiesa cattolica a breve, dopo l’elezione del successore di Benedetto XVI. Nello specifico è il 112° motto in latino che chiude la profezia di Malachia, così come racconta il saggio “I segreti della profezia di San Malachia” di Jean-Luc Maxence, edito da Bompiani nel 2000: il lettore viene accompagnato nella comprensione di questa profezia, a lungo studiata e che, così come ogni questione legata in qualche modo al soprannaturale, crea ipotesi e congetture.
Sono motti che identificano ciascun papato, partendo dal 1143 fino all’ultimo, collocato genericamente tra il 2000 e il 2031/2032; tale profezia in realtà è stata resa pubblica solo nel 1595 e non si conosce la vera natura di questi oracoli, tant’è che nel saggio non si analizzano quelli che sono precedenti al 1595, proprio perché potrebbero essere stati scritti postumi ai pontificati.
È straordinario pensare a come qualcuno abbia potuto scrivere questi incisi, spesso di poche parole, che raccontano un intero papato, ma è ancora più stupefacente quanto, anche dopo 400 anni dalla pubblicazione della profezia, questi motti possano coincidere effettivamente con il pontefice al quale si riferiscono: ovviamente si tende a pensare al pontefice in quanto singolo, ma Maxence ci aiuta a comprendere quanto in realtà ci si riferisca al papato e, talvolta, al periodo che coincide con un determinato governo pontificio. È un viaggio attraverso i secoli, attraverso tutti i successori di Pietro che rende il lettore partecipe della vita del Vaticano, affascinante e misteriosa: l’autore cerca di contestualizzare i motti analizzando il papato e la personalità del pontefice in questione e ne emerge per ciascuno un ottimo ritratto, nonché un’analisi sintetica ma efficace delle varie fasi della storia della Chiesa cattolica nei secoli. Durante ogni conclave ecco rievocata la profezia; addirittura nei secoli precedenti (e sicuramente per l’elezione di Clemente VIII, negli anni di pubblicazione della profezia) si utilizzavano questi motti per condizionare il risultato dell’elezione, mentre poi dal Settecento si è guardato a questi come una linea guida da mantenere durante il pontificio regno.
Oggi, nel 2013, ecco che viene ancora tirata in ballo la profezia di questa figura misteriosa, vaga, di San Malachia (importante personalità del XII irlandese), proprio in occasione dell’imminente conclave che ha due aspetti piuttosto inconsueti e nuovi: il primo l’elezione di un nuovo pontefice in seguito alle dimissioni, e non alla morte, del precedente; il secondo legato alla profezia stessa, in quanto questo sarà l’ultimo papa della storia della Chiesa cattolica.
Può affascinare, o far sorridere: l’autore ne dà un’interpretazione il più possibile legata a fatti storici concreti; nulla è dato all’immaginazione e alla pura congettura; ognuno ne tragga ciò che crede, riconoscendo, però, l’aspetto suggestivo che questa profezia porta con sé da 418 anni.





