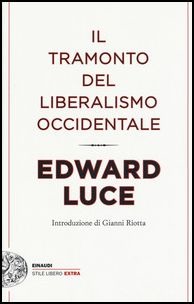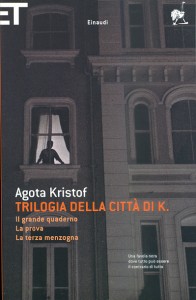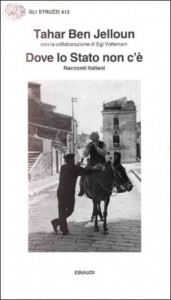Marianna Abbate
Marianna Abbate
ROMA – È giusto spiegare ad un bambino l’orrore del lager? È giusto che un bambino sappia quali siano le infamie di cui l’uomo è capace? Mostrare ad un innocente che le guerre, gli stermini, non sono solo parole lontane legate a una cultura diversa dalla nostra, a un mondo dominato da leggi diverse dalle nostre, ma che le stesse cose succedono da noi che ci vantiamo di essere culla della democrazia?
Annete Wieviorka non ha dubbi. Lei, storico del ‘900, che convive ogni giorno con il tema dello sterminio degli ebrei si prende carico di questa responsabilità. Auschwitz spiegato a mia figlia è stato un caso editoriale, in Italia è pubblicato da Einaudi, a cui molti si sono interessati.
Molti adulti hanno letto per la prima volta di quello che succedeva nella cittadina polacca di Oswiecim, vicino alla vecchia capitale Cracovia e così vicino a Wadowice, dove nacque Giovanni Paolo II. Perché di Auschwitz molto sappiamo e non sappiamo niente.
È giusto chiamarlo campo di concentramento? Che differenza c’è tra Auschwitz e Birkenau? I tatuaggi facevano male? Perché volevano sterminare gli ebrei?
Domande naif alternate a domande concrete, come solo un bambino sa fare. Ma forse in quelle domande semplici si nasconde la verità.
Facevano male i tatuaggi? Sì, erano una ferita inguaribile. Non tanto per quella puntura inflitta con aghi di dubbia provenienza (ah i problemi dei nostri tempi, così igienici), ma per il loro significato. Per quello che quell’ago ti rubava: il tuo nome, la tua identità, il tuo posto nel mondo. Molte famiglie di sopravvissuti o morti ad Auschwitz usano tatuarsi il numero portato dal loro parente internato, per non dimenticare quel dolore.
Perché è sbagliato dire campo di concentramento, campo di lavoro? Questo termine è abbastanza corretto in riferimento ad Auschwitz I, ma non ad Auschwitz II- Birkenau. Il campo di Birkenau era un centro di sterminio. I convogli arrivavano e le persone scendevano in file ordinate. Si spogliavano seguendo l’ingannevole promessa di una doccia, e morivano sotto il venefico effetto del terribile gas Zyklon B. Arrivavano, scendevano e morivano. A volte qualcuno veniva scelto. Fortunato, viveva qualche giorno, qualche mese, prima di morire di fame, di freddo.
Se pensiamo ad Auschwitz, pensiamo ai sopravvissuti. È la cosa più sbagliata che possiamo fare. I sopravvissuti sono un errore, sono uno scherzo del sistema. Non dovevano esserci sopravvissuti ad Auschwitz. Quando le truppe entrarono a liberare il campo, videro ombre di persone, videro quello che gli internati chiamavano musulmani: persone in fin di vita, ridotte a pelle e ossa che vagavano nel campo. Quanti di quelli ancora vivi alla liberazione sono sopravvissuti al loro stato? E quanti sono riusciti a sopportare il peso di quello che hanno vissuto.
Si potrebbe pensare che Primo Levi sia un sopravvissuto. Abbiamo tutti letto il suo libro, abbiamo visto le sue foto in tarda età. Eppure Primo Levi è morto in quel campo. E come lui molti di quelli che abbiamo chiamato salvati. Persone che non hanno saputo liberarsi dall’orrore di ciò che hanno vissuto, e che hanno vissuto la vita dopo il campo come fantasmi. Strappati alle proprie case, unici rimasti di famiglie numerose.
Spiegate Auschwitz alle vostre figlie, spiegatelo ai vostri figli.