 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Negli anni ’60 Beirut era considerata la Parigi del Medio Oriente: erano gli anni in cui i divi del cinema affollavano le passeggiate lungo mare e i banchieri e finanzieri controllavano i traffici bancari bivaccando tra palazzi, cocktail bar e languide spiagge. Poi dalla fine degli anni ’70 e per tutti gli anni ’80 Beirut si tramutò nel teatro di scontri e bombardamenti furiosi e feroci: “Ognuno aveva diritto alla sua bomba”. Una terra martoriata e perseguitata, bersaglio incolpevole di furie avverse e di scelte unilaterali.
L’artista Zena El Khalil, che ha vissuto in Nigeria, negli Stati Uniti e in Italia, decise un giorno di tornarsene ad abitare nella sua Beirut. E ha raccontato il suo rapporto conflittuale con la sua città in “Beirut, I love you” (Donzelli editore, 2009). Il libro è piuttosto un rivivere tramite flash, scene, inquadrature particolari, il suo legame mai estinto né consumato con Beirut, per diventare un incessante canto d’amore, struggente, alle sue radici, alla sua identità che si concretano nel destino crudele di Beirut stessa, nella sua predestinazione alla sofferenza. Prova a viverne lontana, Zena. Prova a cercare di essere sé stessa anche in altre metropoli, dedicandosi al lavoro, alla sua arte, ai rapporti, ai legami. Ma dopo l’11 Settembre ecco che si sente straniera dovunque: e decide che l’unico orizzonte da cui guardare il mondo è là da dove proviene.
Beirut è lo scenario ma si configura anche come protagonista della storia. Ne è la burattinaia e l’attante. È terra di abbandoni dolorosi, di ricordi feroci. Ma è proprio in questa terra arsa, bruciata, che pare più facile far germogliare anche la poesia, far ri-nascere le pulsioni vitali che ogni volta, bomba dopo bomba, vengono messi a dura prova ma covano pulsanti e forti sotto le macerie, sotto i cieli sporchi di incendi e di fumi, come una necessità sottopelle di rivalsa, come un coraggio perenne di risollevare la testa che non conosce domatori né dominatori e che punta sempre alla vittoria finale.
Perché su Beirut pare abbattersi un destino sempre avverso, crudele, rabbioso e feroce. Come Oriana Fallaci la dipinse nel suo “Insciallah”, nei primi anni ’90. Come un carnaio; pulsante vita e avventure, paure e tranelli. Beirut è dominata da pulsioni contrastanti e divergenti: la morte e la vita, lo splendore e la tenebra. A Beirut tutto è difficile; ma per questo, ancora più appassionante. Zena El Khalil, invece, confida che i venti e i destini avversi riescano a trionfare e a riconsegnare Beirut a un nuovo inizio, a una nuova storia che sia di felicità e di serenità; una nuova narrazione di fiducia e nuova consapevolezza, di arte e di cultura, di orizzonte larghi e di prospettive aperte come il cielo e il mare che la incorniciano. Ed è in questo contesto, in questa città che è nido e trappola, tana e prigione, che Zena compirà il suo percorso di consapevolezza fino alla rivelazione ultima: “Sono così lontana dalla morte”.
Tag: 2009
Le favole e poi l’ultimo viaggio di Antoine de Saint-Exupéry
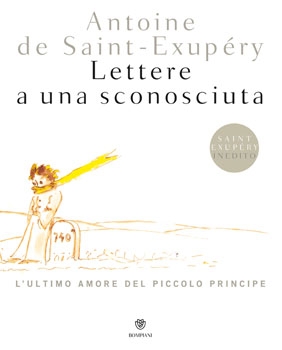 Dalila Sansone
Dalila Sansone
AREZZO – “Ma se mi va di dimenticare il suo dimenticare e di inventarmi un sogno?”. Già, se a volte volessimo dimenticare e immaginare una realtà diversa? Non per illusione, solo per smettere di non credere più e non correre il rischio di pensare che di qualcosa non sia valsa la pena? Vale sempre la pena, anche solo per inventarsi un sogno.
Non mi sono mai chiesta che fine avesse fatto il Piccolo Principe, se se ne fosse tornato dalla sua rosa o fosse invece rimasto, per sempre bambino, a stupirsi delle illogicità di presunti adulti. Faccio l’errore di molti e lascio i “personaggi” tra la lettera maiuscola della prima pagina e il punto dell’ultima, nel loro eterno presente senza trascorsi e destini con cui riempire pagine non scritte.
Antoine de Saint-Exupéry quel suo Piccolo Principe se lo portava dietro, ché in fondo era un po’ lui, era la parte invisibile di lui; così, quando prima di partire per l’ultima missione (Algeri 1943), la incontra in Algeria, su di un treno un giorno qualunque e agli schizzi di un piccolo principe biondo che lascia raccontare, parlare, chiedere, spesso non capire. Le “Lettere a una sconosciuta” (Bompiani, 2009) sono una bella raccolta degli ultimi fogli sparsi dell’autore del libro più venduto al mondo, acquerelli e righe scarabocchiate. Sulle pagine scorrono qualche frase o lettere per una donna, sposata, algerina che smette di rispondere al telefono e non avvisa se decide di non presentarsi ad un appuntamento. Non c’è nessun filo che collega il bambino che sulla carta parla per l’uomo al libro che li ha resi entrambi liberi dallo scorrere del tempo e dalla dimensione materiale dell’esistenza. Si, perché tra quei pochi pezzi di carta, invece, ci sono proprio il tempo e l’essere esistiti, lì in quel momento. Ci sono emozioni semplici che parlano delle illusioni, di quando le illusioni pretendono che si guardi alla realtà con la logica dei fatti e delle conseguenze.
“Le favole sono fatte così. Una mattina ti svegli e dici: ‘Era solo una favola…’. Sorridi di te. Ma nel profondo non sorridi affatto. Sai bene che le favole sono l’unica realtà della vita.” Sentire riesce quasi sempre a vivere la disillusione e a trovarci dentro la ragione profonda del sentimento, che è fatto di una natura diversa dalla logica; sopravvive a sé stesso come sensazione ed è quella la realtà: la sensazione che non si spiega, non si descrive, capace com’è solo di restare. A volte il piccolo principe continua a non capire, arriva persino a rinunciare, a farlo credendo che sia inutile, distraendosi di amarezza. Ma poi succede anche a lui di rendersi conto che l’essenziale non è invisibile agli occhi, l’essenziale è semplicemente parte di te. Esiste. È inutile credere che si possa restare per sempre bambini, illudersi che l’ingenuità di cui si nutre l’immediatezza delle emozioni sia duratura… però è così stupidamente adulto non custodirne gelosamente la tenerezza!
“Madam Butterfly”: la donna che attende e poi decide.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – La storia è quella nota dell’opera lirica di Giacomo Puccini, del 1904. L’aveva scelta perché affascinato dalla tragedia di David Belasco, vista a Londra. Fu la sua prima “opera esotica”, sulla scia di un entusiasmo per l’Oriente che stava contagiando tutte le arti della vecchia e stanca Europa. Fu nell’apoteosi del sacrificio femmineo dell’opera che la gloria di Madama Butterfly, ovvero la gheisa Cho-Cho-San, raggiunse l’acme della notorietà, la consacrazione nell’olimpo delle figure straordinarie delle arti. Ma forse in pochi sanno che l’origine dell’opera (e della tragedia) è una novella, di John Luther Long, edita nel 1898, che Avagliano editore ha ripubblicato nel 2009 nella collana “La straniera”. E forse in pochi sanno che la novella ha un finale agli antipodi della trasposizione operistica.
La novella di John Luther John ha degli aspetti che ancora la mantengono valida e preziosa, nonostante l’ipoteca di Puccini sulla storia e sulla figura della geisha lontana: il ritratto di Cho-Cho-San, nella novella, è fresco, leggero, soave. Fuori da complesse macchinazioni psicologiche, più facilmente riscontrabili nella tessitura di musica e parole, Long ha saputo in poche pagine plasmare un ritratto femminile di inaudita potenza e complessità, pur utilizzando sempre uno stile e un linguaggio semplici e diretti.  Lo scarto tra la Cho-Cho-San di Long e la Madama Butterfly di Puccini si consuma tutto alla fine della vicenda, nel momento in cui i destini delle due trovano soluzioni diverse.
Lo scarto tra la Cho-Cho-San di Long e la Madama Butterfly di Puccini si consuma tutto alla fine della vicenda, nel momento in cui i destini delle due trovano soluzioni diverse.
Cho-Cho-San si concreta come il paradigma della donna perennemente in attesa, della donna illusa, della donna rimasta bambina nel mito di un uomo che la possa amare, che la tratti come una regina, che la conservi al riparo dal mondo crudele che sta al di fuori delle mura domestiche. Come se codeste mura fossero il luogo più sicuro del mondo: ma già ai suoi tempi, nei suoi luoghi remoti ed “esotici”, le più atroci violenze si consumavano proprio all’interno della famiglia. Cho-Cho-San di famiglie ne avrebbe perse due: quella dei suoi familiari, della sua stirpe, della sua gente che la condanna per aver cercato di contravvenire a leggi ataviche e tradizionali. Si è innamorata di un uomo straniero, di un dominatore, di un invasore. Con lui ha concepito un bambino. Non si può meritare altro che l’abbandono, l’esilio. Ma Cho-Cho-San perde anche l’altra famiglia, perde il suo amore, proprio lui che l’ha allontanata dall’altra famiglia. Il destino di Cho-Cho-San pare segnato, pare dettato e condizionato dalla sofferenza, dalla colpa, dalla menzogna.
Ed è qui che John Luther Long rende Cho-Cho-San moderna, progressiva, orgogliosa e indipendente: si avvicina la decisione del suicidio, estrae la spada, “l’unico oggetto, fra tutti quelli appartenuti a suo padre, che i suoi parenti le avevano concesso di tenere”, si colpisce il petto, “il rivolo di sangue che le era sceso nel seno divenne di una tinta più scura e si arrestò”. Cho-Cho-San decide di vivere: decide di non concedersi al sacrificio per un uomo che invece di amarla l’aveva violata, insultata, offesa. Si salva grazie a suo figlio, si salva perché una scintilla in lei esplode e l’incendio divampa. Se non proprio simbolo di femminismo e di rivolta al maschilismo imperante, Cho-Cho-San è figura profetica, antesignana di sentimenti che a fine Ottocento eran forse prematuri ma proprio per questo sorprendenti in codesta novella. E così cantò, profetica, anche Fiorella Mannoia: “Ma scapperò via da qui / da questa casa galera / che mi fa prigioniera”.
“Il diritto alla pigrizia” nei nuovi anni Dieci.
Giulio Gasperini
ROMA – Potrebbe sembrare un affronto in questi tempi di crisi riproporre un saggio che esorta alla pigrizia; che condanna il lavoro e la sua feroce ricerca. Paul Lafargue fu scrittore e teorico d’economia sfrontato e coraggioso, senza remore né timori di brandire le sue estreme convinzioni e di farle bandiera di un presunto progresso. “Il diritto alla pigrizia”, che la toscana Piano B edizioni ci ha riproposto nel 2009, è un saggio acuto ma scomodo, che tira in ballo paure e inquietudini che finiscono per paralizzare e terrorizzare.
Paul Lafargue, nato a Cuba e formatosi in Francia, abbracciò fin da subito le idee socialiste di Proudhon e sposò Laura, la figlia di Karl Marx, insieme alla quale si suicidò, in una fredda compostezza borghese, annunciando l’ineluttabilità della sua decisione: “Sano di corpo e di mente, mi uccido prima che l’impietosa vecchiaia mi tolga uno a uno i piaceri e le gioie dell’esistenza”. Inderogabile nelle sue decisione, Lafargue; implacabile e senza concedersi appelli. Come è il suo saggio, pubblicato sui giornali, articolo dopo articolo, a partire dal 1880. Già la frase di apertura, sulla quale si basa tutto lo svolgimento della sua ipotesi, è agghiacciante e spiazzante: “Una strana follia si è impossessata dei lavoratori delle nazioni in cui domina la cultura capitalistica. […] Questa follia è l’amore per il lavoro – è la moribonda passione per il lavoro – spinta fino all’esaurimento delle forze vitali dell’individuo e della sua progenie”. Non c’è appello a questo: il lavoro è dannoso, perché allontana gli uomini dalla Natura, dalla condizione di Buon Selvaggio che, teorizzata da Rousseau, pareva essere la sua declinazione migliore, la più perfetta e compiuta. “Anche gli antichi greci non provavano che disprezzo per il lavoro”. L’ammonimento di Lafargue è apocalittico, catastrofico: “Introducete il lavoro di fabbrica, e addio gioia, salute, libertà: addio a tutto ciò che rende la vita bella e degna di essere vissuta”. Perché il lavoro produce merce, e la merce finisce per restare invenduta, producendo una stagnazione economica che si tramuta in povertà umana, perché l’uomo, inserito in un vortice senza possibilità di uscita, è costretto a dover produrre sempre più. La soluzione, per non fermare la vorace ansia dell’uomo lavoratore, sarebbe quella di “obbligarli a consumare le merci che producono”.
L’otium sarebbe la panacea, la più perfetta delle condizioni. Ma l’otium, nella contemporaneità, non ha più possibilità di affermarsi, di diventare una possibile condizione umana, come nell’antichità greco-romana. L’età contemporanea, ormai, è corrotta e contaminata. “Ogni miseria individuale e sociale proviene dalla sua passione per il lavoro”: più perentorio di così.





