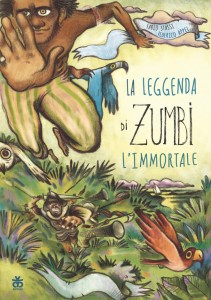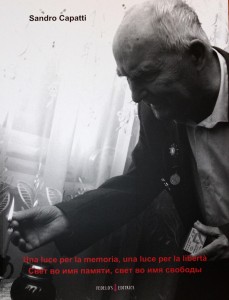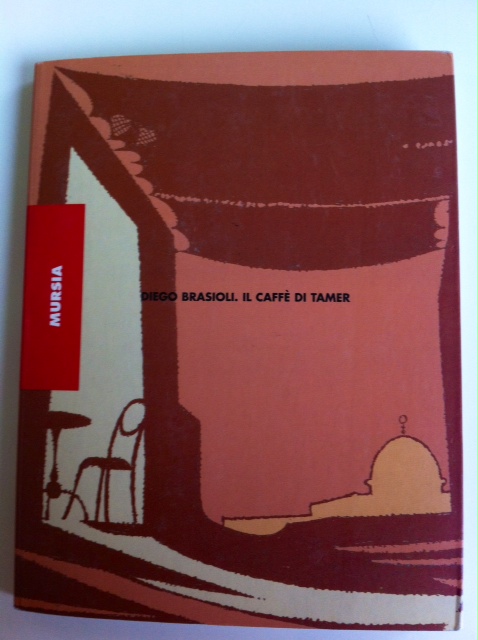Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – In quest’epoca di social espansi all’inverosimile, di comunicazioni immediate, a tempo di un semplice click, di fotografie, filmati e documenti colti dal vivo, quale spazio ha ancora il fotogiornalismo? Pare essere questa la domanda che sta all’origine di Il sudario di latta, il taccuino di guerra del giornalista Ugo Lucio Borga, edito dalle Edizioni Marcovalerio nella collana “I Faggi”.
In particolare, con le Primavere arabe il mondo ha scoperto le potenzialità della documentazione 2.0. Tutti, con un semplice cellulare, possono riprendere, fotografare, inviare milioni di documenti nel web. E tutti, con un semplice click, possono usufruire di quest’enorme patrimonio di informazioni. Il confine con il fotogiornalismo è, però, ancora piuttosto evidente, come testimonia anche “Il sudario di latta”. Innanzi tutto, il fotografo è un giornalista, che spesso ha una conoscenza molto approfondita della zona dove si trova e nella quale sta lavorando. La sua, pertanto, non è una semplice documentazione, spesso colta solamente nell’istante dell’accadimento, ma diventa una testimonianza ragionata, condotta con un criterio e con una chiave di lettura che possa aiutare e sostenere il lettore, non lasciandolo abbandonato e sommerso di materiali che senza un’accurata preparazione finiscono soltanto per travolgerlo. Il giornalista, se bravo e competente, sa anche raccontare, sa spiegare, sa narrare.
In più, il fotogiornalista è un artista; un artista che ha una sua chiave interpretativa (perché ogni giornalista dà un’interpretazione, veicola un punto di vista), che ha una sua poetica, una sua concezione della realtà e una sua percezione della storia. E proprio quella regala al lettore, chiamato così a confrontarsi con numerosi codici comunicativi.
“Il sudario di latta” ci fa conoscere tre scenari particolari di guerra: la Siria, la Libia e la Somalia. Tre luoghi di entità statali distrutte, di furia brutale, di cieca e incontrollata violenza. Quelli di Ugo Lucio Borga sono appunti, scritti nell’immediato o a distanza di tempo: sono dunque sia vergati impulsivamente sia rielaborati dalla lucidità che soltanto la lontananza e la separazione danno. Danno l’affresco potente di tre scenari complessi e multiformi, difficili. Non raccontano solamente, però: cercano anche di capire e spiegare l’uomo, senza mai giustificarlo né condannandolo; semplicemente, descrivendolo, narrandolo e provando a capire le sue reazioni, i suoi motivi, le sue scelte a volte profondamente drammatiche. A sostegno delle parole, le fotografie, il vero miracolo di queste esperienza al fronte. Perché la fotografia di Borga non è mai banale: coglie attimi non sempre, e non necessariamente, topici, decisivi; anche lo sguardo su una quotidianità, in questi territori di lotta, che spesso finisce poi inghiottita nella follia vorace e nella dimenticanza di tutto il resto (indifferente) del mondo, è fonte preziosa di documentazione.








 Giulia Siena
Giulia Siena