 Luca Vaudagnotto
Luca Vaudagnotto
AOSTA – Nessun altro titolo pareva più azzeccato di questo per introdurre “Luce istantanea” (Edizioni della Meridiana), del regista russo Andrej Tarkovskij (1932-1986), un libro da leggere e guardare. Si tratta, infatti, di una raccolta di Polaroid scattate in Russia e in Italia sui set di alcuni film celeberrimi (Lo specchio, 1974, e Nostalghia, 1983), corredate da appunti, pensieri trascritti e annotazioni che permettono al lettore di penetrare la poetica di questo immenso cineasta. E poetica è il termine più giusto per presentare questa raccolta, edita da Ultreya nel 2002, perché la poesia, e nello specifico la poesia della luce, è il fil rouge che unisce non solo queste piccole immagini dense e ricchissime, ma tutta la produzione del Tarkovskij regista.
In queste immagini, così intense ed evocative, Tarkovskij utilizza la luce come un elemento denso, materico, capace di modificare ogni cosa che colpisce e illumina, per veicolare i significati e i temi fondanti della sua ricerca artistica: troviamo, dunque, il topos della famiglia, nei ritratti della moglie e del figlio, trattenuti dal regime sovietico durante il suo viaggio in Italia, quello della casa, che si esprime attraverso gli sguardi sugli interni, i raggi di sole che trapassano le finestre, i mazzi di fiori di un giallo luminosissimo sui tavoli, le pieghe molli delle tende ombreggiate dal tramonto, o ancora l’archetipo dello spazio personale, del guscio, dell’intimità, dei luoghi dell’anima nelle fotografie di paesaggi, alberi e steccati, fiumi e cespugli, che circondano la casa del regista. Luoghi, oggetti, persone che raccontano al lettore, mediante la poesia di queste immagini che diventano per volere del loro autore una guida, un ponte verso altri significati, la nostalgia dell’esilio, la condizione precaria dell’uomo, l’importanza della memoria.
Tutto, infine, è intriso di una certa religiosità, che è difficile definire ma che Tarkovskij richiama continuamente, anche nelle sue parole: si avverte la presenza dell’assoluto, di un approccio religioso, ma di cui non è dato sapere di più. Queste polaroid diventano così icone, nel senso più autentico della parola: tutto ciò che ci circonda, attraverso la luce, è apparizione, immagine di un’entità suprema da cui siamo tutti, seppur inconsapevolmente, illuminati.
Tag: 2002
“Il caffè di Tamer”, un luogo perfetto che non c’è.
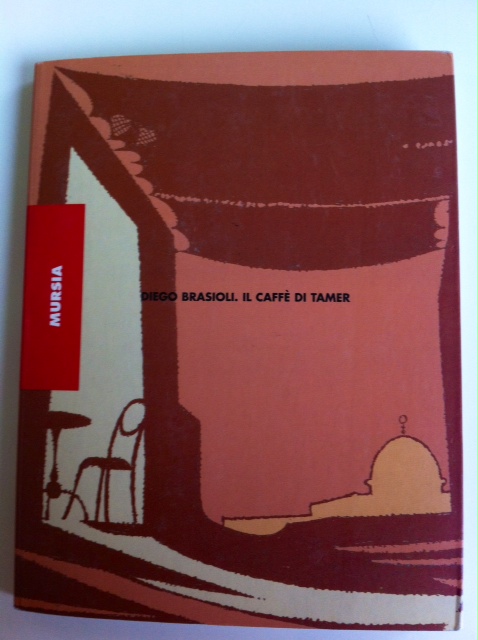 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Diego Brasioli conosce il Medioriente. Ci ha trascorso molti anni, come ambasciatore per l’Italia a Beirut. E ha conosciuto gli spettacoli della guerra, la devastazione, la complessità umana e sociale dei conflitti che per decenni lunghissimi hanno martoriato questa piega di mondo. Ed ha conosciuto persone vere, con un volto, un timbro vocale, una storia di migrazioni. In “Il caffè di Tamer”, edito da Mursia nel 2002, Brasioli squaderna una storia di amicizia dal valore altamente simbolico, come soltanto nel contesto della guerra sanno concretarsi.
Dori Goldman è statunitense, ebreo. Come tanti, prima di lui, si trasferì in Israele; tanti si sentirono in dovere di condividere la sorte dei loro “fratelli” di religione, altri pensarono che fosse la cosa giusta da fare; altri ancora, come Dori, andarono quasi per caso e scoprirono che lì, per ragioni sconosciute e non chiare, si sentivano a casa. Quando lui arrivò era il 1963: anni cruciali per il neonato stato. Si trasferì in un “quartiere di arabi ed ebrei dove in fondo non vi erano mai state fratture”, a conferma di come la storia sia spesso falsata e resa inesatta da giornalisti e storici dello scoop. La pace, in Palestrina (o Israele), è sempre esistita, perché gli uomini, al di là del Potere, sanno convivere e superare le differenze. Dori adora passeggiare per i quartieri della Gerusalemme vecchia, una città che possiede un’energia sovrumana, quasi mistica. Qui, in questo luogo di millenarie sofferenze ed epifanie, Dori conosce Tamer, un arabo proprietario di un modestissimo caffè, ma che diventa l’ombelico del loro mondo, il luogo più sicuro sulla terra, quello dove si costruiscono i veri sentimenti e si rafforzano i rapporti di amicizia e amore. Da dove, soprattutto, si contempla con sguardo critico l’evolversi degli eventi.
Anche durante gli episodi della Seconda Intifada, inaugurata all’alba del nuovo millennio, il loro rapporto non si incrinò, fino all’inevitabile epilogo, che un po’ è atteso ma non per questo perde il suo valore ultimo di teorema umano, che non ha bisogno di nessuna spiegazione né dimostrazione. Anche grazie a uno stimolante espediente narrativo. Il finale è, infatti, presentato all’inizio, in un “cielo accanto alla terra”; come se la fine fosse proprio il principio: la preghiera del rabbino ebreo e i versetti del Corano, cantati dall’amico, si allacciano insieme e si fondono in una preghiera unica, universale, che canta lo stesso uomo e i suoi stessi bisogni, le sue stesse urgenze: “Gerusalemme ricorda i giorni della sua miseria e del suo vagare, / tutti i suoi beni preziosi del tempo antico; ricorda quando il suo popolo cadeva / per mano del nemico e nessuno le porgeva aiuto”.
Il tempo nemico che nulla restituisce.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – L’ultima edizione è del 2002, per Mondadori. Ma le “Poesie” di Dario Bellezza mancano da troppo tempo dagli scaffali delle librerie. Una delle voci più potenti e spregiudicate della poesia italiana del Novecento, Bellezza ha sempre vissuto straziato dal conflitto tra la “vita tempesta” (e la sua declinazione dell’amore) e la morte, complice anche una malattia a cui lui si è condannato (Dario, “vittima e carnefice” di sé stesso) e che l’ha lentamente consumato nel suo “vecchio corpo rotto da malattie”.
Dario appartenne al genere degli uomini che vivevano di notte e che nella notte trovavano la loro unica missione e il loro unico compimento: “Ogni alba è una resurrezione, ritorno / alla pluralità, ma noi abitatori della notte / non arriveremo mai all’amore / della nostra decadenza!”. La solitudine è la condizione sostanziale che si materializza a ogni livello: “Addio. Tradiscimi con chi / ti pare”; persino a quello artistico (“Morta è la poesia”). La solitudine è, inoltre, la condizione che tesse la “pigra quotidianità”. La vita è tiranna, il vivere è il “suicidio più lento”; ma la vita non è altro che azione quotidiana dopo azione quotidiana, in un ritmo soffocante e asfissiante: “Abbracciato all’enigma / del futuro chiudendo in povertà i giorni / tutti uguali con il cuore a registrare / su un misero giaciglio in una casa / presa in affitto i puerili battiti / d’amore che mai più proveremo, così / sentimentali, così audaci nello sperpero / della pubblica energia”. È un concetto, questo, che in Bellezza si concreta ripetitivo e quasi ipnotico, straziante nella sua ineluttabilità: “Ma il quotidiano insiste […] / […] / Insiste così / il quotidiano […] / Insiste dunque il quotidiano […]”.
Ineluttabile e inappellabile è principalmente la morte: “Ché solo morte / esiste e a lei m’affido”. I rapporti di Bellezza sono sempre stati di intenso amore, nonostante la consapevolezza di essere un peccatore, perché “il giusto non aspetta certo / a Sodoma”. La sua fine tragica fu presentita: “Ascoltavo la morte nel mio sogno / […] / Allora mi ricordai di te e mi svegliai. / La morte mi era a lato. La notte / riempiva la stanza di silenzio. / Alla finestra la luce della luna. E // nel mio cuore un presentimento”.
La vergogna più grande, pel poeta, è quella di non aver vissuto, di aver fatto trascorrere i giorni tra le dita, come sabbia di clessidra; adesso non rimane che stringere l’aria: “Una vita sprecata. La più pura di tutte / fu quella addormentata che non vissi / da vivo, ma ritornando a casa, già adulto / intravidi nello specchio di tutte le brame / […] / Fermati tempo, restituisci il passato!”. La confessione dell’uomo (prima ancora del poeta) è straziante, senza appello: “Ho paura. Paura di morire. […] / Devo prendere atto di questo: / che si è un corpo e si muore”. Ma è la morte che, segretamente, e paradossalmente, ha reso l’uomo un poeta: “Ora alla fine della tregua / tutto s’è adempiuto; […] / Così / senza speranza di sapere mai / cosa stato sarei più che poeta / se non m’avesse tanta morte / dentro occluso e divorato, da me / orrendo infernale commiato”.
Solo “Quattro ore a Chatila” per sopravvivere all’inferno.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Quanto tempo si può trascorrere all’inferno? Jean Genet ce ne trascorse quattro, il 19 settembre 1982; e l’inferno fu il carnaio di Chatila; soltanto un paio di giorni prima, tra il 17 e il 18, i miliziani cristiani, fedeli al presidente libanese Gemayel, per vendicare la morte del loro capo, fecero irruzione a Sabra e Chatila, i due campi profughi palestinesi a Beirut Ovest. Jenet fu il primo occidentale a entrare e le sue “Quattro ore a Chatila” (Stampa Alternativa, 2002) diventarono un inno alla contestazione della violenza inspiegabile, del cieco furore che colpisce senza ragione. “Qui, tra le rovine di Chatila, non c’è più niente” racconta Genet: non c’è più niente di vivo, tra le rovine di Chatila. C’è tanta morte, però; tante istantanee pazzesche e inspiegabili: “Da un muro all’altro di una via, curvi o inarcati, i piedi contro un muro e la testa appoggiata all’altro, i cadaveri neri e gonfi, che dovevo scavalcare, erano tutti di palestinesi o libanesi”. Gli israeliani erano fuori: avevano chiuso i campi, avevano collocati posti di osservazione sui tetti, ufficialmente per proteggere i profughi palestinesi dalle violenze dei libanesi, ma non mossero un dito di fronte all’invasione delle milizie cristiano-falangiste: “Il massacro di Chatila si è compiuto nel brusio o nel silenzio totale, se gli israeliani, soldati e ufficiali, sostengono di non aver sentito nulla, di non aver dubitato di niente mentre occupavano questo edificio?”. Anzi; alcuni li accusarono di aver fatto luce sul campo, per facilitare la violenza degli invasori, girando la faccia dall’altra parte per fare finta di non vedere: “Al bagliore dei razzi rischiaranti israeliani, ogni orecchio israeliano, da giovedì sera, ascoltava Chatila”.
I cadaveri, a Chatila, erano muti, le bocce piene di terra, gli occhi vuoti di cielo: “La donna palestinese era probabilmente vecchia, perché aveva i capelli grigi. Stesa sul dorso, posata o abbandonata sui sampietrini, mattoni, sbarre di ferro ritorte, senza cura. Il volto nero e gonfio, rivolto verso il cielo, una bocca aperta, nera di mosche, con denti che mi sembravano bianchissimi, volto che, senza che un muscolo si muovesse, sembrava sia accigliarsi, sia sorridere o gridare di un grido silenzioso e ininterrotto”. Le immagini che testimoniano la carneficina sono agghiaccianti, incomprensibili nella loro ferocia, ma non riescono a dare il giusto peso della realtà: “La fotografia non coglie le mosche, né l’odore bianco e greve della morte. Non racconta il salto che si deve fare quando si passa da un cadavere all’altro”. Non c’è neppure nulla che, in luoghi del genere, dovrebbe essere naturale: “Ciò che mancava, in quel luogo, me ne sono accorto allora, era la scansione delle preghiere”. Chi pregare, in quella situazione? A chi rivolgere parole di supplica e di pietà? Nella violenza si perde la misura, si smarrisce il storia, si snatura l’essenza: “La solitudine dei morti, nel campo di Chatila, era ancora più tangibile perché avevano gesti e pose di cui non erano responsabili. Morti non importa come. Morti abbandonati”. Perché a Sabra e a Chatila non sono morti soltanto i profughi palestinesi, ma siamo morti tutti, responsabili morali delle violenze: “L’odore della morte non veniva né da una casa né da un suppliziato: sembrava uscire dal mio corpo, dal mio essere”.
Ma i morti, grazie alla testimonianza, sanno anche parlare: la loro presenza pesa e significa: “Un bimbo morto, a volte, può bloccare le strade, che sono così strette, quasi sottili e i morti sono così tanti”. Genet si schiera dalla parte dei palestinesi, per lui privati di una terra e costretti a difendersi dall’assalto degli invasori: “La lotta per una terra può riempire una vita molto intensa, ma breve”. Ma la questione è ben più complicata: e l’inferno di Sabra e Chatila dolorosamente lo conferma: “Sono dovuto andare a Chatila per percepire l’oscenità dell’amore e l’oscenità della morte”.





