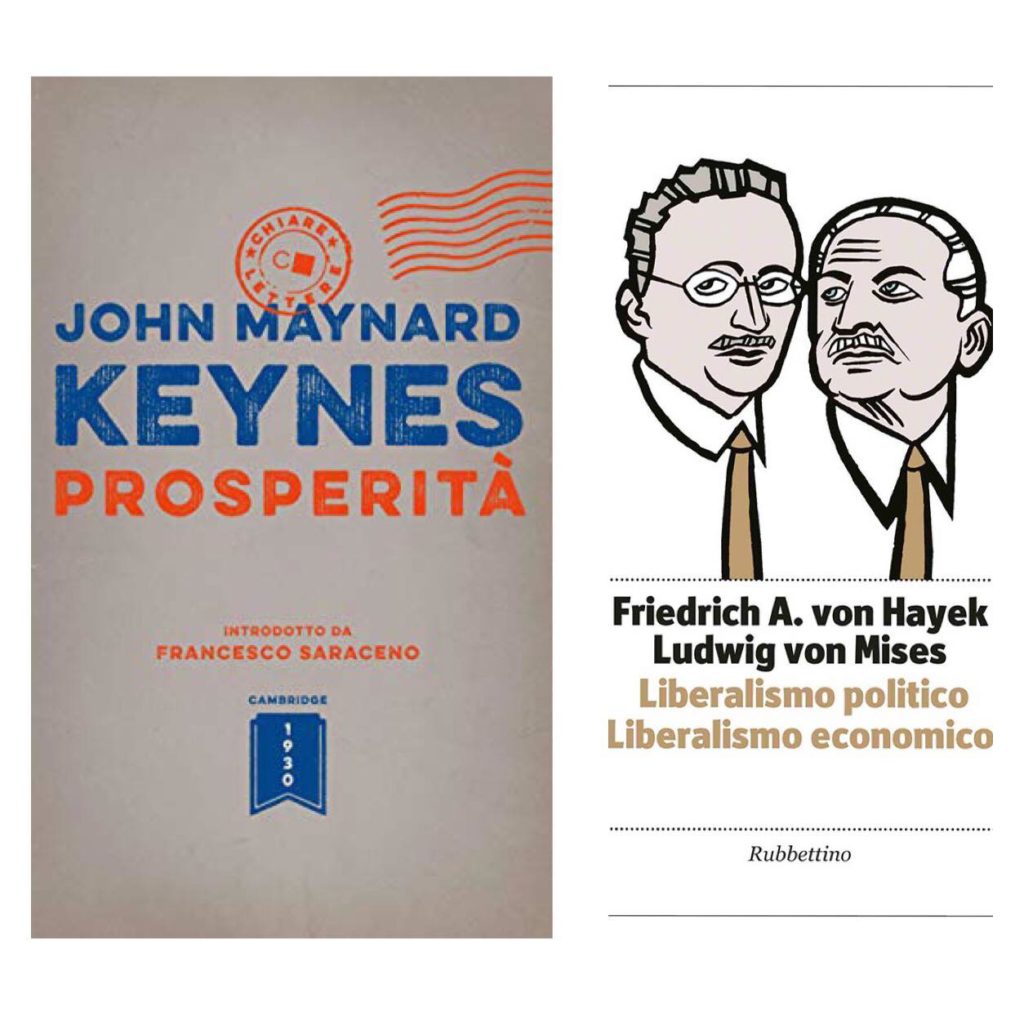Stefano Billi
Stefano Billi
ROMA – “Nuove parole del manager. 113 voci per capire l’azienda“. Ecco il titolo di una recente opera edita da Guerini e Associati e siglata dalla penna di Francesco Varanini.
Ecco il titolo di un utile libro sull’importanza di quelle parole che oggi sono diventate imprescindibili non soltanto per chi esercita attività d’impresa, ma soprattutto per chi voglia comprendere davvero l’ambito aziendale.
Nelle sue dimensioni tascabili, il testo compie il gesto coraggioso di ricordare al lettore come le parole siano importanti, non soltanto per “chiamare le cose col proprio nome”, ma soprattutto per conoscere il vero significato di ogni termine e la creatività umana che l’ha originato. Per dirla alla maniera del Varanini: «porre attenzione alle parole significa tornare a porre l’attenzione al senso», cosicché si possa ancora «riflettere sul nostro modo di agire, sul perché, e sul come lavoriamo».
E certamente non si corre alcun rischio di derive nazionalistiche laddove si voglia evidenziare come molto spesso i ricorsi a forme linguistiche estere, pur se appropriati, potrebbero invece lasciar il passo alla riscoperta di italianissimi sinonimi che esistono, come dimostrato tra le 230 pagine (circa) dell’opera.
Il lavoro certosino del Varanini dimostra perciò un acume fuori dal comune nel rintracciare le origini di alcune parole, siano esse vecchie o nuove, nostrane o straniere (schiera, quest’ultima, che in larga parte annovera elementi anglosassoni).
Inoltre, il libro offre una fruizione particolare, precisamente quella dei dizionari, cosicché non soltanto si può leggere il testo procedendo all’analisi delle singole voci secondo un ordine alfabetico, ma si può inoltre sfruttare un ricco indice analitico che assurge a stella polare di queste pagine dense di storia delle parole.
Sebbene ormai sia chiaro ai più come sovente la forma, specie in ambito aziendale, divenga sostanza, «riscoprire il senso delle parole ci aiuta ad andare oltre le apparenze», tanto che verrebbe da annoverare questo libello a guisa di fendente capace di squarciare il velo di ignoranza che spesso ottunde la comunicazione moderna.
“Nuove parole del manager. 113 voci per capire l’azienda” è un’opera importante per capire davvero il mondo aziendale, pratica e pronta all’uso, come le migliori guide sanno essere.