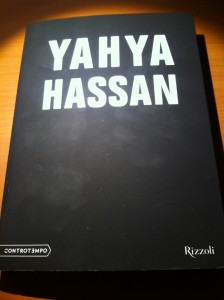 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – È stata la raccolta poetica più venduta in Danimarca. Accanto ai nomi di Karen Blixen, di Søren Kierkegaard, di Hans Christian Andersen, Yahya Hassan ha imposto anche il suo, che campeggia deciso, bianco su fondo nero, sulla copertina della sua silloge (Rizzoli, 2014); che non ha titolo, tranne, appunto, il suo nome. Yahya Hassan è un palestinese, classe 1995, apolide. Il suo passaporto, adesso, è danese. Ma la sua storia è quella di un ragazzo in cerca di un’identità. Una ricerca feroce e tremenda, che lo ha portato in tante comunità adolescenti (“E quanti tutti sono stati picchiati e mandati nelle stanze / si beve il caffè”), separato dai genitori e dai fratelli, in una ribellione continua a una cultura di origine che oramai era lontana e a una cultura di arrivo che lo rifiutava e non lo accettava: “A scuola non si può parlare in arabo / a casa non si può parlare danese”.
Violando qualsiasi regola della netiquette, le poesie di Yahya sono tutti scritte in maiuscolo, quasi fossero gridate dalle pagine bianche. E quello di Yahya Hassan è proprio un grido, feroce, furioso: è una protesta indocile, cruda. L’umanità viene scarnificata, ridotta all’essenziale; e l’essenziale è violenza, spesso gratuita ma in ogni caso pare imprescindibile, irrimediabile. Yahya non si fa problemi nel raccontare aspetti cruenti e mortificanti: tra le righe è però evidente il disagio, il rischio dell’annichilimento, l’ostilità verso un modo precostituito e completamente attrezzato nel difendersi contro un nemico inesistente. Il conflitto con il padre (“Cinque figli in fila e il padre con la mazza”), l’ostilità verso una nuova madre con nuovi fratelli e sorelle (“Ma sua moglie dice / che non devo toccare i suoi figli”), diventa ben presto exemplum di un’ostilità rivolta all’autorità, che comanda e bastone, che impone e obbliga, piuttosto che cercare di comprendere ed armonizzare: “Altri educatori / spaccano il vetro e mi danno una ripassata”.
La lucidità di questo diciannovenne è incredibile, sbalorditiva: “E tu dici che vorresti / non fossimo mai nati”. Meglio di qualsiasi trattato di sociologia o antropologia riesce a coinvolgere il lettore, a trascinarlo in una serie di teorizzazioni (sotto forma di poesia, ovviamente) che riguardano la nostra epoca, i nostri nuovi anni Dieci. L’integrazione fallita, il rifiuto di un modello di meticciato, l’inesistente disponibilità all’accoglienza: “È così che si muove il traffico / fatto in un autobus fermo al rosso al Digterparken / un gruppo di negri scende a Søren Frichs Vej / oltre il ponte – un altro ghetto”; e, di conseguenza, il riaffermarsi di modelli autocratici e razzisti, l’incapacità di gestire l’alterità (“Lo psichiatra controlla a tutti la testa e il culo / e le bocche vengono riempite di psicofarmaci”), l’individuazione di un capro espiatorio che sia “l’altro”, il “diverso”, la minoranza debole e scarsamente difendibile: “13 anni e ricercato salgo su un treno per la Danimarca”.
Spesso, però, come si evince da queste poesie, è la stessa minoranza che non può fare a meno di sentirsi tale: circondata dall’odio, dal disagio dell’incontro, dall’ostilità più o meno aperta rischia di diventare referente di (e a) sé stessa. E di nuovo si richiude in forme ancora più crudeli di esclusione e precarietà: “Sono sonno senza sogni / come una spia in isolamento volontario”.
Tag: Danimarca
“Un grande artista, mesdames, non è mai povero”.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Saper raccontare storie è un dono; un’abilità che, come le Mille e una notte insegnano, può persino salvare la vita. E sicuramente offre un’opportunità inestimabile di non perdersi ed esser ricordati. Karen Blixen sapeva raccontare storie. Sapeva costruire personaggi. Sapeva calibrare dialoghi, ricchi ma essenziali, dove neppure una parola – neanche una virgola – era fuori posto, né superflua. E uno dei massimi capolavori della sua arte di tessitrice di storie è senza dubbio “Il pranzo di Babette”, scritto nel 1958.
Babette è una misteriosa donna francese che, fuggita dalla Parigi dove era fallita la scommessa rivoluzionaria della Comune del 1871, si rifugia in un fiordo della Norvegia, assente anche dalle carte geografiche; lì, indirizzata da un suo conoscente francese, il noto cantante d’opera Achille Papin, va a cercare aiuto da Martina e Filippa, due anziane signore, figlie di un famoso decano protestante che, negli anni addietro, aveva fondato un movimento religioso di grande successo.
La vita di Babette si cristallizza così, per più di dieci anni. Mai un evento a rompere la quiete sonnolenta del borgo, mai un incontro, una parola che non fosse strettamente necessaria, mai un ricordo della sua patria, la Francia lontana, dove aveva perso tutti i suoi cari e il suo misterioso lavoro. Ma ben presto arriverà il momento, anche per Babette, di tornare a brillare, anche solo per un istante.
 La storia di Babette è una deliziosa metafora della vita dell’artista, declinata – come non avrebbe potuto fare altrimenti – nella figura di una donna. Babette è cuoca: a Parigi era stata chef, caso quanto mai raro a quei tempi, e lavorava nel ristorante più rinomato della città. La sua creatività, il suo estro culinario (che si confonde con quello artistico) le avevano persino fatto creare dei piatti nuovi, assolutamente unici, inconfondibili. E sono quegli stessi che il generale Lowenhielm – l’unico a portare un po’ di colore ed emozione alla riunione dei puritani – riconosce e attraverso i quali si smarrisce ricordando il suo passato di giovanotto, quando i piaceri terreni erano i soli a esser ricercati ma anche quando la speranza per il futuro era la premessa della felicità.
La storia di Babette è una deliziosa metafora della vita dell’artista, declinata – come non avrebbe potuto fare altrimenti – nella figura di una donna. Babette è cuoca: a Parigi era stata chef, caso quanto mai raro a quei tempi, e lavorava nel ristorante più rinomato della città. La sua creatività, il suo estro culinario (che si confonde con quello artistico) le avevano persino fatto creare dei piatti nuovi, assolutamente unici, inconfondibili. E sono quegli stessi che il generale Lowenhielm – l’unico a portare un po’ di colore ed emozione alla riunione dei puritani – riconosce e attraverso i quali si smarrisce ricordando il suo passato di giovanotto, quando i piaceri terreni erano i soli a esser ricercati ma anche quando la speranza per il futuro era la premessa della felicità.
Spenderà tutti i soldi vinti in una lotteria, Babette. Li spenderà perché è l’unico modo, quello, per poter tornare a essere la grande artista che era, un tempo; quella che riusciva a rendere felici gli uomini con i suoi pranzi; quella che, costretta all’esilio, non smette di essere un’artista ma sente sempre il bisogno, quasi un imperativo morale, di poter dare sempre il massimo; perché “un grande artista, mesdames, non è mai povero”.





