 Dalila Sansone
Dalila Sansone
GRAZ – Esistono scritture potenti: mani che imprimono alle parole sui fogli la plasticità delle emozioni, rendendo vive le passioni, quelle che ardono e mentre bruciano consumano ciò di cui si alimentano, eliminandone la fisicità ma non la forza. “Le braci” di Sándor Márai è esattamente questo, l’equivalente della scultura in letteratura, la tensione che cresce sulla corda di un arco teso fino all’istante prima di scoccare il tiro. È il racconto di una notte: un incontro atteso quarantuno anni, preparato per tutto quel tempo e il compimento di ogni attimo di vita vissuta fino a quel momento. Due amici di una volta che si ritrovano davanti al fuoco di un camino in una notte di fine estate, consapevoli di prendere parte all’ultimo atto di un duello da combattere, ciascuno con la propria esistenza, una resa dei conti che solo la presenza dell’altro rende concreta.
Cresce la narrazione, attraverso i pensieri del generale, dall’arrivo di una lettera alla partenza di Konrad all’alba del giorno successivo. I ricordi ricostruiscono il passato, un passato di fatti la cui consistenza si sgretola lentamente, inesorabilmente, nel rincorrersi di momenti cristallizzati nell’istante esatto in cui si sono compiuti e l’alternarsi di emozioni troppo fragili e inesperte quando sono rimaste ancorate alla mente, fissate per sempre. La sensazione è che siano stati loro, momenti ed emozioni, a vivere nel frattempo e non le esistenze che hanno scandito, modellandosi, acquisendo identità e potenza.
La ricerca della verità che cos’è? Le risposte hanno bisogno della formulazione di domande ma riuscirci, arrivare alla domanda, può richiedere il tempo di una vita e non ha presunzione di compimento. Diviene una sfumatura dell’esistenza che non ammette categorie fisiche, abolisce il tempo e permea l’essere. Le categorie, quelle categorie insufficienti che rispondono allo spazio e al tempo, vengono sostituite da una dimensione che vive una morte inesorabile nel silenzio, nella sua continua e inevitabile tensione verso lo scandire delle parole che la motivano: l’attesa. Attesa della verità, che non può risiedere in pochi fatti polverosi: conoscere i fatti non è abbastanza.
Le braci ardono a differenza delle ceneri. Nelle braci langue la forza delle fiamme che le ha generate. Quello che brucia vive e quando si consuma, prima di spegnersi, è pronto a riaccendersi e ardere d’intensità pari all’incendio di un tempo indefinito precedente. Basta il passaggio di un alito di vento.
Di fronte alle braci che riprendono vigore, consumando le risposte dei fatti che invece diventano cenere, dopo un’attesa durata più a lungo di quegli stessi fatti, non importa più cosa abbia scatenato la passione, da dove sia provenuta la prima scintilla, solo che lo abbia fatto. E la ricerca del senso si scopre il senso stesso.
Autore: Giulio Gasperini
Nei “Racconti di Odessa” la vita di Bàbel’.
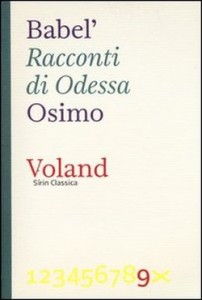 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Innegabile come la vita personale possa diventare materia di racconto. Per gli scrittori tutti codesta è la fonte prima di ispirazione: il lievito madre da cui plasmare storie, vicende da architettare e dipanare. Isaàk Èmmanuìlovič Bàbel’ rappresenta forse una delle massime applicazioni di tale concetto e uno degli esempi più palesi. Nato nel quartiere di Moldavanka, a Odessa, fu perseguitato aspramente e violentemente dal regime di Stalin; fucilato nel 1940, tutti i suoi manoscritti erano stati in precedenza sequestrati e distrutti. Ciò che resta di Babel’, come i “Racconti di Odessa”, pubblicati da Voland nel 2012 con la traduzione di Bruno Osimo, hanno piuttosto come argomento e tematiche gli anni della sua adolescenza, trascorsa nella più totale libertà del quartiere ebraico della Moldavanka, palcoscenico privilegiato di trame e vicende che, già di per sé stesse, costituivano dei copioni narrativi irresistibili per chi, come Bàbel’, possedeva la vocazione alla scrittura.
L’umanità che prende vita negli intensi racconti è quella dei bassifondi, dei trafficanti, dei contrabbandieri che tramano, fanno e disfano per la pura gioia dell’evasione, dell’effrazione della legge, della sua indipendenza. Tra tutte, si erge la figura del giovane Benja Krik, non a caso chiamato “Il Re” per la sua tracotanza e la sua intraprendenza di comando. Nei racconti di Babel’ tutto il quartiere partecipa all’azione, in un esempio di sociabilità che trascende qualsiasi modello di perfetto socialismo ideale e “sociale” (se il bisticcio non fosse troppo pretenzioso). La condivisione, prima di tutto. Ma non solo condivisione; anche co-azione e co-operazione. Non c’è mondo che esista, per Bàbel’, se non c’è l’unità delle sue parti: un’unità, ovviamente, che non può essere imposta né totalmente e inappellabilmente paritaria, ma un’unità che sia a livello di azioni; che situi, insomma, tutti i partecipanti in una coralità ricca ed esuberante.
E proprio l’esuberanza è la chiave, anche stilistica, di questi racconti. La scrittura di Bàbel’ non è cristallina, né limpida. È una continua ricerca di iperboli, di collegamenti che si espandono all’infinito, un incessante rincorrersi di sottrazioni da cui dedurre il risultato finale. La ricerca non è mai semplice, è sempre un continuo mettersi alla prova, sentendosi guidati e condotti da un burattinaio che ci deride col suo stile ricco di tranelli e preziosità difficili da masticare. Perché spesso è il paradosso l’unico elemento che riusciamo chiaramente a distinguere: e ogni paradosso nasconde persino un fondo di realtà che, nel contesto narrativo e stilistico di Bàbel’, pare quasi diventare l’elemento meno importante.
“Svanire è davvero possibile? O è solo un’illusione?”
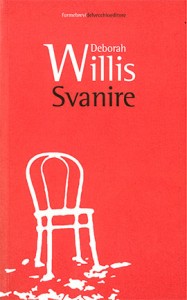 Michael Dialley
Michael Dialley
AOSTA – “Svanire” non è solo il titolo della raccolta di Deborah Willis, edita da Del Vecchio editore, ma anche il primo racconto che apre la strada al lettore in un viaggio particolare, molto suggestivo che riguarda lo scomparire, lo svanire, il lasciare.
Sono 14 racconti i cui protagonisti sono i più diversi, sia per età che per cultura e stile di vita, ma tutti accomunati da un’esperienza di distacco: una moglie che scappa, qualcuno che muore, che viene rapito, ma anche chi è stato incapace di capire i figli, chi gli stava intorno, causando un allontanamento forzato.
Si viene incatenati subito alle pagine di questo libro, perché sono esperienze che tutti, chi più chi meno, hanno vissuto totalmente o solo in parte; sono racconti brevi, scritti con semplicità e chiarezza, ma soprattutto con un’intensità straordinaria.
Si impara a conoscere i vari protagonisti, con le loro emozioni, i loro sentimenti, le loro abitudini e si capisce come ci si senta dopo essere stati allontanati, dopo essere stati abbandonati o dopo essersi allontanati.
Sono tante le riflessioni che si possono fare dopo ciascun racconto: i genitori si chiederanno sicuramente se il rapporto con i figli è giusto, oppure si identifica con quello di alcuni racconti; un figlio si domanda se ha un atteggiamento giusto verso babbo e mamma, se ha affrontato un divorzio o, peggio ancora, un lutto, nella maniera corretta, con la giusta intensità; i ragazzi che si affacciano, appena ventenni, alla vita, al mondo, fuori dall’ala protettrice della famiglia, si interrogheranno su quali esperienze sono da fare per rendersi conto di come funzioni il mondo, su quali cose è necessario impegnarsi e quali situazioni vanno tralasciate e dimenticate.
Questo romanzo è una sorta di guida, non un saggio; è persino un cortometraggio con spezzoni di varie vite di varie persone. La domanda che viene rivolta a ogni lettore, alla fine, è: si può davvero dimenticare, essere dimenticati, svanire nel nulla, oppure una parte di noi rimane costantemente legata alle persone, ai luoghi, alle situazioni? La risposta sta in ogni uomo, non ci sono risposte giuste o sbagliate, ognuno pensa e agisce a modo suo, e non ci si può nemmeno chiedere perché qualcuno vicino a noi è svanito, o ha cercato di farlo.
Svanire nel nulla non è possibile né fattibile: dovunque andiamo, chiunque conosciamo, ci lascia un qualche cosa così come noi lasciamo tracce, parole, azioni, indelebili nel mondo.
Dove si sente cantare “il suono del suo nome”.
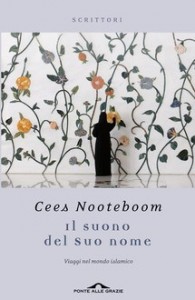 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – La luce, il tempo, la pietra: sono queste le dimensioni privilegiate per le quali Cees Nooteboom parte alla scoperta del mondo islamico, durante vari anni. “Il suono del suo nome”, edito da Ponte alle Grazie nel 2012, è un collage di racconti e incantevoli poesie che sorprendono e cristallizzano istanti, attimi, momenti sorpresi in ogni istante del giorno e della notte. Mai realmente turista, Nooteboom ha saputo trasformare l’esplorazione e il viaggio in una vera e propria arte, in una declinazione di pura narratività. E sicché accade che i nomi – Marrakech, Atlante, Tangeri, Isfahan – scontornino i loro bordi, i limiti della loro realtà e concretezza, e si profumino di spezie, si squadernino di spazi indefiniti, si allunghino di dolci ombre: i nomi perdono la loro importanza geografica, si estraniano da una carta, e si giustifichino non in virtù del loro aspetto ma per la società che li popola e che, in loro, costruisce un confronto e un’unione.
Le piccole, intense incursioni di Nooteboom nel mondo islamico diventano squarci di anima, indagini affilate e potenti delle tante sfaccettature dell’intimo. La ricerca diventa ancora più efficace, in tale contesto, perché “è un paesaggio senza distrazioni, senza decorazioni”; un paesaggio essenziale, dove “il cielo è freddo e brilla di stelle”. La consapevolezza dell’essere umano trova molte strade, nelle descrizioni di Nooteboom; la realtà tangibile, l’abilità degli artigiani, la perizia dei loro mestieri, la sacralità delle tradizioni si filtrano attraverso la coscienza di un uomo che non è semplicemente viaggiatore ma peregrino in ogni terra, dalla Spagna all’India, alla ricerca del significato più vero, quello più genuino, quello che si smarchi dai luoghi comuni e dai pregiudizi dilaganti. E il percorso, senza la pretesa di giungere a una verità suprema, a una descrizione che sia anche racconto metafisico e univoco, comincia a svelare le bellezze e il rischio di fraintenderle. Si scopre, così, che l’aridità della pietra è necessaria per comprendere la bellezza, la sua unicità se nasce in un luogo dove nessuno l’attenderebbe e dove accoglierla è un atto di ribellione; e si scopre che la bellezza inevitabilmente consente di accettare la durezza, la ruvidezza, l’aridità, ovvero una parte innegabile dell’esistenza umana: “Dopo la pietra capisci la rosa, dopo la rosa sopporti la pietra”. È proprio il deserto la dimensione che più riduce l’uomo e lo ridimensiona nei suoi fragili e ridotti confini, che lo lascia esterrefatto al cospetto della sua nullità, della leggerezza del suo respiro, della permeabilità della sua ombra: “E quando ci giriamo, vediamo quello stesso vento cancellare subito i nostri passi insignificanti. Non siamo mai stati qui”.
L’avventura di Nooteboom, però, intenzionalmente non mira ad arrivare a una soluzione, non aspira consapevolmente a descrivere oggettivamente quello che si vede, quello che si tocca, si sente, si odora: “Io preferisco la sensazione del mistero alla certezza della soluzione”.
“Un grande artista, mesdames, non è mai povero”.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Saper raccontare storie è un dono; un’abilità che, come le Mille e una notte insegnano, può persino salvare la vita. E sicuramente offre un’opportunità inestimabile di non perdersi ed esser ricordati. Karen Blixen sapeva raccontare storie. Sapeva costruire personaggi. Sapeva calibrare dialoghi, ricchi ma essenziali, dove neppure una parola – neanche una virgola – era fuori posto, né superflua. E uno dei massimi capolavori della sua arte di tessitrice di storie è senza dubbio “Il pranzo di Babette”, scritto nel 1958.
Babette è una misteriosa donna francese che, fuggita dalla Parigi dove era fallita la scommessa rivoluzionaria della Comune del 1871, si rifugia in un fiordo della Norvegia, assente anche dalle carte geografiche; lì, indirizzata da un suo conoscente francese, il noto cantante d’opera Achille Papin, va a cercare aiuto da Martina e Filippa, due anziane signore, figlie di un famoso decano protestante che, negli anni addietro, aveva fondato un movimento religioso di grande successo.
La vita di Babette si cristallizza così, per più di dieci anni. Mai un evento a rompere la quiete sonnolenta del borgo, mai un incontro, una parola che non fosse strettamente necessaria, mai un ricordo della sua patria, la Francia lontana, dove aveva perso tutti i suoi cari e il suo misterioso lavoro. Ma ben presto arriverà il momento, anche per Babette, di tornare a brillare, anche solo per un istante.
 La storia di Babette è una deliziosa metafora della vita dell’artista, declinata – come non avrebbe potuto fare altrimenti – nella figura di una donna. Babette è cuoca: a Parigi era stata chef, caso quanto mai raro a quei tempi, e lavorava nel ristorante più rinomato della città. La sua creatività, il suo estro culinario (che si confonde con quello artistico) le avevano persino fatto creare dei piatti nuovi, assolutamente unici, inconfondibili. E sono quegli stessi che il generale Lowenhielm – l’unico a portare un po’ di colore ed emozione alla riunione dei puritani – riconosce e attraverso i quali si smarrisce ricordando il suo passato di giovanotto, quando i piaceri terreni erano i soli a esser ricercati ma anche quando la speranza per il futuro era la premessa della felicità.
La storia di Babette è una deliziosa metafora della vita dell’artista, declinata – come non avrebbe potuto fare altrimenti – nella figura di una donna. Babette è cuoca: a Parigi era stata chef, caso quanto mai raro a quei tempi, e lavorava nel ristorante più rinomato della città. La sua creatività, il suo estro culinario (che si confonde con quello artistico) le avevano persino fatto creare dei piatti nuovi, assolutamente unici, inconfondibili. E sono quegli stessi che il generale Lowenhielm – l’unico a portare un po’ di colore ed emozione alla riunione dei puritani – riconosce e attraverso i quali si smarrisce ricordando il suo passato di giovanotto, quando i piaceri terreni erano i soli a esser ricercati ma anche quando la speranza per il futuro era la premessa della felicità.
Spenderà tutti i soldi vinti in una lotteria, Babette. Li spenderà perché è l’unico modo, quello, per poter tornare a essere la grande artista che era, un tempo; quella che riusciva a rendere felici gli uomini con i suoi pranzi; quella che, costretta all’esilio, non smette di essere un’artista ma sente sempre il bisogno, quasi un imperativo morale, di poter dare sempre il massimo; perché “un grande artista, mesdames, non è mai povero”.
È un “dolce sollievo la scomparsa”, per Sarah Braunstein.
 Michael Dialley
Michael Dialley
AOSTA – Le vite sono delle storie da raccontare, e non fanno eccezione quelle di Paul, Judith, Sam, Hank, Bea, Byron, ma soprattutto quella di Leonora, la bambina che accompagna il lettore in tutto il romanzo di Sarah Braunstein, “Il dolce sollievo della scomparsa” edito da 66thand2nd nel 2012.
Sono storie che non risultano mai banali, tutte hanno un qualcosa di nascosto che cattura il lettore, sono particolari, difficili spesso. Vite di amore, rinunce, passioni sfrenate, sincerità, ma anche menzogne; e i protagonisti sono soprattutto bambini, con la loro innocenza ma anche con il loro non sapersi sottrarre alle pulsioni, alle passioni e con la voglia di libertà. I personaggi si raccontano, sono apparentemente estranei e lontani, ma poi nella narrazione alcuni si incrociano e, in età adulta, si troveranno a ricordare, rivivere momenti dell’infanzia, e a volte arriveranno a riscattare ciò che in passato non hanno potuto vivere, offrendoci spunti di riflessione e importanti lezioni di vita.
Leonora è il centro, ma al contempo periferia, di tutto il romanzo e ci fa imparare una cosa molto importante: le persone non sempre sono come sembrano e nelle situazioni estreme emergono forza, capacità, determinazione e, soprattutto, forza di volontà. È questo un insegnamento che lei ha ricevuto, a sua volta, dal babbo, e che si troverà a mettere in pratica negli ultimi istanti della sua vita: soffre, Leonora, nella stanza dove la tengono segregata, con il gattino che farà la sua stessa fine, ma a un certo punto ricorda le parole del padre – “Tieni duro!” – e poi riconosce un grande albero che ha visto ogni giorno per molto tempo: tutto questo le darà la forza di affrontare il suo destino; e lo farà totalmente sollevata.
I bambini sono innocenti, ma proprio per questa loro spensieratezza sono costantemente attratti dal male; il maligno è una calamita che attrae facendo leva sulla voglia di libertà e sull’elemento ribelle che c’è in ogni uomo. Scappare diventa una liberazione, così come lo è l’essere lontano da ogni legame; essere in un mondo di sconosciuti, essere totalmente svincolati da tutto e tutti dà, effettivamente, un dolce sollievo. Quante volte vorremmo scappare da tutto e tutti e stare con noi stessi? Spesso.
I bambini e i futuri adulti di questa storia hanno potuto provare questo distacco: chi volontariamente, chi involontariamente. Ma per tutti è stata, senza dubbio, un’esperienza fondante.
“The true adventures of Rolling Stones”
 Dalila Sansone
Dalila Sansone
GRAZ – Non è una biografia in senso proprio: dietro i vent’anni di Mick Jagger sulla copertina patinata dell’edizione riproposta per i cinquant’ anni della rock band non c’è la storia dei Rolling Stones. Troppo facile. Gli Stones non ci si sono mai del tutto prestati alla categoria del “facile”. Sfuggenti, taglienti, capaci di creare l’aspettativa e risponderle ancora meglio. Stanley Booth invece era un giornalista, scriveva di musica negli anni ’60. Un’idea: scrivere la loro biografia; ed è per questo che li segue nella tournée statunitense del ’69. Gli ci vorranno quindici anni per concludere una delle più graffianti auto confessioni di un’epoca. Le ragioni di una genesi così lunga stanno lì, in fondo al libro, incastonate nella postfazione come una pietra rara: un’analisi retrospettiva talmente lucida da valere tutte le parole, le immagini e le sensazioni che il loro intreccio precedente aveva evocato. A distanza, una distanza che impreziosisce la prospettiva.
Ci vuole tempo a capire le sovrapposizioni della narrazione, il collegamento con l’epigrafe all’inizio di ogni capitolo, le parole della madre del già annegato-in-piscina Brian Jones, i voli da un college all’altro, gli Hell’s Angels, il dente di coguaro che dondola all’orecchio di Keith Richards, nomi, tanti nomi, marijuana, alcool, il ritratto sbiadito di Jagger provato dalla stanchezza e convinto di essere ormai vicino al declino: – Sono otto anni che facciamo questa vita, quanto volete possa ancora durare?!
Si alternano una storia, polverizzata in mille storie, e la cronaca degli ultimi mesi di un periodo destinato a frantumarsi e implodere su se stesso allo scadere dell’appuntamento con il nuovo decennio. Gli Stones una delle metafore possibili. “The true adventures” (1984)si apre e si chiude con Altamon, 6 dicembre 1969. La promessa di una nuova Woodstock, al termine di una tournée folgorante che celebrava il riscatto di quelli che tre anni prima erano stati dati per finiti davanti agli scranni dei tribunali dell’Inghilterra perbenista. Fu l’emblema della fine degli anni ’60. Un declino che trapuntava con fili sottili le contraddizioni, le contestazioni, quel senso illusorio di libertà di espressione che, nonostante la polizia, i poteri forti, il Vietnam, si aveva la presunzione di possedere. Eppure Booth la provava quella nausea; non erano sufficienti le droghe, il ritmo, era lì, tutte le volte che Mick lanciava petali di rosa in chiusura sulle note di “I’m free”. Liberi? Liberi dentro le mura di una palestra? Liberi di suonare per gli studenti in libera uscita? Liberi circondati dagli Hell’s Angels ? Liberi di credersi liberi?
Quell’anno muore Kerouac. Una telefonata. La notizia. L’illusione si spezza e, solo a questo punto, ti accorgi che stai leggendo la STORIA. La fine è macchiata di sangue. Niente sarebbe stato più lo stesso, nemmeno gli Stones. Non guidavano, né erano il simbolo di nessuna protesta: erano giovani della periferia anonima di Londra, come tutti gli altri, come tutti i protagonisti dimenticati e senza nome che hanno fatto degli anni ’60 quello che sono stati fuori dalle analisi ufficiali e dalle cronache; la generazione di passaggio verso una società destinata a rimodellarsi continuamente in realtà che avrebbero, di li a poco, continuato a mutare credo e definizione (o presunti tali) vertiginosamente.
L’orrore collettivo di Altamon fu l’incubo che precede quei risvegli bruschi dalle percezioni dilatate in maniera straniante, fuori dal sogno, distanti dalla realtà. Una terra di nessuno dei sensi e di mancanza di riferimenti per certe coscienze. Booth ebbe bisogno di ridefinire se stesso, gli Stones avrebbero costruito pezzo su pezzo la loro identità, la loro di realtà consacrandola all’immortalità. Eppure nella musica di quegli anni la senti vibrare ancora quell’urgenza vitale di esistere, la rivendicazione di libertà, l’assoluta affermazione si sé stessi attraverso la negazione di adeguamento a qualunque schema precostituito. È lì che affondano le radici della leggenda. La rottura ha in sé le premesse della riorganizzazione dopo l’urto. Si sceglie se riutilizzare i pezzi e di quali fare le colonne portanti della ricostruzione. Non è riuscito a tutti bene. Ai protagonisti di questo racconto nella storia, voce narrante e personaggi principali, invece si. No, non avrebbero mai potuto trovare soddisfazione. Erano di quelli destinati a non provarla mai.
I cento anni del “Pigmalione”
 Dalila Sansone
Dalila Sansone
GRAZ – “Piantala di fare l’idiota (…), se non sei in grado di apprezzare quello che hai ottenuto allora vedi di procurarti quello che sai apprezzare”. A volte in un giorno di pioggia vorrei muovermi dentro il tempo, aprire gli occhi e trovarmi di fronte Covent Garden, Londra, un centinaio di anni fa. Lì dove Eliza Doolittle ha incontrato la prima volta Henry Higgins. Inizia così “Pigmalione” di Bernard Shaw: la pioggia, persone che si riparano dietro le colonne di un portico, una misteriosa figura che prende appunti su un taccuino. Cento anni dalla prima pubblicazione: l’assoluta certezza che Shaw abbia scritto un testo senza tempo. Fuori dall’ambientazione, oltre la narrazione della storia della fioraia con il suo cockney dei bassifondi e dell’erudito professore di fonetica Mr Higgins, sono il modellarsi del rapporto, la mutevolezza delle forme e la potenza dei legami che prendono forma. Sarebbe facile cadere in errore e farne una riduzione sentimentale. La finezza di Shaw sta nel non cedere alla banalità. Perché i casi della vita raramente rispondono a tale definizione e se lo fanno sono destinati a non inciderla. Mai.
Eliza si presenta all’uomo che l’aveva terrorizzata la sera prima, ripetendo esattamente ogni suono uscito dalla sua bocca: vuole che le insegni un corretto inglese. L’unico modo per vincere i pregiudizi, lavorare in un negozio di fiori e smettere di farlo per strada. Il primo scontro titanico. La mediazione del colonnello Pickering lo trasforma in una scommessa: sei mesi per riuscire a far passare Eliza per una duchessa. Un tempo in cui lei si scopre nelle cose che apprende e che diventano sue. Non cambia, riordina un essere se stessa senza bisogno di definizioni e inconsapevole, con la naturalezza delle cose non cercate che si delineano più velocemente di quanto le si possa cogliere, si crea il legame. Ed è quel legame a rivelarsi prepotentemente nel riaccendersi dell’istinto, quando la scommessa è vinta e Higgins è solo sollevato di non dover continuare con un affare così noioso mentre Eliza non sa più chi è. Lui non si accorge nemmeno di lei, troppo occupato a chiedersi dove siano le sue ciabatte. Lei decide esattamente in quell’istante chi è e gliele lancia contro, quelle ciabatte, prima di andarsene e non tornare. Non tornare più come prima, né quella di prima. La consapevolezza di sé ha il suo prezzo. L’indipendenza emotiva anche ma richiede uno strappo per essere capita. Per capire che è li dentro che sta un’identità che, invece, non avevi mai del tutto compreso.
Higgins potrebbe nascondersi nel passato di chiunque, tutti potremmo essere stati delle fioraie con i confini del mondo chiusi dentro un cesto di viole e un terribile accento da strapparsi di dosso per seguire un qualche destino. La scoperta di sé, il valore consapevole della dignità che si trascina dietro, scavano un angolo intoccabile e lasciano un segno indelebile sulla pelle. Si tratta di occasioni che possono capitare, oppure no e le conseguenze non gli dipendono necessariamente: la svolta non appartiene a nessun altro se non a chi decide di compierla. Ma restano anche i segni, quelli invisibili agli sguardi. Quelli che ricordano l’attimo esatto in cui qualcosa è cambiato. Il perimetro sottile del punto di non ritorno, quando non c’è stato nessuno a dirti chi eri e dove saresti andato.
C’è un alone di malinconia, non di tristezza, nei brividi dietro il calare improvviso di un’ombra che capita si allunghi nell’animo di un’umile fioraia ma non tocca mai quello del suo pigmalione. Potrebbe succedere di domandarsi tutta la vita se a lui, invece, sia rimasto non un segno, anche solo un graffio di lei, lasciato nell’urto con quell’occasione.
Il senso comune si infrange contro i vetri opachi che separano le emozioni da tutto il resto. Lasciano appena intravedere e proteggono quello che ci appartiene dal tentativo di volerlo spiegare: ciò che veramente ci appartiene non ha bisogno di essere compreso, non ha nulla da pretendere se non l’essere lasciato intatto.
Henry Higgins ha fatto di Eliza Doolittle una donna. Lui lo sa. E la risposta alla domanda quella donna la conosce dall’alto della sua dignità e di quella inspiegabile commistione di riconoscenza e di affetto che non si sceglie, si può solo provare. Nonostante tutto.
Negli “African graffiti” l’unicità d’un continente.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Non si può raccontare l’Africa se si prescinde dalle persone. Forse nessun altro continente, come l’Africa, affida ancora la sua storia a quelle singole degli individui: lì non esiste, almeno fin adesso, l’idea del destino comune, della meccanizzazione dei destini, dell’inviolabilità del futuro. Forse perché in Africa il futuro ha ben poca importanza in confronto all’adesso, a quello che sta accadendo nell’attimo in cui si parla. E anche perché le incognite, le variabili, non sono preventivate: l’uomo non può immaginarsi ogni casualità, ogni possibile futuro; perché allora doversene preoccupare?
“African graffiti”, la raccolta di storie di Marco Aime, edita da Stampa Alternativa – Nuovi Equilibri (2012), è tutto questo: una galleria di volti, di persone, di nomi precisi, di gesti identificabili. Marco Aime, nei suoi lunghi anni di studio come antropologo delle terre africane, sa che non si può parlare di futuro, per l’Africa, in termini universali, generici. È troppo grande, l’Africa; è troppo composita, varia, multiforme. L’unico modo per capire l’Africa è cercare di capirne i singoli frammenti, i tanti tasselli che la formano. L’Africa ancora non è collettività anonima, industriale, riconducibile a calcoli matematici ed economici. L’Africa è ancora un intreccio e un collegamento di comunità, di nuclei umani. Sicché l’umanità è qualcosa da cui non si può prescindere per descriverla e per capirla.
A cominciare dall’unicità dei cartelloni pubblicitari e delle insegne commerciali: “Sono dipinte a mano, ognuna con un suo stile, colori suoi. Al contrario delle nostre insegne standardizzate, che rimandano a marchi industriali, queste sono dei veri non-loghi, perché sono estremamente personalizzate. Non ce ne sono due uguali”. L’Africa è così, proprio come le sue insegna: è la terra per eccellenza del no-logo, della personalizzazione, dell’esclusività. È una terra dove ancora alcuni valori riescono a sopravvivere, dove ancora si ascolta e dove ancora l’uomo non è soggiogato al tempo incalzante e prepotente.
E la galleria di ritratti che Marco Aime ha messo diligentemente insieme ci conferma tale sensazione. Lui stesso è consapevole di quanto il suo lavoro possa apparire inutile e sterile, di quanto corrompa il pensiero e di quanto si rischi, insistendo, di perdere la meraviglia dagli occhi e dalla mente, non lasciandosi più sorprendere da nulla e attendendosi già tutto. Ma è anche consapevole, Marco Aime, che l’Africa sa sempre come riprendersi la rivincita e come offrire sempre un nuovo motivo, un nuovo gesto, un nuovo sguardo, per far sorprendere, per rimanere ancora una volta senza fiato, e chiedersi qual è quel potere che incatena l’uomo. Che fa stancare dell’Africa il secondo giorno che vi si sbarca ma che la fa mancare, perdutamente, già al secondo giorno del rientro in Italia.
“Verdi colline d’Africa”: vanità di vanità.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – A Hemingway, si sa, garbavano i fucili; a tal punto da usarne uno per spararsi e decidere di morire, nel 1961. Fino a qualche anno prima li aveva usati soprattutto per l’altra sua grande passione: la caccia, quella grossa. E in “Verdi colline d’Africa”, del 1935, codeste sue passioni sono esaltate come in nessun’altra sua opera.
Piuttosto anomala nel panorama della sua produzione, “Verdi colline d’Africa” è la descrizione del primo safari a cui lo scrittore partecipò, nel 1933, nella regione del Lago Manyara, ora Tanzania. Ernest amò l’Africa; quella stessa così magistralmente narrata da Karen Blixen, alla quale pare proprio il vecchio Hemingway aver soffiato il premio Nobel, nel 1954 (e alla quale il cavaliere Ernest si sentì in dovere di riconoscerne, almeno idealmente, il merito). L’Africa fu ispiratrice anche di altri testi hemingwayani, soprattutto racconti brevi, ma questo “Verdi colline d’Africa”, nonostante continue stroncature da parte di critici e altri scrittori, è degno di menzione, perché appare subito diverso, nel risultato, da quelli che sarebbero potuti essere gli intenti. Non è, infatti, un resoconto: ben poco ha di cronaca e di narrazione diaristica; pare piuttosto un’esercizio di analisi, quasi psicoterapico, dove ogni ritratto che ne è tratteggiato risente delle intermittenze del cuore e dove ogni episodio, ogni singolo avvenimento, rappresenta ben più della pura e semplice comprensione letterale.
 Il buon vecchio Ernest si sente frustrato perché gli altri caccian bestie più grosse delle sue; perché l’amico (o presunto tale) porta al campo delle corna che son più grosse di quelle sue. Ebbene, Freud si sarebbe divertito da pazzi leggendo questo resoconto di battute di caccia grossa, esplorando il non-detto, il sottaciuto e le pretese palesi dell’irrazionale. E finanche noi un po’ ci divertiamo; e ne (sor)ridiamo, persino un tantino compassionevoli. Perché il buon vecchio Ernest ci credeva davvero, in quel che faceva: nell’energia che spendeva a furia di far meglio dell’altro, di cacciare qualcosa di meglio, di sparare proprio nel punto giusto. E che terribile giorno fu quello nel quale perse la bestia già colpita ma più lesta o semplicemente più furba, che sparì e non si fece più ritrovare, preferendo magari morire nella dignità della solitudine.
Il buon vecchio Ernest si sente frustrato perché gli altri caccian bestie più grosse delle sue; perché l’amico (o presunto tale) porta al campo delle corna che son più grosse di quelle sue. Ebbene, Freud si sarebbe divertito da pazzi leggendo questo resoconto di battute di caccia grossa, esplorando il non-detto, il sottaciuto e le pretese palesi dell’irrazionale. E finanche noi un po’ ci divertiamo; e ne (sor)ridiamo, persino un tantino compassionevoli. Perché il buon vecchio Ernest ci credeva davvero, in quel che faceva: nell’energia che spendeva a furia di far meglio dell’altro, di cacciare qualcosa di meglio, di sparare proprio nel punto giusto. E che terribile giorno fu quello nel quale perse la bestia già colpita ma più lesta o semplicemente più furba, che sparì e non si fece più ritrovare, preferendo magari morire nella dignità della solitudine.
Sarebbe troppo facile dire ‘povere bestie’! No, qua c’è molto ma molto di più. C’è la confessione d’un uomo che, novello Sant’Agostino, non trova di meglio, per, appunto, confessarsi, che sterminare una buona porzione di fauna africana. Eran tempi in cui si poteva fare. E adesso se ne pagan le conseguenze; sicché le colline in Africa saran pure verdi, però dopo che c’è passato Hemingway son sicuramente un po’ più disabitate.





