Intervista a Stefano Redaelli, dolenti epifanie poetiche giunte su carta
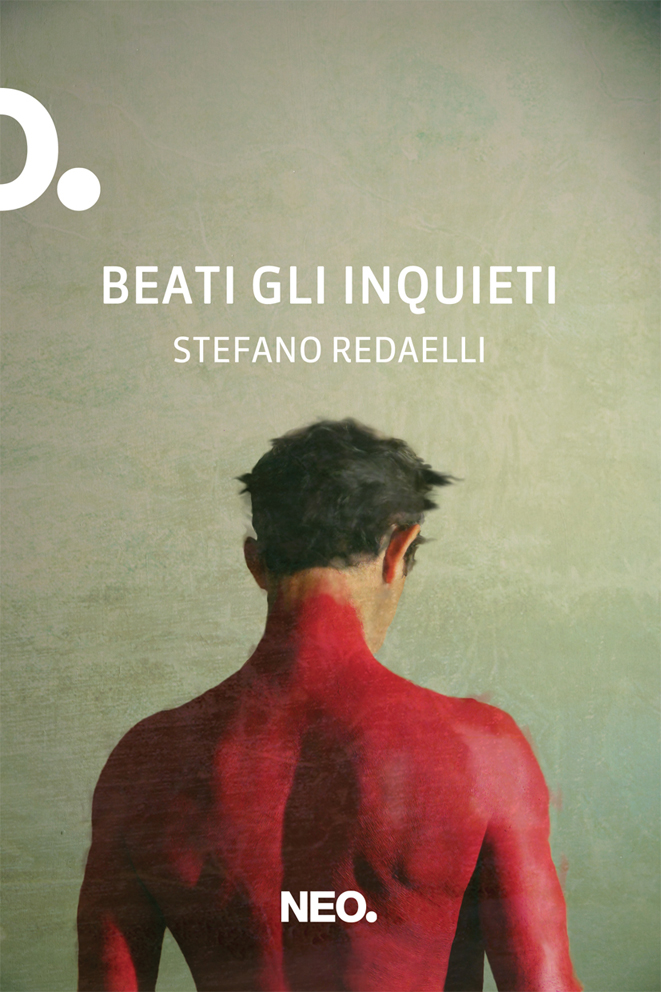
Parlare di Beati gli inquieti significa raccontare la bellezza dell’ascolto; una bellezza che si cela anche dentro storie di dolore e buio abissale. Parlare di Beati gli inquieti è dare voce al silenzio assordante riguardo la malattia, alle strutture psichiatriche, alla solitudine dei pazienti. Parlare di questo libro e farlo con il suo autore, Stefano Redaelli (nella foto in basso), è fare insieme una riflessione; un esercizio accorto di poesia, memoria e consapevolezza.
Docente di letteratura all’Università di Varsavia e osservatore attento e solerte di situazioni sopite; chi è Stefano Redaelli?
Un inquieto? Uno che si interroga, appassiona, compromette. E per questo scrive.
Beati gli inquieti: la letteratura si fa esplorazione dell’ignoto, della follia. Come nasce questo romanzo?
Da un gesto di amicizia, un lungo ascolto, uno studio. Un’amica, molti anni fa, mi invitò a trasformare dei diari, che raccontavano un’esperienza di amicizia con pazienti di una struttura psichiatrica, in un romanzo. Riteneva che in quei diari ci fosse un mondo ancora troppo sconosciuto, temuto, nascosto. Li lessi, mi appassionai. E capii di non poter scrivere un romanzo senza aver fatto un’esperienza simile. Trovai una struttura psichiatrica nella mia città natale, iniziai a frequentarla. Mi misi in ascolto di voci, storie, dolenti epifanie poetiche, invenzioni meravigliose, silenzi abissali. Da quell’esperienza (che non si è mai interrotta) è nato il desiderio di studiare la follia dalla mia prospettiva, ovvero quella delle sue rappresentazioni letterarie. A differenza di altre discipline e scienze, la letteratura non cerca di dare nomi e definizioni (che potrebbero diventare prigioni, manicomi), quanto piuttosto una voce e un volto: più voci e più volti, perché la follia è cangiante.

Si può affidare alla scrittura l’incontro con l’altro e – specularmente- l’esplorazione di sé stesso?
La scrittura è uno strumento straordinario. È una lanterna per muoversi negli spazi bui (perché non ancora illuminati) dell’animo umano. Pensiamo di essere noi a tenerla in mano e farci strada, ma poi scopriamo che è lei a condurci dove vuole, a diradare le ombre. Quel che ci rivela (se è autentica ricerca, coraggiosa ispezione) è sempre una sorpresa. Così è stato nella scrittura di Beati gli inquieti. Non immaginavo che l’inquietudine contenesse una beatitudine. La luce della scrittura si è spinta in uno spazio separato e buio, quello della malattia mentale, dove troppo poco guardiamo, per paura, forse, o per pregiudizio. Ed ha messo in luce una sanità nella malattia, una mitezza nell’inquietudine, una umanità che non avrei mai conosciuto diversamente.
Nel romanzo il protagonista, Antonio, scopre la bellezza dell’ascolto e il potere salvifico della poesia. Qual è il suo rapporto con gli inquieti?
Come dicevo prima, un rapporto di amicizia. È stata una scuola di ascolto e accoglienza. Un ascolto disarmato: occorre deporre le armi della ragione, rinunciare a capire e interpretare razionalmente parole, emozioni, che non vogliono essere necessariamente capite ma innanzitutto accolte. Un’accoglienza fiduciosa: non bisogna aver paura di ciò che non si capisce. Possiamo capire forse il dolore, la poesia? Non li capiamo, li accogliamo, ci facciamo i conti, ci lasciamo trasformare.
Forte il senso di frattura che emerge da queste pagine: da una parte la Casa delle Farfalle e dall’altra la vita fuori. Queste due realtà sono quasi destinate a non incrociarsi mai; o da una parte, o dall’altra. O dalla parte degli inquieti, o da quella del personale sanitario. Una separazione che racconti benissimo, ma sono realtà così inconciliabili?
Quarantatré anni fa, con la Legge 180, nota come Legge Basaglia, sono stati chiusi i manicomi. Molti hanno pensato erroneamente che quello fosse il punto di arrivo di una profonda riforma psichiatrica e culturale, invece era solo il punto di partenza. Quello che la medicina e la politica da sole non possono fare è aiutarci a superare un muro invisibile, “un solco”, lo chiamava Basaglia, che divide il mondo dei sani da quello dei malati. La letteratura può aiutare a riformare il pensiero, a superare il pregiudizio, la paura. Alda Merini scriveva che l’inferno trovato fuori dalle mura del manicomio era stato peggiore dei supplizi elettrici: si riferiva allo stigma, al giudizio della società, che non assolve mai del tutto il malato mentale. Ma cosa ne sa la società della malattia mentale, cosa ne sappiamo veramente? Quanto l’abbiamo ascoltata e quanto invece l’abbiamo messa a tacere, confusa con la voce dell’indigenza e della delinquenza? La letteratura ha dato e continua a dare volti e voci alla follia, mostra prospettive diverse, complementari: quella dello psichiatra (penso ai romanzi di Tobino) e quella del paziente (abbiamo citato Alda Merini), ma anche dei familiari (penso alle opere di Clara Sereni, Carmelo Samonà). Mette questi punti di vista diversi in dialogo tra loro. La letteratura produce esperienza che aumenta la conoscenza. Se si lascia il discorso sulla saluta mentale soltanto alla medicina e alla politica si rischia di averne una conoscenza asettica e un’esperienza condizionata.
Nonostante i diversi tentativi negli anni di “normalizzare” il disagio psichico, oggi questa è ancora una voragine nel sistema sociale e sanitario italiano. Perché tutto questo silenzio?
Si tace, ignora, lascia nell’ombra una realtà, quando si ha paura di affrontarla o non si hanno gli strumenti per farlo. Ascoltato fino in fondo, il disagio mentale, cosa direbbe? Cosa ci chiederebbe di cambiare? Quale riforma del pensiero e della società esigerebbe? C’è un saggio molto bello di Eugenio Borgna e Aldo Bonomi intitolato “Elogio della depressione”, che non è un elogio della malattia, ma del suo ascolto, di quello che la malattia ci dice: l’angoscia, la paura, l’incapacità di dare un significato collettivo alla sofferenza, il valore di una umanissima fragilità che andrebbe riscattata. Quando un uomo si ammala, non sono mai solo il suo corpo e la sua psiche ad ammalarsi, ma l’intero corpo e psiche sociale ad esso connessi. Così, nella cura, in particolare del disagio mentale, deve essere coinvolta la società tutta. Il problema è che si delega alla sola psichiatria la presa in cura e, peggio ancora, alla farmacologia la soluzione silenziosa del problema. Naturalmente, non è questa la strada.





