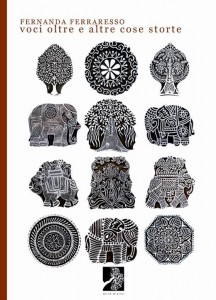 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Immergersi nella poesia di Fernanda Ferraresso è un’occasione imperdibile. Per quella successione di suoni, richiami, echi che le parole scelte riescono a produrre, trasportandoti in un ambiente che si scontorna senza confini certi e sicuri. Voci oltre e altre cose storte, edito nel 2015 da Terra d’ulivi edizioni nella collana rime&rami, è una raccolta corposa e complessa di liriche, che accompagna il lettore in un viaggio multiforme e vario, dalle tante declinazioni e diramazioni.
Come il titolo stesso suggerisce, l’attenzione è subito catturata dal gioco di significati e significanti che si squaderna nelle liriche. Questo gioco ritmico e fonico dà forma a una sostanza molteplice, che comprende principalmente tematiche sociali (“e in molti posti / dove abbattono gli alberi per lasciarci più poveri”) varie. La parola viene presentata “senza una veste / ovvero / nudismo della parola”: “costruire parole senza accorgersi / che dentro e intorno esplodono / non sono muri o case le parole”. Parola che spesso è anche difficile, faticosa da ritrovare, disagevole nella ricerca e nella rappresentazione di una fisica tutta creata e teorizzata in poesia: “dentro i cinque sensi rivòltati / contro la mia testarda intolleranza di perderti / frantuma i miei cieli i miei gesti corruttibili / inventati un silenzio che mi accerchi e dilaghi / dentro e oltre di me cancella la gravità che ci costringe / disegna distanze che si nutrano d’infinito”.
La poesia è un dialogo, con un immaginario “tu” che in ogni occorrenza assume un valore diverso, profondo, una ricerca costante, un volto sempre nuovo e diverso: “lascia che prendano spazio / tutto quello che è in te così che poi / sulla linea principale della mano / quella che corre da nord a sud il nostro mistero comune / ci sia un luogo / uno dove vivere entrambi”. Il desiderio sottaciuto è quello di riuscire a costruire stimolanti altrove, luoghi lontani dall’attualità dove si riesca a far nascere e crescere qualche seme buono: “e una corrente ci porta lontano lontano lontano / dove abitiamo tutti e tutti ci riconosciamo solo toccandoci / solo dandoci una mano”. Ma il “tu”, spesso, diventa anche “altro-io” con cui relazionarsi e confrontarsi, colmando mancanze e ridonando significati profondi: “mi manco sempre un poco / mi manca sempre un poco di quell’altra me”.
C’è anche una continua ricerca nel sé stesso più intimo e profondo; una ricerca che alla poesia e alla sua parola deve molto perché arma indispensabile per tracciare una rotta sicura, anche nella condizione della più assoluta solitudine: “così a lungo un deserto che ho misurato in me / in cui sono andata sempre / sola e solo per andare avanti”.
La narrazione di questa lunga avventura poetica parte da un’origine, potente e feroce, che è quella geografica dell’Africa: “annuso ancora l’aria e / calda violenta / mi riporta l’africa / da cui nasco”. Da lì, un cammino, lungo e faticoso (“otto grani di miglio / otto grani per segnare migliaia di impronte / lasciate sulle strade che ho percorso e / s’intrecciano si biforcano si tagliano e / dentro ci sono / case animali ci sono persone suoni”), che fa rendere l’uomo cosciente di sé e delle sue potenzialità infinite, oltre che delle sue esperienze intense e imprescindibili: “quello che ognuno porta in sé raccolto da storie perdute / anche se non valuta la propria vita in semi da un altrove”.
Tag: migranti
“Crimini contro l’ospitalità”: migrazioni, CIE e detenzione
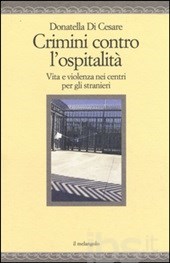 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Donatella di Cesare, insegnante di filosofia teoretica alla Sapienza di Roma, ha avuto il privilegio, concesso a pochissimi, di entrare in un CIE, in particolare quello di Ponte Galeria, a Roma, tra i più grandi di Italia. “Crimini contro l’ospitalità”, edito nel 2014 da Il Melangolo, è il documento nato da quest’esperienza. Il testo si trasforma in un interessante saggio, ma perde quello che sarebbe potuto diventare il suo maggior pregio, ovvero la possibilità di testimoniare direttamente il visto e il sentito in questo luogo dove entrare e vedere sono due azioni praticamente impossibili.
Donatella di Cesare affronta la questione dei CIE, ovvero dei Centri di Identificazione e di Espulsione, in un’interessante prospettiva filosofica, declinando la problematica dal punto di vista della razionalità più pura e cristallina, confutando le idee e i fragilissimi principi che stanno alla base della creazione di queste “isole di non diritto”, questi territori che presentano le caratteristiche evidenziate da Erving Goffman per definire una “istituzione totale”: distanza, chiusura, isolamento.
I CIE, che spesso sono stati teatro di duri scontri e di rivolte da parte degli “ospiti”, non hanno praticamente mai un regolamento interno; ai reclusi, non sono consentite visite né possono parlare con il loro avvocato (quando ne hanno uno); non hanno passatempi, non hanno penne né libri né giochi né attrezzi sportivi. Sono ridotti a bestie in uno zoo, secondo il principio di zoologizzazione degli esseri umani, come sottolineato dalla di Cesare nel suo saggio. La prima violazione dei diritti umani è, però, antecedente ai CIE e avviene al di fuori: è l’arresto, la “detenzione amministrativa” alla quale sono condannati pur non avendo commesso nessun reato. La mancanza di un titolo di soggiorno è diventata reato soltanto dopo il Pacchetto sicurezza del 2009, ma non era mai stata prevista, in nessun ordinamento che si occupi di migrazioni. Inoltre, la detenzione non è decisa da nessun organo di giudizio, dopo un processo penale, ma è una condanna decisa da un’autorità esclusivamente amministrativa: sono chiamati a giudicare, pertanto, dei funzionari di governo e dei burocrati che “non sono membri dell’ordinamento giudiziario, non sono stati eletti, non rappresentano nessuno”. Di Cesare spiega compiutamente e fa vedere con estrema lucidità e puntualità come, all’interno del CIE, l’umanità si deformi perché si deformano le dimensioni più caratteristiche dell’uomo, a cominciare dal tempo e dallo spazio; brutalizzando l’uomo, riportandolo a una condizione primordiale e animale, lo scopo è quello di brutalizzarlo, di privarlo di dignità – un affronto che si assomma alla punizione per un crimine, come abbiamo visto, mai commesso.
Si potrebbe, con la massima attenzione, utilizzare per lo scritto di Donatella di Cesare la definizione di “reportage filosofico”, anche se non si può non sottolineare la mancanza di una parte di maggior reportage.
Yahya Hassan: la poesia violenta di un’identità.
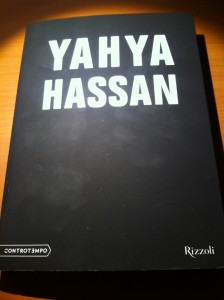 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – È stata la raccolta poetica più venduta in Danimarca. Accanto ai nomi di Karen Blixen, di Søren Kierkegaard, di Hans Christian Andersen, Yahya Hassan ha imposto anche il suo, che campeggia deciso, bianco su fondo nero, sulla copertina della sua silloge (Rizzoli, 2014); che non ha titolo, tranne, appunto, il suo nome. Yahya Hassan è un palestinese, classe 1995, apolide. Il suo passaporto, adesso, è danese. Ma la sua storia è quella di un ragazzo in cerca di un’identità. Una ricerca feroce e tremenda, che lo ha portato in tante comunità adolescenti (“E quanti tutti sono stati picchiati e mandati nelle stanze / si beve il caffè”), separato dai genitori e dai fratelli, in una ribellione continua a una cultura di origine che oramai era lontana e a una cultura di arrivo che lo rifiutava e non lo accettava: “A scuola non si può parlare in arabo / a casa non si può parlare danese”.
Violando qualsiasi regola della netiquette, le poesie di Yahya sono tutti scritte in maiuscolo, quasi fossero gridate dalle pagine bianche. E quello di Yahya Hassan è proprio un grido, feroce, furioso: è una protesta indocile, cruda. L’umanità viene scarnificata, ridotta all’essenziale; e l’essenziale è violenza, spesso gratuita ma in ogni caso pare imprescindibile, irrimediabile. Yahya non si fa problemi nel raccontare aspetti cruenti e mortificanti: tra le righe è però evidente il disagio, il rischio dell’annichilimento, l’ostilità verso un modo precostituito e completamente attrezzato nel difendersi contro un nemico inesistente. Il conflitto con il padre (“Cinque figli in fila e il padre con la mazza”), l’ostilità verso una nuova madre con nuovi fratelli e sorelle (“Ma sua moglie dice / che non devo toccare i suoi figli”), diventa ben presto exemplum di un’ostilità rivolta all’autorità, che comanda e bastone, che impone e obbliga, piuttosto che cercare di comprendere ed armonizzare: “Altri educatori / spaccano il vetro e mi danno una ripassata”.
La lucidità di questo diciannovenne è incredibile, sbalorditiva: “E tu dici che vorresti / non fossimo mai nati”. Meglio di qualsiasi trattato di sociologia o antropologia riesce a coinvolgere il lettore, a trascinarlo in una serie di teorizzazioni (sotto forma di poesia, ovviamente) che riguardano la nostra epoca, i nostri nuovi anni Dieci. L’integrazione fallita, il rifiuto di un modello di meticciato, l’inesistente disponibilità all’accoglienza: “È così che si muove il traffico / fatto in un autobus fermo al rosso al Digterparken / un gruppo di negri scende a Søren Frichs Vej / oltre il ponte – un altro ghetto”; e, di conseguenza, il riaffermarsi di modelli autocratici e razzisti, l’incapacità di gestire l’alterità (“Lo psichiatra controlla a tutti la testa e il culo / e le bocche vengono riempite di psicofarmaci”), l’individuazione di un capro espiatorio che sia “l’altro”, il “diverso”, la minoranza debole e scarsamente difendibile: “13 anni e ricercato salgo su un treno per la Danimarca”.
Spesso, però, come si evince da queste poesie, è la stessa minoranza che non può fare a meno di sentirsi tale: circondata dall’odio, dal disagio dell’incontro, dall’ostilità più o meno aperta rischia di diventare referente di (e a) sé stessa. E di nuovo si richiude in forme ancora più crudeli di esclusione e precarietà: “Sono sonno senza sogni / come una spia in isolamento volontario”.
“Immagina di essere in guerra”: e se i profughi fossimo noi?
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Assumere un altro punto di vista non è compito semplice. Né immediato. Come potrebbe cambiare l’angolazione se ci si mettesse dall’altra parte del banco degli imputati? Spesso la difficoltà sta nella paura di sentirsi colpevoli. Il piccolo volume di Janne Teller ci chiama proprio a questo: deporre la maschera dell’ipocrisia, soffocare l’omertà, ripudiare la latitanza e avere il coraggio di capire. E se fossimo noi, in guerra? E se fossimo noi bombardati, inseguiti, uccisi, trucidati? “Immagina di essere in guerra”, edito da Feltrinelli (2014) con le illustrazioni di Helle Vibeke Jensen, ha il formato di un passaporto: il documento fondamentale per scappare e salvarsi. Che noi teniamo distrattamente in un cassetto del comodino ma che per tante altre persone al mondo rappresenta l’unico strumento di salvezza. Pensato anche per i più piccoli, il testo della scrittrice danese è uno strumento potente di pensiero e di riflessione, in un momento storico come il nostro di grandi cambiamenti e di imponenti forzate migrazioni.
In realtà, la nostra immedesimazione non sarebbe così complessa se ci ricordassimo della nostra storia recente, recentissima. Quella dei primi decenni del secolo scorso, di quei 29 milioni di italiani che dall’Unità d’Italia se ne sono andati all’estero, profughi, per cercare un domani migliore. Ma quando osserviamo i barconi che si avvicinano alle nostre coste, la paura dell’invasione ci paralizza, o piuttosto ci scatena un’irrazionale paura. Tutti gli altri problemi, i veri responsabili, finiscono per essere tralasciati in nome di un pericolo inesistente e inconsistente ma più presente, evidente, più facilmente codificabile e identificabile. Non pensiamo mai a cosa possa significare essere costretti ad abbandonare il proprio paese, la propria casa, i propri affetti, i propri familiari orizzonti per affidarsi a un caso furioso, più spesso crudele e feroce che non risparmi nessuno e di nessuno ha rispetto. Che siano uomini, donne o ancora bambini. Se non addirittura neonati. Non ci chiediamo mai cosa possa significare affidarsi a percorsi ignoti, lasciarsi in mezzo alla sabbia e alla confusione delle rotte, consegnarsi a un mare nero che è stretto nella notte e non accoglie, ma al massimo respinge e rompe in naufragio. Non ci chiediamo mai cosa davvero significhi il termine “casa”: “Ma dov’è casa?” si chiede, infatti, Janne Teller terminando il volume, come se la ricerca non finisse mai, indipendentemente dall’approdo, dallo sbarco ultimo e definitivo.
L’Europa (vincitrice di un improbabile Premio Nobel per la pace) fonda i suoi principi su quelli della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: “Tutti gli essere umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. Ma così veramente ci comportiamo? Se fossimo noi, in guerra, ci sentiremmo accolti da un paese come l’Italia?
“Sotto il cielo di Lampedusa” le parole di dolore.
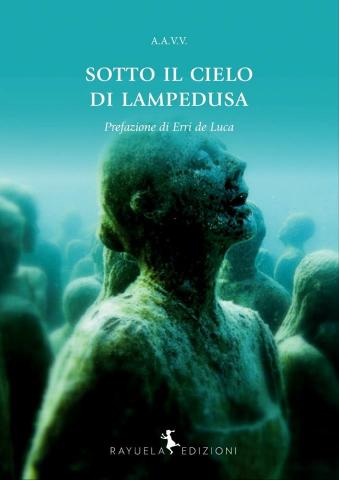 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Fu nel 2011 che i poeti Michael Rothenberg e Terri Carrion lanciarono un appello mondiale: far tornare la poesia al suo antico – e oramai dismesso – ruolo sociale e civile. Utilizzare la parola poetica, cioè, per chiedere cambiamenti umani, civili, culturali, economici, ambientali. Nacque il movimento 100 Thousand Poets for Change, che giorno dopo giorno, poeta dopo poeta, si è esteso fino a comprendere 115 paesi del mondo. A Bologna esiste il gruppo più produttivo e attivo dell’Italia, che ha già organizzato manifestazioni ed eventi collettivi. All’indomani del tragico episodio del 3 ottobre, quando morirono 366 migranti per il naufragio della loro imbarcazione, è nato il progetto editoriale di “Sotto il cielo di Lampedusa”, edito da Rayuela Edizoni (2014).
Un progetto collettivo, in cui raccogliere poesie e autori che ponessero l’attenzione sul dramma del Mediterraneo, sull’inaccessibilità della “Fortezza Europa”, sugli “annegati da respingimento”. Tante le voci che hanno aderito al progetto, tante le accuse rivolte ai veri responsabili di queste tragedie marine, che potrebbero essere tutte evitabili, semplicemente, con una politica più attenta di visti e cordoni umanitari.
“Un confine per segnare la linea / in una retta si chiude perfetta / in una traccia / su un figlio senza abbracci / senza identità né case a cui ritornare”, scrive Meth Sambiase. I motivi per cui si parte sono tanti, troppi. E non dovrebbero essere sempre giustificati; perché si parte anche semplicemente per il desiderio di farlo, senza doversi sentire in colpa del danno e della noia che si recano agli altri. “Ma tornare indietro / è difiscile / stare qui / difiscile / il mio tempo te lo do / la schiena il corpo te lo do / in cambio di un cartoccio / ma la faccia l’espressione degli occhi / la bocca // se vuoi sparare spara in cielo / noi non siamo / uccelli” (Maria Luisa Vezzali). E di fronte a questa sconvolgente realtà, anche la poesia trema e si sente in un certo senso impotente, inutile: “Io resto nella mia cuccia a guardare che piove / mentre la morte si veste di ottobre e di vento / mi sento cadere di foglie e parole svendute / inutile, come un verso che non dice poesia” (Annamaria Giannini). Ma, come scrive Giacomo Sferlazzo del Collettivo Askavusa, “Il mare non ha colpe”, perché le colpe sono tutte degli uomini, delle loro leggi assurde, delle loro paure archetipe, del capro espiatorio che sempre, in ogni momento, deve essere creato per alleggerirsi le coscienze – come se dalla Storia non si potesse mai imparare nulla: “Il popolo italiano sempre innocente, sono loro, quelli che stanno / al Governo e in Parlamento, che hanno fatto le leggi / sui respingimenti, loro hanno firmato i trattati con Gheddafi, / e poi è evidente che tutta questa gente qua non ci può stare” (Francesco Sassetto).
E l’orrore, il disgusto delle 20.000 vite perse per sempre nel fondo del mare, durano poco, quasi solo il tempo di un errore. E poi si finisce, come sempre, nel silenzio dell’omertà, nella frenesia dell’informazione che fa notizia, crea lo scoop, e poi si rigira pigramente verso altri interessi più attraenti, come scrive Sassetto: “Noi dalle nostre rive sfogliamo stancamente il giornale / che già annuncia nuovi barconi in avvicinamento, assuefatti / alla compassione ad intermittenza, noi coristi del coro / che grida forte e freme, / e tace nuovamente il giorno dopo”.
“La prigione degli stranieri”: un passato da cui non si impara mai niente.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – In passato, esistevano i campi di concentramento. Pagina dolorosissima dell’umanità, raccapricciante nella lucida sistematicità dello sterminio. In realtà, di campi ne sono sempre esistiti, in ogni piega di mondo. Quasi irrazionalmente, l’uomo si è sempre più sentito sicuro sapendo che altre persone – quelle che, in quel dato momento, venivano sentite come più minacciose – fossero rinchiuse in un altro luogo, in un altrove di separazione. Il testo di Caterina Mazza, edito da Ediesse (2013), ci accompagna con perizia e competenza alla conoscenza de “La prigione degli stranieri”, ovvero i CIE (Centri di identificazione ed espulsione) che costellano la penisola italiana.
La storia dei CIE, che hanno cambiato un’infinita di nomi piuttosto grotteschi, ha le sue origini nel Trattato di Schengen, ovvero proprio in quel documento che voleva garantire in tutta Europa, per renderla più “unita” e meno “vincolante”, la libera circolazione di uomini e merci. Ma, parafrasando Orwell, anche in tema di libertà, alcuni uomini sono più uguali di altri. Il diritto fu garantito a chi fosse europeo, un po’ meno a chi fosse in Europa per lavoro, per studio, per richiamo familiare, per qualsiasi altro motivo.
Il concetto di libertà non richiama soltanto l’idea di potersi muovere senza vincoli e senza restrizioni, ma implica anche il sapersi sempre al sicuro, esente da rischi e penalità. Situazione che non si verifica oggi, dal momento che fino a qualche giorno fa l’immigrazione clandestina, ovvero il trovarsi sul territorio nazionale sprovvisti di un documento (visto o permesso) regolare implicava il commettere un reato penale. Significava che la stessa esistenza di una persona, la sua vita, il suo essere hic et nunc, fosse una colpa paragonabile a un omicidio.
L’adozione dei CIE non è solamente una decisione di casa nostra, ma come in tutte le cose peggiori, anche l’Italia si è adattata agli altri paesi europei: dalla Spagna alla Grecia, in particolare nella Svizzera e nei paesi del Benelux, esiste una galassia, più o meno legale, di centri di detenzione, dove stazionano per un tempo parecchio oscillante tutti i migranti, non importa neanche se minorenni, malati, donne, transessuali, in attesa di ottenere un documento dalle rispettive ambasciate che permetta di rimpatriarli nei paesi di origine. Son territori, i CIE, dove quasi non esiste legge, dove i diritti son calpestati continuamente, dove la mancanza di libertà è dovuta semplicemente a un colpa che, se vogliamo proprio definirla tale, appartiene alla sfera amministrativa.
Le migrazioni hanno caratterizzato da sempre la storia dell’umanità. Fermare l’uomo è impossibile, persino assurdo. Pretendere che l’uomo reprima il desiderio di sfidare gli orizzonti e di cercare un futuro e una speranza migliore per sé e la sua famiglia è grottesco. Ostinare a considerare i migranti come banditi, negandogli persino il diritto costituzionale della presunzione di innocenza, è incredibilmente criminale.
“I dannati della metropoli”: migranti tra lecito e illecito.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – La legge sull’immigrazione italiana è una legge che, inevitabilmente, “costringe” i migranti a muoversi dai territori della legalità a quelli opposti dell’illegalità. E l’illegalità può portare con sé, inevitabilmente, l’esigenza di delinquere, anche solo per la semplice sopravvivenza. Sono molti i migranti che decidono di sottomettersi a contemporanee forme di schiavitù e sfruttamento, pur di non intraprendere percorsi criminali, ma ci sono anche coloro che si ribellano, cercando di affrancarsi a queste forme di razzismo istituzionalizzato. Andrea Staid, storico e antropologo, ha pubblicato per Milieu Edizioni, “I dannati della metropoli. Etnografie dei migranti ai confini della legalità” (2014), volume che in un certo senso fa da pendant al precedente “Le nostre braccia”.
In “I dannati della metropoli”, dopo aver ben descritto e motivato la sua metodologia di ricerca, che si basa sull’osservazione partecipante, teorizzata per la prima volta dall’antropologo Malinowski, Staid si pone come obiettivo quello di esaminare e analizzare “i nessi tra strutture generali di potere e forme di soggettività, capire come e perché si sceglie di delinquere e di ribellarsi ai soprusi quotidiani”. E per questo fine, decide di dare voce, direttamente, ai migranti (di ogni provenienza e di ogni destinazione) che si trovano a vivere, concretamente, sulla loro pelle, le difficoltà che comporta non avere o dover continuamente rinnovare un titolo di soggiorno, ma anche a chi cerca di districarsi nelle quotidiane problematicità di un lavoro, di un affitto da pagare, di una famiglia da mantenere. Le interviste non strutturate che Staid ci offre nel testo, come materiale primario da cui trarre poi considerazioni e valutazioni, sono potenti di vita, pulsanti di esigenze e bisogni reali, concreti, crudi. Non ci sono filtri, non ci sono mediazioni. C’è la vita; e basta. Quella alla quale non si pensa mai, perché comporterebbe un’indolente ammissione di colpa, la presa di consapevolezza di una soffocante omertà.
L’analisi della realtà italiana si scompone in cinque percorsi: si parte con la narrazione di storie relative ai viaggi, quelli famosi attraverso il Sahara, ma anche di meno noti e giornalisticamente gettonati; poi si prosegue con il capitolo dolorosissimo sui CIE, i Centri di Identificazione ed Espulsione, e sulle moderne forme di lager istituzionali, di cui la penisola è disseminata; ci si avventura, poi, nell’analisi della realtà carceraria italiana e i motivi dell’alta presenza di stranieri nei penitenziari italiani. L’ultimo capitolo, invece, rappresenta un curioso e stimolante racconto dell’esperienza di Staid all’interno di Bligny 42, un palazzo milanese a lungo ribattezzato “il fortino della droga” ma che è, invece, piuttosto un “condominio mondo”, traboccante di umanità e di storie “migranti”, di quotidianità partecipate. Un meticciato che è ricchezza, potenza, suono e colore. Che consente infinite possibilità di ricerca e offre altrettante potenzialità di risposte per un futuro che sia più conciliante e lungimirante.
“Lampedusa”, quale futuro per la porta d’Europa?
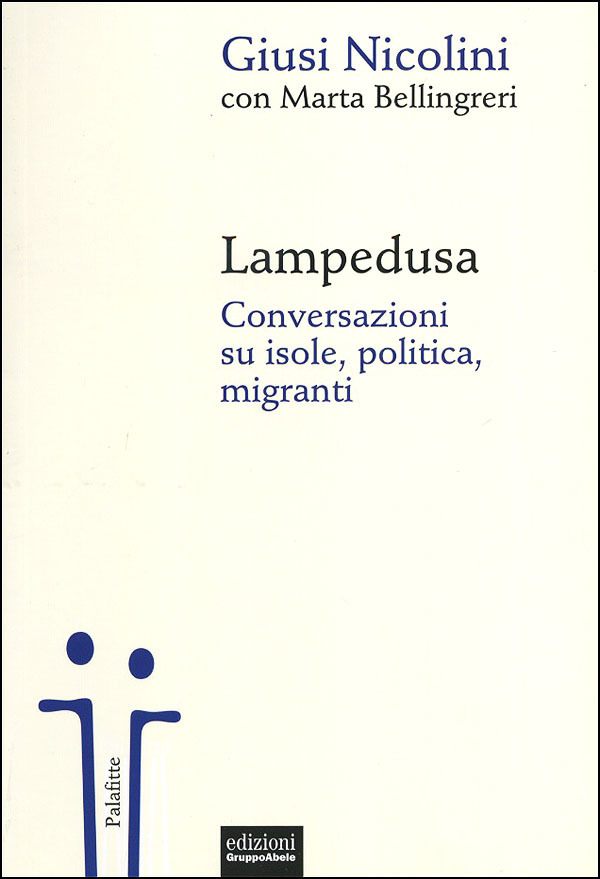 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Giusi Nicolini da sempre alza la voce in difesa di terre e uomini. Da quando è stata eletta sindaco, nel 2012, ha portato all’attenzione dell’Europa intera quei ventun chilometri scarsi di terra che amministra. Marta Bellingreri l’ha intervistata, nel luglio 2013, e questa lunga chiacchierata è stata pubblicata dalle Edizioni Gruppo Abele nel 2013 nella collana “Palafitte”. “Lampedusa. Conversazioni su isole, politica, migranti” è un manifesto di grande lucidità e acutezza, nel quale Giusi Nicolini, diventata uno dei sindaci più famosi d’Italia, racconta la sua storia, la sua decisione di dedicarsi all’amministrazione politica delle sue terre, e tratteggia con grande competenza quelli che potrebbero essere gli orizzonti futuri per Lampedusa, la porta dell’Europa.
Giusi Nicolini parla delle migrazioni, del ruolo che Lampedusa ha nell’accogliere le persone in fuga da una realtà feroce, da malattie, dalla guerra, dalla fame. Parla del cimitero che non basta, dei diritti negati anche da morti, parla dei tanti troppi minori non accompagnati che viaggiano sulle rotte del Mediterraneo e che sono abbandonati, senza cure né assistenza. Tra i tanti progetti realizzati si cita anche la Biblioteca dei ragazzi, realizzata grazie a un progetto di Ibby Italia, nella quale saranno utilizzati molti silent books, libri senza parole ma con tante immagini, realizzati per superare le barriere linguistiche tra i bambini italiani e quelli migranti.
Ma non ci sono migranti, nella storia di Lampedusa. C’è anche l’ambiente, una risorsa straordinaria che fino a pochi anni fa era seriamente minacciata dall’uomo e dai suoi abusi di vario ordine e grado. Quell’ambiente che recentemente ha conferito alla spiaggia dell’Isola dei Conigli il titolo di spiaggia più bella del mondo. Un riconoscimento anche al lavoro della Nicolini, che per tanti anni è stata responsabile di Legambiente della Riserva dell’Isola dei Conigli, una delle ultime spiagge europee dove si riproducono le tartarughe marine, le Carretta, che a Lampedusa vengono recuperate e, in un apposito ospedale, curate.
La lunga intervista con Giusi Nicolini mette in luce le potenzialità e le reali esigenze di un’isola, e di una terra, per lungo tempo dimenticata, trascurata ai margini dell’italianità in ogni settore, da quello scolastico-sanitario a quello sanitario, a quello dell’approvvigionamento idrico ed energetico. Un’isola che strategicamente ha la sua importanza, tanto da essere diventata sede di una base NATO, e di esser stata vittima di un attacco missilistico dalle coste libiche, nel 1986, ad opera del Colonnello Gheddafi.
Ma la Nicolini ha parole di accusa anche per la politica italiana, per i partiti, per i meccanismi del potere che vogliono sempre ricondurti in una definizione, in una schematicità. La sua battaglia si definisce quasi apolitica, sfidando preconcetti e pregiudizi che sono propri di intere collettività umane. I valori che sono difesi, le aspirazioni ventilate, gli obiettivi sperati sono patrimonio comune, non esigenze da manifesto partitico o campagna elettorale.
“Io ero l’Africa”: l’istinto primordiale della madre terra.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Una saga familiare appassionante. Se si dovesse dare una definizione all’ultimo romanzo di Roberta Lepri, “Io ero l’Africa”, edito da Avagliano Editore nel 2013 probabilmente questa sarebbe la più calzante. Ma, in realtà, nelle pagine della Lepri c’è ben di più. Innegabile come le atmosfere del romanzo ci riconducano alle migliori pagine di Karen Blixen, fino addirittura al fallimento dell’attività e alla frustrazione umana di fronte alla potenza devastante (e ribelle) della natura. Ma l’esperimento della Lepri è affascinante innanzitutto perché calato nella nostra condizione di italiani migranti ed emigranti (che in giorni come questi passa sempre un po’ di mente) e poi perché ci offre uno sguardo d’insieme, una prospettive esterna e distaccata sulla narrazione e la trama.
L’Africa trasforma e cambia: è evidente. La sua potenza naturale, le sue emozioni scorrono sotto la terra e corrompono gli uomini, li cambiano. Sottopelle, sentono e scoprono nuovi tremori, nuove passioni; si scoprono finanche nuovi caratteri. Placano antiche ansie e smarcano da primitive schiavitù, come quelle della quotidianità, della routine, della vita borghese. In Africa, tutti diventano esploratori e conquistatori, alle prese con un mondo primordiale che non si conosce e che, a lungo andare, finisce per ubriacare.
Attraverso le pagine di “Io ero l’Africa” ci si avventura nelle vite più intime dei protagonisti, nessuno dei quali esce indenne da quest’esperienza di “esotismo”. Chi matura, chi regredisce, chi si scopre suo malgrado vulnerabile, chi viene inesorabilmente sconfitto. Tutti vanno incontro a una formazione individuale. E sono proprio i rapporti che per primi si sfilacciano e si spezzano, nel romanzo. I legami coniugali, quelli parentali, quelli fraterni, i rapporti di potere e di oppressione, lo scontro senza tempo del nero e del bianco, del civile e dell’incivile, del colonizzatore e del colonizzato. In “Io ero l’Africa” sono tutti tarati secondo nuovi concetti, nuovi modelli. Inconsapevolmente, soprattutto Angela, la vera attante di tutta la saga, dal nome prevedibilmente profetico, si conosce (e si sorprende) come donna nuova, insospettabile nel suo appena disvelato carattere, nelle sue (ri)nate aspirazioni e desideri. È una donna che nessuno conosce più, né il marito che dopo due anni la fa andare in Africa, né suo figlio che la ritrova dopo anni e ne avverte subito le nuove vibranti potenzialità. Ma tutti i protagonisti del romanzo sono tratteggiati con penna potente, guidati e mossi da una matura orchestrazione. La materia del romanzo è densa, corposa, e l’architettura narrativa accompagna il narratore quasi cullandolo, attraverso un ritmico alternarsi di analessi e prolessi. La storia è un fluire continuo, tumultuoso ma non disordinato, un appassionato fermento di eventi ed emozioni. Pare quasi di sentire una storia raccontata intorno a un fuoco, in una notte africa sotto un cielo denso di chiassose e pulsanti stelle.
I “Sogni di sabbia” e il paese dell’uomo bianco.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – A Lampedusa non si è ancora chiusa la contabilità dei morti dell’ultimo incidente. Il naufragio del 3 ottobre scorso ha riacceso i riflettori sulla problematicità delle traversate dall’Africa all’Europa, ridestando le coscienze e sorprendendo ipocrisie e omertà. Ma le morti delle persone che partono dalle coste africane per raggiungere l’Europa, per fuggire guerre e torture, per salvare sé stessi e le proprie famiglie, per poter almeno sperare in un orizzonte migliore, sono silenziose, non fanno né rumore né notizia, non sgomentano coscienze né scuotono dubbi. E dietro ogni rotta, dietro ogni partenza, ci sono volti, ci sono storie, ci sono ragioni e motivazioni diverse. “Sogni di sabbia”, il libro fotografico edito dalla Infinito Edizioni nella collana GrandAngolo, è una sorta di Spoon River migrante (e “clandestina”). Le foto rigorosamente in bianco e nero di Kays Djilali raccontano alcune persone candidate a essere “aspiranti clandestini”, ovvero migranti in partenza che, una volta approdati in terra europea, avranno scarsissime possibilità di mettersi in regola con le severe leggi europee sull’immigrazione. Sono gli harraga, coloro che “bruciano la frontiera”, che partono pur non potendo, sperando di arrivare.
Le fotografie, questi occhi e questi volti, questi sorrisi e questi sguardi, sono stati colti in vari luoghi, nel 2006: da Algeri a Madrid. Ovvero, tra coloro che ancora attendono (e sperano) una partenza a chi invece è riuscito ad attraversare il “mare di mezzo” e a stabilirsi, in qualche maniera. Ad accompagnare le immagini, ci sono le testimonianze. C’è la storia del calzolaio Youssouf, ivoriano, che lavora in Algeria per mantenere la famiglia, ma che ha chiaro come il concetto di “frontiera” sia solo un palliativo: “Laddove il destino ti porta, è lì che rimani”. C’è la storia di Mehdi, un marocchino arrestato in Libia mentre tentava di raggiungere l’Italia: “Conosco dei marocchini che sono morti. È l’angoscia che li ha uccisi. E la tortura”. C’è la storia di A., un camerunense che vive in un ghetto al Algeri: “Ho visto gente diventare pazza. Non hanno più niente per andare avanti né per tornare indietro”, imprigionati in un deserto che non conosce resurrezioni. E c’è la storia di Chaibi Mohamed che cerca suo figlio, Benchaa, scomparso il 13 febbraio 2006: “Vorrei sistemare una stanza speciale per mio figlio e metterci tutte le sue foto e le sue cose e chiuderla”. E c’è la storia di C., un altro camerunense che racconta l’attraversamento verso le coste mediterranee: “Seppelliamo i nostri fratelli nel deserto”. E la traversata del Sahara la ricorda anche Haddane Koné, ivoriano: “Mi ricordo, durante il cammino, di aver portato i miei amici sul dorso, gli ho dato da bere, ho dato loro il mio respiro”. Tutti coloro che partono sono uomini, sono donne, spesso sono bambini. Non sono clandestini; sono solo persone in movimento che cercano la libertà, il benessere, la rivincita. Spesso, pensando esclusivamente alle proprie famiglie. Ma, per tutti, “il paese dell’uomo bianco è lontano, / non ci si può andare in treno. // Il paese dell’uomo bianco è difficile”.





