 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Era il 1962 quando due grandi rivali del grande schermo si ritrovarono a condividere una sceneggiatura. Soltanto un film come “What ever happened to Baby Jane?” poteva avere la suggestione e la potenza di riunire Bette Davis e Joan Crawford in un capolavoro del genere macabro, un capolavoro inquietante e sconvolgente, una metafora ben elaborata di come la solitudine umana possa diventare terrore e di come la gelosia sappia trasformarsi in persecuzione. In una stagione cinematografica in cui i film, molto spesso, radicalizzavano gli ambienti (i loro vizi e le loro virtù) della grande industria hollywoodiana (celebre il noir “Sunset Blvd.” con la grande Gloria Swanson che pone la pietra tombale, finanche grottesca, alla grande stagione del muto), “Che fine ha fatto Baby Jane?” porta all’estremo il fenomeno delle piccole enfant prodige alla Shirley Temple, condannate a una carriere brillante e sfolgorante quanto a un oblio lungo e drammatico. E nel crollo psico-fisico, la piccola Baby Jane trascina anche la sorella, la stella hollywoodiana Blanche Hudson, coinvolgendola in una spirale di tensione psichica che ben presto assume i connotati di una vera e propria patologia. Il film, che ottenne un successo sincero e meritato, fors’anche reso ancor più evidente da una reale antipatia tra le due grandi dive del cinema, era basato sul romanzo di Henry Farrell, edito nel 1960.  Le differenze tra i due prodotti sono evidenti e significative: l’escalation alla violenza viene dipanata nello stesso modo, a partire da una proiezione di vecchi film per celebrare la diva Blanche; e le violenze della sorella Jane si scatenano, accelerate dall’omicidio e alimentate dalle fobie, dalle illusioni e dagli inganni di una mente sconvolta e non più salutare. Tutto si consuma all’interno delle mura gelide di una casa antica, simbolo di un passato che non può essere recuperato, che ricorda ancora – per entrambe – i giorni delle felicità più estreme, pieno di reliquie e di rimasugli polverosi e infranti di sogni e avvenire sfioriti. È una casa che imprigiona, che impedisce contatti, che segrega mentre tutto il mondo, fuori, si chiede cosa accada dentro; ma mentre nel libro è dal mondo esterno che parte il moto di rivolta e la chiave di svolta, nel film la solitudine delle due donne si fa sempre più asfissiante, più claustrofobico, mentre il mondo riesce soltanto a sospettare un disagio sorprendente.
Le differenze tra i due prodotti sono evidenti e significative: l’escalation alla violenza viene dipanata nello stesso modo, a partire da una proiezione di vecchi film per celebrare la diva Blanche; e le violenze della sorella Jane si scatenano, accelerate dall’omicidio e alimentate dalle fobie, dalle illusioni e dagli inganni di una mente sconvolta e non più salutare. Tutto si consuma all’interno delle mura gelide di una casa antica, simbolo di un passato che non può essere recuperato, che ricorda ancora – per entrambe – i giorni delle felicità più estreme, pieno di reliquie e di rimasugli polverosi e infranti di sogni e avvenire sfioriti. È una casa che imprigiona, che impedisce contatti, che segrega mentre tutto il mondo, fuori, si chiede cosa accada dentro; ma mentre nel libro è dal mondo esterno che parte il moto di rivolta e la chiave di svolta, nel film la solitudine delle due donne si fa sempre più asfissiante, più claustrofobico, mentre il mondo riesce soltanto a sospettare un disagio sorprendente.
Jane tenta di recuperare un passato nel quale era lei la stella brillante, la più luminosa; rasenta il ridicolo cercando di trasformarsi di nuovo in un enfant prodige, riesumando le sue sdolcinate canzoni e riprovandosi gli antichi costumi di scena. Ma inconsapevolmente era stata proprio lei l’anima tiranneggiata e sopraffatta dalla sorella, la cui vendetta era stata più lunga e silenziosa ma fors’anche più crudele e meschina.
Categoria: recensione
“Soltanto la memoria è bella. Il resto è polvere e vento”
 Dalila Sansone
Dalila Sansone
GRAZ – “Nulla potrà riscattarci. Tu saprai cosa fare per serbare il ricordo di quanti meritano di essere salvati dall’oblio. Soltanto la memoria è bella. Il resto è polvere e vento.” Alla fine del libro questa frase suona come un imperativo. Una sorta di obbligo morale a cui ti senti vincolato, tu che tante cose non le sapevi, tu che ti eri fermato distrattamente a pensare che la storia avesse uno spessore diverso da quello del corpo di un uomo e quando l’avevi fatto fisicità e anima, passi per strada non li avevi “sentiti” abbastanza muoversi dietro di te.
“Il club degli incorreggibili ottimisti” di J.M. Guenassia (Salani, 2010) racconta un frammento della Parigi degli anni ’60, sullo sfondo la guerra in Algeria, l’imperversare del rock ‘nd roll, le defezioni da Est, la costruzione di muri invalicabili. Fisicamente, ideologicamente, emotivamente. E’ difficile dare una definizione all’opera di Guenassia: la narrazione si costruisce su più livelli, le vite non si appartengono e forse nemmeno si intrecciano, si incontrano un giorno per strada e si ritrovano a giocare a scacchi al Balto, un bistro. In un pomeriggio distratto potrebbe anche capitare di vederci seduti Kessel e Sastre lì. Insieme. L’unica regola di quello strano club è parlare in francese. Nessuno racconta da dove viene, chi era o cos’era. Se scegli di sopravvivere devi smettere di parlare, reinventare tutto di te e vivere un presente continuo fatto di alcuna altra prospettiva se non la vita e nessuna retrospettiva per non affogarci dentro. La memoria è un fatto privato, una piega interiore che le labbra non scandiscono per paura di ferirsi e ferire. Eccolo il tratto comune tra i membri del club: esistere, esistere adesso e non lasciare spazio a quello che non può farlo più. Al Balto impera la democraticità dell’assurdo, della fredda perfezione con cui si può cancellare l’esistenza, non importa se con la morte o con l’oblio. Solo che i ricordi di cui quelle esistenze sono la somma restano nello stesso modo delle poesie imparate a memoria, rubate ai fogli da bruciare, e vivono anche se in silenzio, rivivono tutte le volte o la volta soltanto in cui vale la pena che lo facciano.
Michel ha dodici anni quando si accorge della tenda verde che copre la porta d’ingresso del club e separa il calcio balilla e gli avventori ai tavoli dagli scacchi; nei quattro anni successivi imparerà che siano le ideologie, le circostanze o le decisioni di chi ci sta intorno, l’unica possibilità di scelta è limitata a cosa fare proprio di ciò che rimane. Non si poteva scegliere quanto sarebbe accaduto e brucia la sensazione che forse nemmeno quello che potrebbe accadere ancora dipenda fino in fondo proprio da noi.
E’ intessuto di umanità questo libro, nonostante qualche piccolo cedimento ai cliché del romanzo, ti sferra colpi allo stomaco improvvisi, netti e rimane capace comunque, sempre, di strapparti un sorriso. D’altra parte è la vita che fa questo gioco, a volte sembra tessere la trama di un lieto fine, altre sa essere spietata e intrisa nell’inspiegabile ma nella sua immediatezza è quella che è, qualunque sia stata e a chiunque sia appartenuta e a Guenassia riesce raccontarla con tocco lieve e la giusta ironia.
Già! Perché proprio “degli incorreggibili ottimisti”? – Michel! Sei vivo, per te tutto è possibile! –
“Nessuna esperienza richiesta”: felici e precari
 Marianna Abbate
Marianna Abbate
ROMA – Ho conosciuto un tale di quarant’anni con il posto fisso statale e più di cinquemila euro (!) di stipendio che amava definirsi “precario della vita” (sic!). A nulla è valsa la mia faccia disgustata e il mio tentativo di spiegare che “precariato” non è una condizione dovuta alle scelte personali, all’inettitudine e alla pigrizia, ma uno stato di disagio sociale strutturale. Il precario non si arrende, il precario rema controcorrente, insiste. Se si fosse arreso, quel contratto a breve scadenza non l’avrebbe mai trovato, o sarebbe già scaduto. I precari non sono dei falliti: è il sistema ad essere fallimentare.
Descentio, il protagonista di “Nessuna esperienza richiesta“, edito da Intermezzi, non è un fallito. Nonostante ci si senta fortemente.
Gianluca Comuniello ci ritrae con la tecnica del cubismo pittorico, tutti gli aspetti della sua personalità, tutti gli aspetti della sua vita, senza mai svelarlo completamente. Cambi repentini di narratore aiutano a mostrare quel senso di instabilità, di insoddisfazione e sempre più tangibile disagio che accompagnano Descentio in tutta la sua storia.
Perché Gianluca si sente un po’ Descentio, e forse l’unica cosa che non li accomuna è questo nome parlante, che sembra segnare disgraziatamente il destino dell’uomo di carta. Un nome volutamente altisonante, che invoca una gloria passata in opposizione all’attuale ineluttabile discesa.
Uno stato che non affligge solo il protagonista, ma un po’ tutti i suoi conoscenti, dall’amica sfortunata, all’esule calabrese. Tutti tranne una: Greta, la ex che non sbaglia un colpo. quella che quando dice cosa ha studiato, nessuno le fa le condoglianze.
Bhè io le farei le condoglianze ad uno che ha studiato agraria, non per amore della terra ma per mero calcolo. Ma che ne posso sapere io, che faccio l’impiegata contabile, dopo la mia bellissima e commovente laurea in lettere.
L’ultima nota va all’editore: Intermezzi si conferma un unicum nel panorama editoriale italiano. La capacità di scegliere libri complessi, innovativi anche nella forma e la scelta di scommettere sul “vero” nuovo, dà una piacevole ventata di freschezza e porta la speranza che giovani scrittori capaci esistono. Forse servirebbe un pelino in più di editing.
Apprendere, insegnare, gestire: le sfide del “Manager didattico” e dell’uomo di ogni giorno
 Luigi Scarcelli
Luigi Scarcelli
PARMA – Il concetto di didattica viene oggi troppo spesso banalizzato e ricondotto dalla maggior parte di noi al sistema scolastico, ai suoi attuali e numerosi problemi di contenuti e sostenibilità economica, ai ricordi delle spesso (purtroppo) noiose ore passate da piccoli nelle aule a venir riempiti di nozioni.
In realtà essa abbraccia molti aspetti della nostra vita quotidiana. Didattica è teoria e pratica dell’in-segnare, cioè del tracciare un percorso, fatto di conoscenze e metodi, all’interno di chi apprendere. Si può capire quindi come questa attività abbia a che fare con molti aspetti della nostra vita: il lavoro, l’hobby della domenica, la vita famigliare, e più in generale i rapporti tra persone all’interno di sistemi sociali.
Manager Didattico, pubblicato da Editrice La Mandragora, è un libro che si rivolge non solo a chi opera nell’ambito didattico ma più in generale a chi, all’interno della propria attività, è impegnato nella gestione di risorse umane e strumentali.
Gli autori Guido Capraro e Fabio Portella lavorano da diversi anni nel settore della formazione e del management ed hanno sviluppato notevoli competenze, “riversate” nel libro di cui parliamo.
Il Manager didattico opera nell’ambito della formazione, gestendo e modellando risorse umane e strumentali al fine di raggiungere gli obiettivi didattici prefissati.
Egli opera all’interno di quattro ambiti: CONOSCERE, COMPRENDERE, COLLABORARE, COMUNICARE. Il libro è incentrato su queste quattro tematiche, sviluppando i concetti su una struttura da manuale, schematica chiara e completa anche se non esaustiva data la complessità della materia trattata.
Il libro è interessante in quanto tratta argomenti che vanno oltre la pura didattica: conoscere, comprendere, collaborare e comunicare sono quattro punti alla base del buon svolgimento di qualsiasi attività, partendo da quelle professionali arrivando fino ai rapporti interpersonali di ogni giorno. Per questo motivo è consigliabile ad un pubblico non solo di settore ma che sia interessato più in generale al “saper fare”.
“Ritorno al mondo nuovo” e il bisogno della libertà
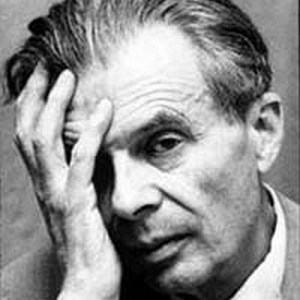 Dalila Sansone
Dalila Sansone
GRAZ – “Ritorno al mondo nuovo” è una riflessione sulla società incastrata a metà novecento, un’analisi in prospettiva alla luce di un pericoloso avanzare nelle direzione delle distopie di inizio secolo. Nel 1932 Aldous Huxley aveva scritto una favola futuristica, descritto un mondo in cui gli uomini nascono in provetta e il condizionamento riflesso è pratica educativa; dove l’ordine sociale è garantito dalla cancellazione del bisogno e dell’emozione. Non organizzazione ma trasformazione degli individui in organismo, entità unica in cui l’individualità corrompe e viene spinta all’autonegazione. Fratello maggiore meno noto di “1984” di Orwell, il “Mondo nuovo” appare molto più vicino alla realtà moderna. Tra il suo libro più famoso e questa raccolta di saggi passano il secondo conflitto mondiale, genocidi, eugenetica, propagande più o meno totalitarie, l’affermazione del consumo di massa: anno 1958. L’autore mette in evidenza l’inquietante parallelismo tra le dinamiche osservabili nella società contemporanea e la descrizione del suo mondo fantastico, una deriva apparentemente incontrollabile condizionata dall’eccesso di popolazione e dalla tendenza alla super-organizzazione, nella quale si affermano forze tutt’altro che occulte ma estremamente abili nell’utilizzare le conoscenze che derivano dal progresso della scienza nell’imprimere una qualsivoglia data direzione. Huxley dà prova, come consueto nella sua saggistica, di profonda conoscenza della scienza del tempo, cita esperimenti, studi, risultati e coincidenze tra prove di laboratorio e concretizzazioni storiche. L’effetto è quello di un documentario virato seppia, un passo più in là del bianco e nero ma ancora troppo precoce per la definizione dei colori. Huxley è una di quelle menti che ha visto sempre oltre la contemporaneità, di cui aveva imparato a leggere le sfumature e a prevedere ogni implicazione, soprattutto a coglierne dinamiche sottili, apparentemente innocue ma di ferocia inaudita. I poteri forti non si affermano permanentemente con la coercizione e la brutalità: il potere è assoluto solo quando capace di non farsi riconoscere come tale e mimetizzarsi in ordine naturale. L’individuo non si obbliga si educa.
La chiave di volta, esattamente come in natura, sta nella diversità, condicio sine qua non per l’affermazione della libertà. Libertà che è prima individuale poi collettiva: non esiste resistenza che non passi per il riconoscimento di principio della libertà individuale fondata su diversità e unicità. Ma la libertà deve anche essere conquista e difesa costante, incentrata sulla constatazione dei fatti e l’enunciazione di valori. La difesa dell’umanità dalle derive totalitarie dell’educazione (e del consumo) di massa non può che passare attraverso l’educazione (o contro educazione) individuale alla libertà a cui va riconosciuto il rango di valore supremo.
Non c’è spazio per le impressioni, ottimistiche o pessimistiche, conoscenza ed educazione individuale alla libertà equivalgono alla costruzione di spirito critico, l’unico a cui fare appello per osservare circostanze e fatti e trarne le dovute conseguenze. La storia insegna che la categoria dell’assolutismo di giudizio è fondamentalmente sbagliata ma anche che l’unica forza di opposizione alle derive assolutiste è l’osservazione critica. Chi crede nella libertà come valore supremo non si trincera dietro l’enunciazione di un diritto astratto ma rinnova costantemente le condizioni che ne rendendo effettivo il riconoscimento. Per necessità, per dovere e per istinto di sopravvivenza.
“Memorie dall’innocenza”, quando l’errore aveva un altro volto

ROMA – La parola memoria non ha un significato statico, perfettivo, come quello della parola “ricordo”. Avere memoria comporta un impegno, un coinvolgimento della persona. Comporta sentimenti, sensazioni, emozioni. Il ricordo è un’immagine fissa, una fotografia del passato, una tela dipinta e ormai incorniciata. La memoria è un quadro in fieri: tieni ancora in mano il pennello e stai ancora scegliendo i colori che comporranno l’immagine. Hai ancora qualcosa da dire, qualcosa da cancellare, qualcosa di cui pentirti e qualcosa da focalizzare. La memoria cambia.
Ed è la memoria la vera protagonista di questo breve romanzo di Serena Frediani, edito da Avagliano. “Memorie dall’innocenza” utilizza l’antico escamotage dell’amnesia post-traumatica, per scavare nell’inconscio dei protagonisti. Vittime di un incidente ferroviario, due persone che non hanno apparentemente nulla in comune, si trovano a ripercorrere la loro vita in un viaggio metaforico, che li porterà a rivalutare scelte e decisioni compiute in passati ormai lontani. Riemerge in loro un dimenticato bisogno di perdono, per quelle colpe sopite, nascoste sotto strati di altri ricordi. E se anche le loro storie sono molto diverse, il dolore sembra essere lo stesso.
Bellissimo lo stile narrativo della Frediani. Frasi sospese, tensione intrinseca ed emozioni. Le parole seguono il flusso dei pensieri, ma senza perdersi nelle divagazioni naturali della mente. Sempre focalizzata sulla trama, l’autrice riesce a trasmettere le paure e le incertezze dei suoi protagonisti.
Daria e Jean, due figure che vi ricorderete.
Un viaggio all’insegna della solidarietà
Silvia Notarangelo
ROMA – I motivi per intraprendere un viaggio sono tanti. Si può partire spinti dalla curiosità di conoscere luoghi e culture diverse, per puro divertimento, per fuggire o evadere dalla routine quotidiana. Tra le ragioni più nobili c’è, senza dubbio, il desiderio di aiutare chi ha più bisogno. Un’aspirazione condivisa anche da Mariella Carimini e Silvia Gottardi, due amiche inseparabili, unite dalla passione per i viaggi ma soprattutto dalla stessa sensibilità verso chi è meno fortunato.
“donne al volante TRANSAFRICA” (Polaris) è il resoconto dettagliato e appassionante della loro ultima avventura, un’avventura sostenuta e incoraggiata dalla Gazzetta dello Sport.
Quando, più di due anni fa, le ragazze si sono presentate al quotidiano rosa con un progetto tanto lodevole quanto ambizioso, il giornale di Andrea Monti ha creduto in loro, conquistato da un sincero entusiasmo e dalla voglia di misurarsi con una “missione impossibile”. Da allora, da quel primo incontro, le due amiche hanno portato in giro per il mondo il nome della Gazzetta e del suo indimenticabile direttore Candido Cannavò.
Nel 2011 è scoccata l’ora della seconda missione: un viaggio attraverso l’Africa, da Milano a Cape Town, per un totale di 16.000 km. Destinazione ultima, la Casa del Sorriso Cesvi di Philippi, una struttura dove sono accolte donne vittime di violenza e malate di AIDS. È a loro che Silvia e Mariella hanno donato il ricavato del viaggio.
Dopo una crociera di otto giorni per raggiungere l’Egitto, ecco che il 1° agosto la nave sbarca ad Alessandria: per la rosa Land Rover Discovery, prontamente ribattezzata Gazzamobile2, è il momento di iniziare la Transafrica. Come ogni viaggio che si rispetti, non sono mancati imprevisti, contrattempi, incomprensioni ma anche piacevoli sorprese. Le giornate, lunghe e faticose, sono state dense di incontri ma anche di occasioni per riflettere e confrontarsi con realtà molto diverse.
A completare questo piacevole volume un ricchissimo apparato fotografico e alcune utili schede di approfondimento con notizie, curiosità e suggerimenti per ognuno dei sette Paesi attraversati dall’instancabile Gazzamobile e dalle due inarrestabili amiche.
“Killerscoop”: il romanzo di Ferdinando Albertazzi
Alessia Sità
 ROMA – “L’intraprendenza contagiosa di Lara, la voglia di buttarsi di Greta, l’attendismo circospetto di Diego” sono solo alcune delle caratteristiche principali del trio di studenti, protagonisti di “Killerscoop”, l’intrigante romanzo di Ferdinando Albertazzi pubblicato da Edizioni Sonda, nella collana Giallo Noir.
ROMA – “L’intraprendenza contagiosa di Lara, la voglia di buttarsi di Greta, l’attendismo circospetto di Diego” sono solo alcune delle caratteristiche principali del trio di studenti, protagonisti di “Killerscoop”, l’intrigante romanzo di Ferdinando Albertazzi pubblicato da Edizioni Sonda, nella collana Giallo Noir.
Potrà sembrare strano, ma tutto ha inizio da una fine. Infatti, un brutto litigio, fra Stefano, Greta e Diego segna la fine della loro amicizia, dell’intesa e della complicità che per molto tempo aveva reso inossidabile il loro legame.
La vita però è ricca di imprevisti e inaspettatamente Diego e Greta si ritrovano travolti dall’arrivo di una nuova ragazza ‘acqua e sapone’: miss Lara. Ben presto, l’entusiasmo sfrenato della nuova arrivata travolge e contagia i due studenti, tanto da spingerli a intraprendere una vera e propria missione impossibile: una pericolosa intervista al famoso serial killer Salvatore. Il temibile e famoso assassino che uccideva ‘per salvare i ragazzi dall’omologazione’. L’uomo, rinchiuso ormai in un manicomio psichiatrico, è disposto a tutto pur di evadere.
Determinati a raggiungere il loro obiettivo, i tre studenti-detective si mettono subito a lavoro per riuscire a ottenere uno scoop assoluto da prima pagina.
Con uno stile semplice e lineare, Ferdinando Albertazzi regala ai giovani lettori un romanzo noir che li terrà col fiato sospeso fino all’ultima pagina.
Roberto Riccardi colpisce ancora: “Undercover”
 Giulia Siena
Giulia Siena
ROMA – “Il mio futuro è diverso. Dove porta la strada non lo so, ma è lì che vado. Da qualche parte c’è un altro me stesso che mi aspetta, per gettare alle ortiche questa tristezza.”
Undercover, sotto copertura. È questo il ruolo che Rocco Liguori si è cucito addosso da quando ha cominciato la sua carriera nell’Arma dei Carabinieri. La sua è una storia già scritta: figlio di un Carabiniere in una terra stremata dalla ‘ndrangheta, da piccolo tirava calci al pallone con i figli dei banditi, di fronte a quegli uomini più grandi della giustizia lui abbassava lo sguardo ma ora, da sbirro, vuole guardare in faccia chi dilania ogni giorno la sua terra e cambiare le cose. Per questo frequenta il corso di Undercover dove “niente è come sembra”, così come ha sentenziato il Regista il primo giorno di corso. Lui, il Regista, è Nicola Clemente, un undercover di razza che sarà fondamentale per la crescita professionale e le scelte di Rocco.
Da queste basi parte “Undercover” l’avvincente romanzo di Roberto Riccardi pubblicato nella collana Sabot/Age delle Edizioni E/O.
Con l’andare delle pagine gli anni passano e Rocco vuole darsi alla carriera militare e spogliarsi dei panni difficili dell’undercover fino a quando una telefonata non scompiglia nuovamente i suoi piani. La chiamata arriva da Vera Morandi, l’agente dagli occhi nocciola che Rocco non ha mai dimenticato. Allora Liguori deve tornare alla sezione antidroga per portare avanti un’indagine a livello internazionale, lo deve al suo passato e lo deve al futuro.
La trama delineata da Riccardi sembra nascere dal bisogno di “dire” e seguire naturalmente le intenzioni della collana in cui il volume è pubblicato: “noi siamo esausti della menzogna che ci opprime” come afferma Massimo Carlotto nel presentare la collana delle Edizioni E/0 di cui è curatore insieme a Colomba Rossi. Infatti, l’autore in “Undercover” dice, racconta con minuzia di particolari il lato oscuro dei traffici di droga e i rapporti della mafia internazionale.
Guarda QUI la videointervista a Roberto Riccardi, realizzata con iTVRome presso la Libreria Invito alla Lettura di Roma.
“Le braci”: la verità non risiedere in pochi fatti polverosi.
 Dalila Sansone
Dalila Sansone
GRAZ – Esistono scritture potenti: mani che imprimono alle parole sui fogli la plasticità delle emozioni, rendendo vive le passioni, quelle che ardono e mentre bruciano consumano ciò di cui si alimentano, eliminandone la fisicità ma non la forza. “Le braci” di Sándor Márai è esattamente questo, l’equivalente della scultura in letteratura, la tensione che cresce sulla corda di un arco teso fino all’istante prima di scoccare il tiro. È il racconto di una notte: un incontro atteso quarantuno anni, preparato per tutto quel tempo e il compimento di ogni attimo di vita vissuta fino a quel momento. Due amici di una volta che si ritrovano davanti al fuoco di un camino in una notte di fine estate, consapevoli di prendere parte all’ultimo atto di un duello da combattere, ciascuno con la propria esistenza, una resa dei conti che solo la presenza dell’altro rende concreta.
Cresce la narrazione, attraverso i pensieri del generale, dall’arrivo di una lettera alla partenza di Konrad all’alba del giorno successivo. I ricordi ricostruiscono il passato, un passato di fatti la cui consistenza si sgretola lentamente, inesorabilmente, nel rincorrersi di momenti cristallizzati nell’istante esatto in cui si sono compiuti e l’alternarsi di emozioni troppo fragili e inesperte quando sono rimaste ancorate alla mente, fissate per sempre. La sensazione è che siano stati loro, momenti ed emozioni, a vivere nel frattempo e non le esistenze che hanno scandito, modellandosi, acquisendo identità e potenza.
La ricerca della verità che cos’è? Le risposte hanno bisogno della formulazione di domande ma riuscirci, arrivare alla domanda, può richiedere il tempo di una vita e non ha presunzione di compimento. Diviene una sfumatura dell’esistenza che non ammette categorie fisiche, abolisce il tempo e permea l’essere. Le categorie, quelle categorie insufficienti che rispondono allo spazio e al tempo, vengono sostituite da una dimensione che vive una morte inesorabile nel silenzio, nella sua continua e inevitabile tensione verso lo scandire delle parole che la motivano: l’attesa. Attesa della verità, che non può risiedere in pochi fatti polverosi: conoscere i fatti non è abbastanza.
Le braci ardono a differenza delle ceneri. Nelle braci langue la forza delle fiamme che le ha generate. Quello che brucia vive e quando si consuma, prima di spegnersi, è pronto a riaccendersi e ardere d’intensità pari all’incendio di un tempo indefinito precedente. Basta il passaggio di un alito di vento.
Di fronte alle braci che riprendono vigore, consumando le risposte dei fatti che invece diventano cenere, dopo un’attesa durata più a lungo di quegli stessi fatti, non importa più cosa abbia scatenato la passione, da dove sia provenuta la prima scintilla, solo che lo abbia fatto. E la ricerca del senso si scopre il senso stesso.






