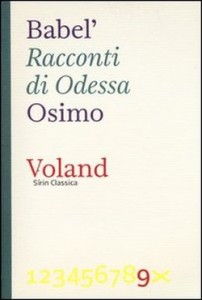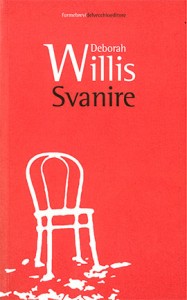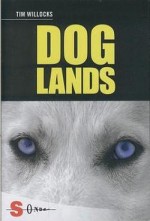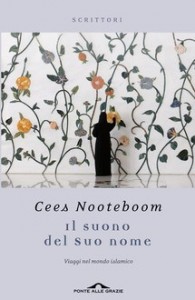ROMA – “Tutto era appartenuto all’esistenza e niente di più doveva essere scritto”. Eva, all’inizio di questo romanzo,voleva scrivere: voleva mettere su carta la vita, trovare una trama avvincente che convincesse un grande editore a pubblicarla. Eva aveva già una storia e per ascoltarla, seguirla e scriverla si trasferì a Sciacca dal Veneto. Questa era la terra di suo padre e di sua nonna Annina, era la terra in cui il suo estro poteva rinascere.
ROMA – “Tutto era appartenuto all’esistenza e niente di più doveva essere scritto”. Eva, all’inizio di questo romanzo,voleva scrivere: voleva mettere su carta la vita, trovare una trama avvincente che convincesse un grande editore a pubblicarla. Eva aveva già una storia e per ascoltarla, seguirla e scriverla si trasferì a Sciacca dal Veneto. Questa era la terra di suo padre e di sua nonna Annina, era la terra in cui il suo estro poteva rinascere.
Eva è la protagonista di “Immagina la gioia”, il secondo libro di Vittoria Coppola. Pubblicato da Lupo Editore, il nuovo lavoro della scrittrice salentina è un romanzo familiare ambientato negli anni Novanta.
Eva ha degli occhi profondi, le mani dipinte di rosso e vestiti colorati. Eva ha un rapporto difficile con suo fratello Pietro, ma più che difficile il loro è un affetto mai espresso; sarà perché dieci anni di differenza tra i due che durante l’adolescenza di Pietro e la giovinezza di Eva diventano un limite insormontabile. Sarà che Eva sta inseguendo il suo romanzo e Pietro il pallone; sarà che Eva è troppo presa dalla scrittura e dalla sua vita tra Sciacca e Mira. Ma la vita, improvvisamente, stravolge tutto.
A Sciacca Eva raccoglie i suoi fogli e cerca di portare avanti il suo romanzo, nel frattempo fa la cameriera nel bistrot di Oliver. A Mira, dove dalla Sicilia suo padre Raffaele si trasferì anni prima per lavoro insieme a tutta la famiglia, Pietro arranca dietro al suo pallone. Il ragazzo ha qualcosa che non va, è il suo ginocchio.
La scrittura dell’autrice ci accompagna in questa storia ma vorremmo sapere più su quei luoghi: vorremmo poterci aggirare con Eva tra le strade di Sciacca, lasciarci trasportare nella tranquillità delle villette di Mira. Vorremmo, da lettori, che la forte capacità della Coppola di descrivere le emozioni si impossessasse anche dei luoghi.