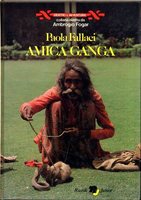 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – La collana “Dentro l’avventura” diretta da Ambrogio Fogar per Rizzoli Junior aveva una caratteristica, sottolineata anche in quarta di copertina: “Questa collana nasce esperta, perché esperti sono i suoi autori. Chi scrive un libro di ‘Dentro l’avventura’ ha una caratteristica comune con gli altri autori della collana: è stato protagonista, almeno in parte, di quanto racconta”. Paola Fallaci è stata veramente in India, in particolare nella città di Benares – oggi chiamata Varanasi – per cogliere veramente la magia di quel luogo, così tanto di moda negli anni Settanta del secolo scorso.
E ha cercato di raccontarla ai lettori più giovani in questa avventura intitolata Amica Ganga (1980), in cui un ragazzino italiano, Antonio, che segue la madre in India alla ricerca del fratello maggiore scomparso, si trova al centro di un’avventura inconsapevole, durante la quale, accompagnato passo passo da una splendida ragazza che si fa chiamare Ganga, incontrerà e scoprirà tanti luoghi e tante fascinazioni di questa città santa, costruita rivolta ad est, sulla linea divina del fiume Gange. Continua
Categoria: Letture vintage
“La sepolta viva”: storia della Cenerentola della letteratura italiana
 Luca Vaudagnotto
Luca Vaudagnotto
AOSTA – Ci sono molte ragioni per leggere La sepolta viva, di Francesco Mastriani, edito con coraggio da Rogas Edizioni: si tratta, infatti, della ripubblicazione di un romanzo d’intrattenimento datato 1889 e tradotto in linguaggio cinematografico nel 1948 dal regista Guido Brignone.
“Ah! Che bell’italiano!”, è il primo pensiero del lettore, appena terminate due pagine del libro: si rimane increduli e stupiti dalla qualità della lingua impiegata da Mastriani, pur rivolgendosi a un pubblico vasto ed eterogeneo, dalle espressioni ricche e dal lessico a tratti addirittura aulico (l’uso di verbi come “palesarsi”, o di vocaboli come “il sembiante”, “rivendugliolo” o ancora espressioni come “mettere a parte qualcuno”): sembra, talvolta, di scorrere un libretto d’opera; ma a guardar bene, è ancor più sorprendente trovare in queste pagine espressioni che ci appaiono estremamente contemporanee (“il cuore schiantato” o “gettar luce” su un fatto poco chiaro). Continua
Un frammento di Stratone riesumato dal passato
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Ogni uomo è tutti gli uomini Edizioni, dal 2005, propone al pubblico testi “dimenticati o poco valorizzati” della letteratura, proponendo anche “testi inediti di autori famosi o completamente sconosciuti”. Recentemente è uscita un’edizione di Frammento apocrifo di Stratone di Lampsaco di Giacomo Leopardi, con la prefazione di Giuliano Toraldo di Francia; un’opera considerata minore del grande poeta, ma che invece ci permette di gettare uno sguardo lungo e profondo sulla sua poetica e la sua concezione del mondo.
L’espediente del ritrovamento di un frammento greco dai monaci del monte Athos, attribuito a Stratone da Lampsaco, permette a Leopardi di discettare su idee che gli appartengono ma che sarebbe stato troppo audace spacciare direttamente come sue. Continua
Oroonoko, il nobile schiavo della letteratura inglese
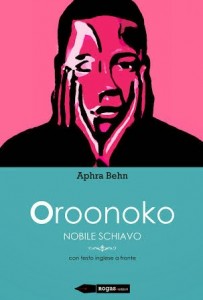 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Aphra Behn è una scrittrice che in ben pochi, se non amanti e cultori della letteratura inglese, conosceranno. Assente dalle librerie dei più, anche perché i suoi libri difficilmente reperibili. Fino ad oggi, quando la coraggiosa casa editrice Rogas Edizioni, nata “come ‘sorella minore’ (ma solo per età…) della libreria Marcovaldo (come recita il sito stesso), ha deciso di ripubblicare, in un’edizione con testo a fronte (tradotto da Adalgisa Marrocco), il suo romanzo più significativo: Oroonoko, nobile schiavo, edito nella prima edizione nel 1688. La collana inaugurata è “Darcy”, dedicata a capolavori della letteratura inglese “(non) dimenticati, fino a ieri introvabili”.
Aphra Behn, definita da Virginia Woolf la prima scrittrice inglese professionista (perché visse con la sua attività di poeta, scrittrice e drammaturga), ha avuto una vita che potrebbe parere un vero e proprio romanzo, anche per via delle poche notizie certe che se ne hanno. Probabilmente nel 1663, quando lei aveva circa 23 anni, la famiglia si trasferì nella Guyana olandese, dove rimase per circa un anno. Questa esperienza fornì la base e il materiale per il romanzo che l’ha resa celebre ed è considerato il suo capolavoro, “Oroonoko”. Il romanzo, il cui sottotitolo originario recitava “A true history”, racconta la storia di un principe, nipote di un sovrano africano, e Imoinda, stupenda donna figlia di un valoroso condottiero. L’amore dei due giovani viene ostacolato dal nonno dell’impavido principe, che sposa con l’inganno la giovane. A questo punto, i due si ribellano, finendo schiavi e trovando, dopo una serie di sfortunate peripezie, una morte gloriosa.
Il romanzo, che si fonda sull’affermarsi un esotismo che in quegli anni cominciava a prendere forma e sostanza letteraria, pur se breve, è denso di elementi significati, anche legati alla società del tempo, non ultimo lo schiavismo e il significato che aveva per gli europei; atteggiamento legato anche alla religione e alla sua diffusione tra gli “indigeni”, che Aphra Behn descrive con occhio benevolo ma persino un po’ compatente. Sicuramente, splendida è la descrizione di questa terra lontana, il Suriname, di cui la Behn ne aveva saputo cogliere il potenziale, a differenza della Corona inglese, che la cedette all’Olanda. La scrittura della Behn è deliziosa, ben calibrata, essenziale nel dire, senza superfluo. I personaggi, in particolare Oroonoko, dai tratti eroici e fortemente tragici, sono quasi sculture antiche, perfette nella loro statuaria comportamentale e caratteriale, che parlano con un’eloquenza tipica dei grandi condottieri antichi, tutti calati in questo “nuovo mondo” che, in quella lontana fine di ‘600, faceva sognare e fantasticare senza limiti.
Scrittrici e scritti dimenticati: i “Romanzi del cambiamento” raccolti da Angela Scarparo
 Giulia Siena
Giulia Siena
PARMA – “L’impressione che io ho è che questi libri siano stati scritti, non per supportare un ruolo già acquisito, o per crearselo, ma viceversa, per l’urgenza di affermare delle verità. Del fatto che la verità non può essere tale, se non è prima di tutto personale, credo che ognuna di loro fosse ben conscia”. Angela Scarparo descrive così, nell’introduzione del suo libro, Romanzi del cambiamento. Scrittrici dal 1950 al 1980, quello che è stato il lavoro di recupero e analisi di quattordici testi di altrettante autrici del Novecento. Il libro, pubblicato da Avagliano editore con la prefazione di Daniela Marcheschi, raccoglie, infatti, stralci di romanzi simbolo della scrittura femminile dei passati decenni chiusi nel dimenticatoio dalle esigenze editoriali moderne. Con Romanzi del cambiamento, la Scarparo – autrice attenta alla letteratura e alle tematiche inerenti la donna – mette in moto, così, un lavoro di recupero e comparazione di libri e romanzi che per un trentennio, dal 1950 al 1980, fecero parte della vita culturale italiana, con ruoli e risonanze diverse. Da Angela Bianchini a Clotilde Marghieri, da Luce d’Eramo a Ginevra Bompiani, da Marilena Ponis a Giuliana Ferri passando per Fausta Cialente, Letizia Fortini, Bianca Garufi e Flora Volpini, arrivando a Maria Teresa Nessi, Sandra von Glasersfeld o Mary de Rachewiltz, le autrici in questione sono osservatrici attente e sensibili dei cambiamenti e delle evoluzioni in atto. Raccontano la vita e lo fanno ognuna con i proprio occhi, accomunate, però, da uno sguardo lucido sul mondo, da una scrittura senza fronzoli, “in cui la parola e la cosa divengono semplicemente stile, – come scrive Daniela Marcheschi nella sua prefazione al libro – cioè la “cosa detta” nella sua plastica evidenza, tesa a raccontare appunto le “cose naturale” che accadono agli esseri umani”. Di questi cambiamenti loro si fanno carico, ne raccontano e si lasciano coinvolgere, partecipi delle grandi trasformazioni giuridiche sul ruolo della donna e sui diritti della famiglia, ma sempre un po’ ai margini del fermento intellettuale di questi anni. Attraverso gli scritti, i racconti, le pagine raccolte dalla Scarparo, vediamo infatti come le scrittrici protagoniste di questo libro – a differenza dei loro colleghi uomini – in questi anni si siano, volutamente, tenute fuori dai canoni prevalenti del periodo.
Le donne sono state escluse dalla grande letteratura, forse – sicuramente a torto – perché i romanzi scritti da donne erano spesso catalogati come libri “femminili”. Se da una parte questa esclusione ha contribuito alla perdita di attrattiva per le case editrici di molte delle autrici del secolo passato, dall’altra ha fatto sì che le autrici del secondo Novecento si sentissero fuori dalle accademie, dai circoli, dai salotti e dalle comunità letterarie, tanto da andare quasi fuori dagli schemi e sentirsi libere di toccare tematiche differenti, libere di narrare ciò che più stava loro a cuore. E tutto questo fa grande e prezioso Romanzi del cambiamento, un volume che raccoglie e analizza gli scritti di quattordici importanti scrittrici del Novecento arricchendo la memoria della letteratura moderna. Perché questa è l’editoria che serve, quella che ci fa capire che non dobbiamo smettere di leggere, di capire e di cercare le pagine della cultura italiana erroneamente messe nel dimenticatoio.
Qui potete vedere l’intervista ad Angela Scarparo e Daniela Marcheschi realizzata a Più Libri Più Liberi 2014 da ChronicaLibri. (Dal minuto 7.00)
È il tempo della congiura, “Quando Marte è in Capricorno”.
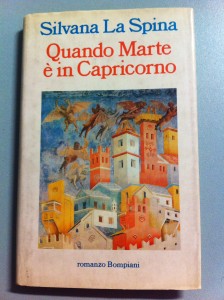 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – “Quando Marte è in Capricorno” è il tempo della congiura. Come quella di cui narra Silvana La Spina nel romanzo edito da Bompiani nel 1994. Ai danni di Federico II di Svevia. La congiura si fa spazio subdolamente nei rapporti tra persone, percorre fredde stanze, valica improbabili e fragili confini e si semina distrattamente per dare grossi frutti. E con la congiura accade un passaggio, una transizione da epoca a epoca che condiziona una società e ne modifica alla base i meccanismi e i rapporti.
Il punto di vista del romanzo è quello di un vecchissimo Jacopo da Lentini, l’inventore del sonetto, la cui vocazione poetica è da lui stesso considerata timidamente come una pausa rispetto alla sua attività (modesta) di notaro. Rinchiuso, quasi in fuga dal mondo, in un’abbazia benedettina della Sicilia, trascorre il proprio tempo nell’affannoso compito di sistemare la sua attività poetica, il suo splendido “Canzoniere”. Alla notizia della morte di Pier delle Vigne, il consigliere più amato da Federico, accusato di alto tradimento, si spalanca la memoria del notaro e l’imperativo più impellente, quello a cui non ci si può sottrarre, è la stesura di una storia, da lasciare in eredità al figlio, su come sia andata effettivamente la storia; tanto pressante da dimenticarsi delle proprie poesie.
Silvana La Spina edifica una narrazione che travalica la storia, creando una realtà più concreta dei semplici fatti storici, dei semplici avvenimenti da calendario. Solo ipotesi, quelle elaborate da Silvana, ma che assumono la potenza di una verità incontestabile, perché animate da una forza narrativa destabilizzante, tellurica. I legami umani, quelli di amore e di amicizia, sono l’origine di un complesso tessuto, di una rappresentazione che richiama quelle del “pittore di battaglie” di Arturo Pérez-Reverte: un affresco unico, un ciclo continuo di vicende e accadimenti che si rincorrono e nessuno è casuale né vano, ma tutti incatenati e incastrati armonicamente per la realizzazione di un disegno superiore. Ma l’importanza della storica fa un passo indietro di fronte alla monumentale narrazione dell’interiorità di quelle stesse persone che, in altri libri, paiono persino svuotate della loro umanità, per diventare eminentemente pedine di uno schema politico e militare.
In “Quando Marte è in Capricorno” Silvana La Spina non avanza pretese di nessun tipo. Soltanto, si concede il beneficio del dubbio di avere più ragione di chi la storia la teorizza e basta. Utilizzando uno strumento ulteriore, quello dell’italiano. Nel romanzo, la lingua è raffinata poesie: un’attenzione puntuale ma non ostentata verso il lessico. Una scelta preziosa di parole e suoni, di significati e significanti, rendono la lettura di queste pagine un piacere anche musicale ed emotivo.
Il trentesimo anno e un albero da piantare.
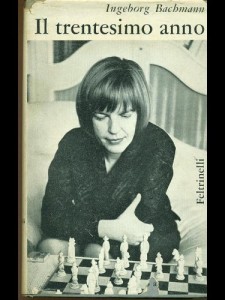 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – I trent’anni possono essere un momento cruciale, nella vita. Un passaggio che forse può significare la necessità di tracciare i primi bilanci, di gettare uno sguardo sulla strada percorsa e valutarla. Ingeborg Bachmann, una delle più interessanti scrittrici della letteratura del Novecento, ha esplorato l’approdo al trentesimo anno in un racconto lungo di inaudita potenza e profondità. “Il trentesimo anno” (Das dreißigste Jahr) uscì nel 1961, in una raccolta di racconti a cui dette il titolo complessivo. Fortemente autobiografico, vinse tanti premi internazionali e consacrò la scrittrice austriaca.
Nel racconto, il punto di vista è quello di un uomo che si trova a fare i conti con l’arrivo di un’età anagrafica che lo spaventa e lo atterrisce. Si sveglia, alla luce del nuovo giorno, consapevole che qualcosa sta cambiando. Prima “s’immaginava di avere innumerevoli possibilità e credeva, per esempio, di poter diventare qualsiasi cosa”. Pensava che il tempo potesse non finire mai ma andare sempre avanti e avanti. Poi la trappola comincia a stringerglisi addosso, intorno, piano piano. “Non gli basta partire per un viaggio, deve proprio andarsene. In quell’anno deve sentirsi libero, lasciare tutto, cambiare luogo, abitazione e persone”. L’irrequietudine diventa un imperativo morale, un bisogno intenso e potente. Spostarsi, cambiare per cercare di acquietarsi, di scongiurare la crisi.
L’anno procede, le stagioni si alternano in una progressione incalzante e soffocante. E la sua percezione del mondo cambia: “Cercò un dovere da compiere, voleva rendersi utile. Piantare un albero. Generare un figlio”. Assieme a scrivere un libro, le tre cose che anche Garcia Lorca, secondo tradizione, indica come indispensabili per dare un senso alla vita. E proprio il senso della vita il protagonista trentenne ricerca, in questo racconto della Bachmann che è insieme analisi e valutazione, esame e verdetto, ricerca e soluzione. Un precipitare, con una lingua elegante e misurata, in un vortice del pensiero che trasforma l’irrequietudine del movimento in agitazione del pensiero. Però, “come tutti gli esseri umani non arriva a nessuna conclusione”. Destino comune di chiunque cerchi di arrabattarsi con pensieri, meccanismi, derive e approdi troppo complessi e complicati, per l’intelligenza di un singolo. Ma arriva l’incidente; l’imprevisto che crea una rottura nell’evolversi della situazione: un incidente automobilistico lo costringe a letto, ferito e spaccato, con tutte le ossa rotte. Ma proprio allora, tornando a vivere dopo la distratta morte, ha la rivelazione, contemplando un capello bianco che si ostenta nella specchio: “Finalmente si disse: ma io vivo e quel che desidero è vivere ancora a lungo. […] Ma io vivo! Presto sarà guarito. Presto compirà trent’anni. […] Ti dico: alzati e cammina! Non hai un solo osso rotto”. I trent’anni, alla fine, possono essere un momento di riflessione, di paura, di bilanci e di attese. Ma forse nemmeno.
“Il compleanno dell’Infanta”, Oscar Wilde e la sua favola
 Giulia Siena
Giulia Siena
PARMA – Il posto delle favole è un posto silenzioso e segreto. Un posto di cui la realtà è curiosa e lontana. Il posto delle favole è altrove: fuori dal tempo, lontano dalle logiche e dalle risposte. In questo tempo, lontano e misterioso, Oscar Wilde ambientò uno dei suoi componimenti più belli e poco conosciuti, Il compleanno dell’Infanta (Einaudi Ragazzi, 2003).
Il giorno del dodicesimo compleanno dell’infanta di Spagna è tutto un gran agitarsi: la festa, a corte, è una delle più belle di sempre nonostante l’infanta compia gli anni ogni anno, come un qualsiasi bambino povero. Ma si sa, la giovane erede può avere più di chiunque altro, può avere tutto: un vestito splendido, amiche da invitare a palazzo, giocolieri, leccornie e l’affetto di suo padre. Per quel giorno può avere anche la presenza di un povero Nano trovato nelle foreste e portato a corte per allietare la festa. Lui, il Nano buffo, entrato nell’arena barcollando, agitando il suo testone arruffato, scatenò l’ilarità dell’infanta e dei suoi ospiti. Rise anche lui, del tutto inconsapevole del suo aspetto grottesco. Rise e fece ridere danzando per la piccola regina e per la sua corte. Sì divertì, il piccolo Nano, e gioì: la sua gioia fu accentuata da un fiore datogli in dono dalla stessa festeggiata. A quel punto il suo cuore esultò e si riempì d’amore. Capì che la sua danza, il suo dimenarsi, era quasi un gioioso movimento di conquista e quel fiore era la dimostrazione dell’amore dell’infanta per lui. Alla corte di Spagna, però, dove il Nano era solamente un giullare, non c’era spazio per la sensibilità e l’affetto; avere un cuore, per il Nano, fu un grande difetto.
Dagli 8 anni e per sempre.
“In futuro – ordinò – quelli che saranno condotti a palazzo per il mio divertimento non dovranno avere un cuore!”
Il mito di Pia da Dante a Gianna Nannini e Pia Pera.
 Giulio Gasperini
Giulio Gasperini
AOSTA – Sono solamente sette i versi, gli ultimi del canto V del Purgatorio, con i quali Dante ci consegna una delle figure più enigmatiche e solitarie della sua cantata umanità. Una donna aggiunge, quasi timida, la sua voce a due imponenti figure maschili, e ci affida un suggerimento, niente più d’un sospetto della sua esistenza. La scenografia è l’Antipurgatorio, le anime sono quelle di morti di morte violenta. Di fronte ai resoconti sanguinari e sanguinosi di due uomini, la Pia, come un puro giglio, ci parla di sé e del suo destino con un pudore e una reticenza da lasciarci quasi increduli, tristi, impotenti. È lei stessa a proiettarci un’agghiacciante ombra sulla sua fine: “Siena mi fé, disfecemi Maremma: / Salsi colui che ‘nnanellata pria / disposando m’avea con la sua gemma.”; Pia, dunque, sembra suggerirci che a ucciderla sia stato proprio il marito. E qui finisce la sua confessione. Con un’ulteriore richiesta, struggente nella sua umanità: che Dante la ricordi, una volta tornato sulla Terra dei vivi. Non vuole essere dimenticata, consegnata all’oblio, dopo che la sua vita è stata così precocemente strappata alla vita vissuta. Pia, anche da anima, compie il peccato più umano che possa esistere: richiede l’eternità, valicando lo spirito e il corpo, il pudore e il dolore: “Ricorditi di me, che son la Pia”. Dante rappresenta l’ultima sua sopravvivenza tra i vivi. E il poeta acconsente; la ricorda in maniera così fuggente e vaga da aver alimentato la leggenda.
E Gianna Nannini se n’è impossessata, a distanza di otto secoli, e ne ha fatto un’opera rock, uscita nel 2008, “Pia come la canto io”, dove si vive la sua leggenda. Pia de’ Tolomei, ricca nobildonna senese, era sposa di Nello de’ Pannocchieschi, ricco possidente della Maremma. Mentre egli è in guerra, il suo migliore amico, Ghino, tenta di corteggiare Pia, senza però ottenerne i favori; così Ghino, volendosi vendicare, racconta a Nello, tornato dalla guerra, che Pia, in sua assenza, lo tradiva. Nello allora, credendo all’amico, fa rinchiudere la moglie in un castello della Maremma: il Castel di Pietra, nel comune di Gavorrano. Pia qui si strugge per l’ingiustizia subita e contrae la malaria, morendo sola e abbandonata. Questa è la storia che, spogliata dei connotati più marcatamente storici, ci viene riproposta oggi da Gianna Nannini, dopo un lunghissimo lavoro durato sette anni, condotto insieme a Pia Pera, autrice di tutti i testi dell’opera: testi forti e dolci, aspri come la gelosia e terribili come la pandemia che incombe tra le anime della Maremma.
La forza musicale è quella tipica della rocker toscana, la leggenda le scorre nelle vene fin dall’infanzia, e deflagra, in queste musiche e melodie che scavano a fondo nell’anima, nel cuore, proponendoci un dramma, una sofferenza, un agitarsi di quei sentimenti e di quelle emozioni talmente umane da essere immutabili nonostante il trascorrere del tempo. Il sogno più grande dell’uomo è sempre concedersi l’eternità, Gianna ce ne racconta un frammento. Con quella solita poesia e genuinità che da sempre la contraddistinguono. I testi, invece, grazie al lavoro di Pia Pera, sono testi altamente poetici, che uniscono suggestioni antiche, medievali a valenze e sapori moderni, contemporanei. Un duro plurilinguismo, con accenni anche al triviale, che richiama la maniera di scriver dantesca, che mai, neanche nel Paradiso, fu timoroso nell’utilizzare parole piuttosto licenziose e furiose.
“I sensi lunghi”, le vite liquide che scivolano nell’acqua.
 Luca Vaudagnotto
Luca Vaudagnotto
AOSTA – Non si legge Carlo Villa per caso, tanto meno “I sensi lunghi”, che nella produzione dello scrittore e poeta romano rappresentano un’opera degli esordi (Einaudi Coralli, 1970). Eppure questo lavoro, che si colloca a metà strada tra un romanzo breve e un racconto lungo, già dal titolo affascina e ammorba il lettore che lo prende in mano e lo sfoglia, in modo particolare nella sua edizione originale, con una curatissima veste grafica ed editoriale.
“I sensi lunghi” è la storia, in forma di soliloquio, di un uomo ordinario, sposato e con una figlia, che a un certo punto della sua vita abbandona il lavoro e si rinchiude in casa, nel bagno, e, attraverso le tubature, ascolta e spia la vita dei condomini, in particolare di Claudia, della quale apparentemente si innamora. È un romanzo dell’ermetismo, dove l’esistenza del protagonista si richiude su sé stessa, si disgrega in tutte le sue funzioni sociali, a partire dal linguaggio, che per il nostro anti-eroe altro non è che un ammasso di «segni divenuti misteriosi e inintelligibili». E nasce uno stridente contrasto tra questa rinuncia alla verbalità del protagonista e la scrittura del suo inventore: l’italiano di Villa è una lingua difficile, estranea ai più, ermetica anch’essa ma per la sua complessità e per l’uso ardito che l’autore ne fa, che oscilla tra tecnicismi propri dell’ingegneria idraulica e picchi altissimi di poesia.
Non bisogna, tuttavia, cadere nel facile errore di considerare il protagonista alla stregua di un epigono di quei personaggi inetti a vivere, disadattati, tanto cari alla letteratura d’inizio secolo. Il nostro è un uomo che decide, consapevole, di allontanarsi dal mondo («pratico la vita per mezzo di una fuga da essa»), ma che parallelamente viola le chiusure degli altri, l’altrui intimità, raggiungendo in alcuni momenti lucidi deliri di onnipotenza («Il burattino oscilla […] ma i fili sono io che li tengo», dice, in riferimento a Claudia).
L’altra grande protagonista, di cui tutto il romanzo è intriso è l’acqua: i sensi del protagonista si allungano proprio grazie a questo medium fluido, e le parole e i verbi dell’acqua sono disseminati sapientemente da Villa in tutto il romanzo, cosicché l’elemento liquido si manifesta in tutte le sue forme e in tutti i movimenti che gli sono permessi. In questo senso, l’acqua è ascoltata, toccata, ci si immerge, è bevuta, è raccolta in speciali contenitori, è annusata. L’acqua, insomma, come sostituto d’ogni altra socialità, quel rapporto con l’altro che, oggi come allora, è segno distintivo dell’uomo, ma le cui derive diventano inferni da cui fuggire.





